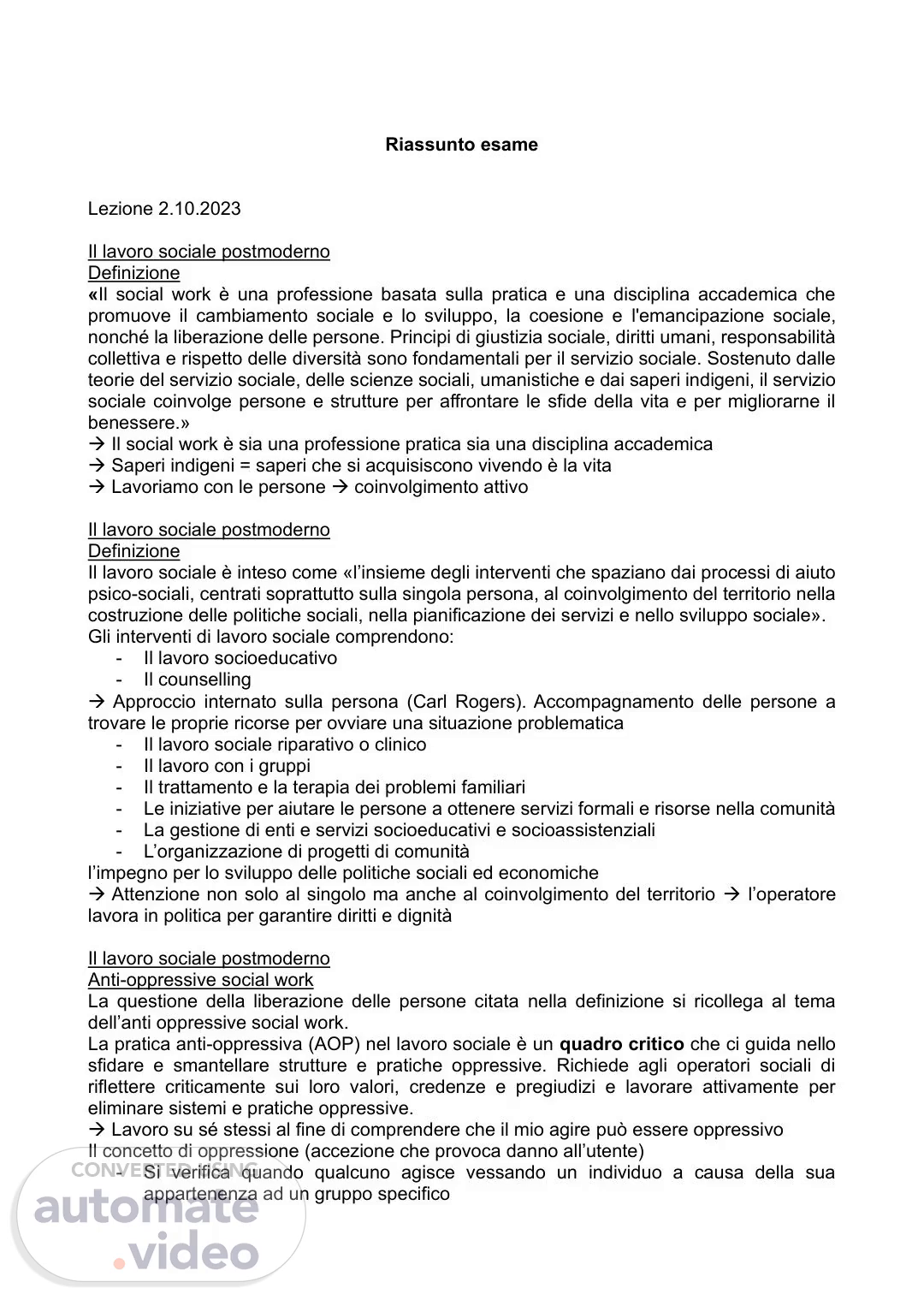Scene 1 (0s)
Riassunto esame Lezione 2.10.2023 Il lavoro sociale postmoderno Definizione «Il social work è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere.» → Il social work è sia una professione pratica sia una disciplina accademica → Saperi indigeni = saperi che si acquisiscono vivendo è la vita → Lavoriamo con le persone → coinvolgimento attivo Il lavoro sociale postmoderno Definizione Il lavoro sociale è inteso come «l’insieme degli interventi che spaziano dai processi di aiuto psico-sociali, centrati soprattutto sulla singola persona, al coinvolgimento del territorio nella costruzione delle politiche sociali, nella pianificazione dei servizi e nello sviluppo sociale». Gli interventi di lavoro sociale comprendono: - Il lavoro socioeducativo - Il counselling → Approccio internato sulla persona (Carl Rogers). Accompagnamento delle persone a trovare le proprie ricorse per ovviare una situazione problematica - Il lavoro sociale riparativo o clinico - Il lavoro con i gruppi - Il trattamento e la terapia dei problemi familiari - Le iniziative per aiutare le persone a ottenere servizi formali e risorse nella comunità - La gestione di enti e servizi socioeducativi e socioassistenziali - L’organizzazione di progetti di comunità l’impegno per lo sviluppo delle politiche sociali ed economiche → Attenzione non solo al singolo ma anche al coinvolgimento del territorio → l’operatore lavora in politica per garantire diritti e dignità Il lavoro sociale postmoderno Anti-oppressive social work La questione della liberazione delle persone citata nella definizione si ricollega al tema dell’anti oppressive social work. La pratica anti-oppressiva (AOP) nel lavoro sociale è un quadro critico che ci guida nello sfidare e smantellare strutture e pratiche oppressive. Richiede agli operatori sociali di riflettere criticamente sui loro valori, credenze e pregiudizi e lavorare attivamente per eliminare sistemi e pratiche oppressive. → Lavoro su sé stessi al fine di comprendere che il mio agire può essere oppressivo Il concetto di oppressione (accezione che provoca danno all’utente) - Si verifica quando qualcuno agisce vessando un individuo a causa della sua appartenenza ad un gruppo specifico.
Scene 2 (1m 5s)
→ Comportamento sfavorevole. Es: escludo qualcuno perché nero - Concetto “socialmente costruito, multidimensionale e fluido” - Origine interna/esterna e Intensità variabile Il lavoro sociale postmoderno Anti-oppressive social work → L’oppressione riguarda: Il lavoro sociale postmoderno Anti-oppressive social work 5 cose che i futuri operatori sociali dovrebbero sapere sul lavoro sociale anti-oppressivo 1. L'oppressione è pervasiva L'oppressione esiste in tutti gli aspetti della società, anche all'interno della pratica del lavoro sociale. Gli operatori sociali riconoscono e comprendono come l'oppressione opera e colpisce i loro clienti (utenti), colleghi e comunità. 2. L'intersezionalità è importante Le persone hanno molteplici identità che si intersecano che modellano le loro esperienze di oppressione e privilegio. Gli operatori sociali considerano come le diverse forme di oppressione, come il razzismo, il sessismo, l'abilismo e l'eterosessismo, si intersecano e si compongono per creare esperienze uniche di emarginazione. 3. L'autoriflessione è fondamentale Gli operatori sociali auto-riflettono continuamente per identificare e sfidare i loro pregiudizi, supposizioni e privilegi. Sono disposti a esaminare come le loro identità ed esperienze modellano la loro visione del mondo e come interagiscono con i clienti (utenti). 4. L'empowerment/capacitazione è fondamentale Il lavoro sociale anti-oppressivo mira a potenziare le persone riconoscendo e costruendo sui loro punti di forza, abilità e conoscenze. Gli operatori sociali collaborano con le persone per identificare i loro obiettivi e supportarli nel difendere sé stessi e le loro comunità. 5. L'attivismo è necessario Il lavoro sociale anti-oppressivo comporta la sfida e il cambiamento di strutture e pratiche oppressive all'interno e all'esterno della professione di lavoro sociale. Gli operatori si impegnano nell'attivismo e nella difesa per creare cambiamenti sociali e promuovere l'equità e la giustizia per le comunità emarginate. Il lavoro sociale postmoderno Anti-oppressive social work La questione del potere → dimensione micro Gli operatori sociali detengono un potere enorme connesso al loro ruolo professionale. A volte riproduciamo inconsapevolmente o consapevolmente forme implicite o esplicite di oppressione. Sakamoto e Pitner (2005) affrontano il concetto della coscienza critica «che sfida gli operatorie sociali ad essere consapevoli dei differenziali di potere e di come questi differenziali possano inavvertitamente rendere la pratica del lavoro sociale un'esperienza oppressiva».
Scene 3 (2m 10s)
→ Es: assistente sociale fissa un appuntamento con un utente donna con figli alle 8:00 consapevole che vive lontano dallo studio. La donna arriva in ritardo accompagnata dai figli. L’assistente la sgrida = oppressione nella relazione d’aiuto L’operatore sociale lavora con L’operatore sociale professionale lavora con persone di diverse età, gruppi di persone e comunità, tenendo in considerazione la complessità dei sistemi in cui sono inseriti (gli utenti), in relazione alle proprie finalità professionali, alle normative e regolamenti del proprio contesto sociale e istituzionale di riferimento, nel rispetto della deontologia professionale, collaborando con la propria équipe, con la rete di professionisti e di persone significative (per l’utente) per l’elaborazione e l’attuazione di progetti di intervento professionale L’ operatore sociale postmoderno Negli approcci postmoderni l’operatore sociale è una figura professionale incerta, non facilmente definibile, in quanto opera nella complessità delle realtà sociali e umane, continuamente in trasformazione, affrontando innumerevoli aspetti e dimensioni della vita quotidiana delle persone e dei sistemi in cui sono inserite. La sua debolezza strutturale la rende: una figura professionale “liquida” (Bauman), connotata da una flessibilità (= adattarsi alle varie situazioni) indispensabile per ricercare soluzioni funzionali nella complessità. L’operatore sociale lavora con Complessità dei sistemi → importante per esame!!!! Le persone, i gruppi, le comunità e i contesti in cui sono inseriti sono sistemi complessi, ossia insiemi di elementi in costante relazione reciproca, in continua trasformazione, data dall’influenza che ogni elemento ha e produce sugli altri, alla continua ricerca di un equilibrio. I sistemi complessi sono regolati da una causalità circolare: non è possibile risalire alle cause di un comportamento o di un fenomeno, né prevedere con certezza comportamenti o fenomeni futuri. → no causa – effetto L’operatore sociale lavora con L’operatore sociale lavora con complessità di sistemi: - Casualità lineare (determinismo) → cause – effetto - Casualità circolare (teorie sistemiche) → ogni elemento influenza e viene influenzato. La casualità circolare è una caratteristica della complessità Quindi negli organismi viventi non ha senso attribuire un fenomeno ad un’unica causa o ad una serie lineare di eventi L’operatore sociale lavora con Persone - Individui nella loro globalità (dimensioni fisica, cognitiva, affettiva, relazionale- sociale, creativa e spirituale = complessità della persona) unicità (ogni persona è un meraviglioso universo misterioso, non scomponibile, portatore di diritti e di differenze, non svelabile ed imprevedibile) in continua evoluzione e cambiamento, - Inserite in un contesto (fisico, relazionale, culturale, e ambientale), in continua trasformazione, - Individui con diritti, potenzialità, bisogni, aspirazioni, risorse e limiti, - Co-costruttori del proprio destino, protagonisti e attori del cambiamento, sia nelle trasformazioni emancipative che nelle cristallizzazioni di situazioni di difficoltà e disagio → tirare fuori le risorse dell’individuo.
Scene 4 (3m 15s)
Versus Visione deterministica e diagnostica di essere umano (= la persona non è la sua diagnosi) → Se considero la persona una vittima non gli permetto di migliorare e di cambiare L’operatore sociale lavora con Persone Modello multidimensionale bioecologico dello sviluppo umano (= chiave di lettura della complessità) - Teoria formulata da Urie Bronfenbrenner (1917-2015) per favorire la comprensione delle interrelazioni dinamiche tra i vari fattori personali e ambientali che influenzano lo sviluppo umano. → - Per comprendere lo sviluppo umano, bisogna prendere in considerazione sia gli aspetti biologici e genetici dell’individuo, sia l’intero sistema ecologico in cui la crescita si verifica (i contesti). → - Gli esseri umani si sviluppano secondo il loro ambiente di appartenenza: questo include la società ed il periodo storico nei quali la persona vive L’operatore sociale lavora con Persone Modello multidimensionale bioecologico dello sviluppo umano «In questa teoria l’attenzione è dunque posta sulla persona, sull’ambiente e sulle relazioni che si creano tra loro: l’interconnessione tra persona e ambiente diventa il processo determinante dello sviluppo umano poiché il soggetto fa contestualmente esperienza di sé, degli altri e del mondo» L’operatore sociale lavora con Persone Modello multidimensionale bioecologico dello sviluppo umano Aspetti fondamentali della definizione di ecologia dello sviluppo umano: 1. L’individuo non è considerato come una tabula rasa che l’ambiente modifica a suo piacimento. L’individuo cresce e si muove dinamicamente in esso in quanto soggetto attivo. 2. L’interazione tra individuo e ambiente è bidimensionale, l’uno modifica e influenza l’altro. Questo prende il nome di reciprocità. 3. L’ambiente ecologico viene interpretato come una serie ordinata di strutture concentriche incluse l’una nell’altra. Quest’ultimo non è un’unica situazione ambientale ma l’insieme delle interconnessioni tra più situazioni ambientali. 4. La visione di sviluppo si estende alla persona nell’intero corso della vita..
Scene 5 (4m 19s)
- Microsistema (ambiente primario in cui il soggetto nasce, cresce e agisce) E’ lo strato più vicino alla persona e contiene le strutture con le quali l’individuo fa esperienza diretta di relazioni Si tratta di istituzioni e gruppi presenti nel quotidiano che hanno un impatto diretto sullo sviluppo della persona tra cui: famiglia, scuola, ritrovi di quartiere e coetanei. Il potere di questa prima serie di relazioni è connesso allo sviluppo dei processi relazionali e di reciprocità. La famiglia è il primo microsistema per imparare a vivere. È l’ambiente di apprendimento più vicino e «intimo». - Mesosistema (insieme di relazioni) Questo sistema è costituito dalle relazioni tra i microsistemi ai quali la persona partecipa attivamente. Cambia ogni volta che un individuo entra in una nuova relazione con altri microsistemi. Ne sono un esempio le interazioni tra la famiglia e gli insegnanti, o la relazione tra coetanei del bambino e della famiglia. → Rappresenta persone che conosciamo che interagiscono tra loro. Es: mio papà interagisce con la mamma - Esosistema (ambiente a cui l’individuo non partecipa direttamente) È costituito da una o più situazioni ambientali di cui l’individuo non è un partecipante attivo, ma in cui si verificano degli eventi che determinano, o sono determinati da ciò che accade nella situazione ambientale che comprendere l’individuo stesso. Questo strato impatta sulla persona interagendo con una o più strutture nel suo microsistema. Per esempio, gli orari di lavoro del genitore influenzano le opportunità di interazione con il/la figlio/a. Il bambino può non essere direttamente coinvolto a questo livello, ma può percepire la forza positiva o negativa legata all’interazione con il proprio microsistema. → Rappresenta persone che conosciamo con relazioni esterne a noi. Es: mio papà che interagisce con il suo capo (io conosco mio papà ma il suo capo no). - Macrosistema (culture in cui gli individui vivono) Valori, costumi, Leggi, aspettative - in generale le culture – delle società in cui gli individui vivono. Si riferisce ai modelli globali di ideologia e organizzazione che caratterizzano una determinata società o gruppo sociale. Gli effetti dei grandi principi definiti dal macrosistema hanno un’influenza sulle interazioni di tutti gli altri livelli. - Cronosistema (dimensione temporale) Descrive le transizioni riferite al soggetto, i cambiamenti che si verificano nel ciclo di vita delle persone e che ne influenzano lo sviluppo sul piano individuale e sociale. Osserva come il tempo modifica i processi di vita di un sistema sia a livello micro, sia macro. Il cronosistema si compone di eventi ambientali, cambiamenti delle circostanze storico- sociali e transizioni nel corso della vita. Gli elementi all’interno di questo sistema possono essere sia esterni all’individuo, come i tempi della morte di un genitore, o interni, come i cambiamenti fisiologici che si verificano con la crescita..
Scene 6 (5m 24s)
Lezione 9.10.2023 L’operatore sociale lavora con Persone - Il Sé dialogico Il Sè è composto da un set dinamico di posizionamenti (visioni soggettive del mondo, dinamiche e contestuali) impegnati in un complesso e multidirezionale dialogo che si svolge nell’ambito di un ampio scenario identitario e che esprime la propria modalità di vivere i diversi ruoli con cui la persona è confrontata nei suoi diversi contesti di vita. I posizionamenti sono forniti di “voci” tra loro in dialogo. Un dialogo è per sua natura polifonico (Bachtin, 1979). La natura narrativa e dialogica del Sè genera continuamente nuovi posizionamenti: è questo il meccanismo capace di far sviluppare il Sè. → Sè = insieme di rappresentazioni della realtà (soggettive) che noi abbiamo in un dato momento L’operatore sociale lavora con Persone - Identità L’identità può essere considerata come il risultato dei diversi modi di sperimentare il sé come soggetto (Glodis e Blasi, 1993). Sono quattro le forme dell’esperienza soggettiva di sé: - La sensazione di essere in grado di incidere sulla realtà, di modificare gli eventi, di essere cioè responsabili della costruzione della propria identità (senso di agency). - Il sentirsi un individuo unico, capace di mettere in discussione le ideologie precedentemente accettate e capace di differenziarsi dalle definizioni e dalle aspettative degli altri. - Il sentirsi un individuo capace di trovare una continuità tra presente, passato e futuro. - Il sentimento della distanza tra le proprie cognizioni (= pensieri) e le proprie azioni che richiama la capacità di autoriflessione. Solo dopo la prima adolescenza gli individui incominciano a scoprire di avere un’identità. Mentre in un primo momento l’identità è, tuttavia, sentita come qualcosa di naturalmente dato che deve quindi essere scoperto e osservato, solo successivamente l’individuo acquisisce la sensazione di essere responsabile delle caratteristiche che appartengono al proprio sé (agency). → L’identità è innata oltre che processo continuo L’operatore sociale lavora con Persone - Identità L’identità è sottoposta a continui cambiamenti e revisioni. Alcuni di questi cambiamenti possono essere attesi dalle persone, come per esempio quelli che realizzano aspetti desiderati del sé. Altri possono essere percepiti come conferme della propria identità. Altri possono invece minacciare l’identità mettendo in discussione uno o più principi identitari. Ci sono situazioni in cui i cambiamenti rendono instabili o mettono a dura prova i principi di continuità, distintività, autoefficacia e autostima (esempio perdita di lavoro, lutti, malattie, far parte di minoranze sociali, etniche, politiche...) Tali situazioni possono essere ricercate dall’individuo per modificare la propria posizione o possono derivare da forze esterne..
Scene 7 (6m 29s)
Concetto di bisogno Bisogno Stato soggettivo di tensione che spinge la persona a mettere in campo una serie di azioni al fine di soddisfare le percezioni fisiche e psicologiche che esprimono una mancanza o una necessità. Per Maslow il bisogno è una necessità impellente di raggiungere uno stato desiderato o valutato come risolutivo. La spinta a rispondere ai bisogni è definita come «motivazione». La motivazione è caratterizzata sia dalla direzione verso cui orientare le azioni per soddisfare i bisogni percepiti, sia dall’intensità con cui il soggetto si investe per raggiungere i propri obiettivi (Quaglino 1990). Le persone sono impegnate continuamente a soddisfare i propri bisogni. Secondo Maslow ogni volta che un bisogno viene soddisfatto, perde temporaneamente di investimento motivazionale e permette l’emersione di un altro bisogno. Maslow propone una struttura gerarchica dei bisogni che va da quelli di base di natura fisiologica a quelli superiori di natura spirituale e psicologica. Bisogni: modello gerarchico Piramide di Maslow (2010) La struttura gerarchica è soggetta a continue riorganizzazioni contestuali in relazione al significato che la persona vi attribuisce. Ogni bisogno dà indicazioni descrittive del funzionamento umano e prescrittiva delle azioni richieste per prendersene cura. → Maslow rappresenta un modello lineare → La piramide mostra i bisogni necessari all’uomo per la sopravvivenza → Da non interpretare in maniera lineare bensì concentrarsi sui bisogni fondamentali dell’uomo Piramide: Bisogni: modello multidimensionale (circolare) Da un punto di vista socioeducativo i bisogni si presentano come stati percettivi emotivi e cognitivi ed è possibile rilevare due differenti sistemi di bisogni: - Il sistema dei bisogni evolutivi: Si percepiscono nelle situazioni di equilibrio in relazioni alla fase specifica del proprio ciclo di vita personale e della famiglia La possibilità di attivarsi per la soddisfazione dei bisogni permette l’acquisizione di nuove competenze-abilità Schema:.
Scene 8 (7m 31s)
Bisogni: modello multidimensionale (circolare) - Il sistema dei bisogni complessi: Si attivano nelle situazioni di crisi e post-traumatiche e sono caratterizzati dalla spinta a «riparare» stati fisiologici e psicologici compromessi Nelle situazioni traumatiche e di crisi la percezione e la rappresentazione dei bisogni sono alterate e amplificate dalla condizione di incertezza e instabilità, legate al bisogno di sopravvivenza e di continuità esistenziale. Schema: Bisogni: modello multidimensionale (circolare) Circuito di soddisfazione/ gratificazione dei bisogni Schema: Concetto di bisogno Approccio pedagogico Ogni risposta a un qualsiasi bisogno mobilita dimensioni altre, indissolubilmente legate a quella corporea, come l’immaginazione e il pensiero, immette in un mondo di significati, determinate da una visione del mondo influenzate da una specifica cultura e uno specifico contesto. Possiamo parlare di bisogni universali per intendere i bisogni che tutti gli esseri umani hanno (Es: Piramide di Maslow) ma la percezione dei bisogni lega indissolubilmente la dimensione corporea e cognitiva alle situazioni contingenti in cui sono vissuti. Non esistono bisogni fisiologici in sé, ma modalità di viverli. Dal punto di vista pedagogico, ciò significa che ognuno si forma attraverso la risposta soggettiva e sociale ai bisogni. Da questa prospettiva il bisogno non è solo una necessità determinata da una mancanza, non è solo un malessere da estinguere trovando risposte alle proprie esigenze fisiologiche, psicologiche o sociali ma è anche la una condizione esistenziale che attiva la motivazione all’empowerment, all’azione, al cambiamento. Se pur spesso connotata da sensazioni e emozioni di disagio e frustrazione è alla base di qualsiasi nuovo apprendimento. È pertanto anche una occasione di crescita. Desiderare e aspirare Come ben ci insegna Maslow (1943) le persone, oltre ad esprimere bisogni primari, avvertono una tensione verso la propria autodeterminazione. Il termine desiderio deriva dalla composizione della particella privativa "de" con il termine latino sidus, sideris (plurale sidera), che significa stella. Dunque, "desidera", da cui.
Scene 9 (8m 36s)
"desiderio", significherebbe, letteralmente, "condizione in cui sono assenti le stelle". (enciclopediabioetica.com) Nello spazio della relazione di aiuto il discorso tra operatore sociale e persona cambia se poniamo il focus non solo sui bisogni ma anche sui desideri e le aspirazioni. Cosa accadrebbe se nel colloquio con una persona e/o una famiglia chiedessimo quali sono i suoi desideri/aspirazioni anziché concentrarci (solo) su bisogni, mancanze e problemi? L’operatore sociale non è un semplice risolutore di problemi/erogatore di prestazioni ma, coerentemente con l’agire etico che il nostro lavoro richiede, anche un costruttore di storie e di speranza. Desiderare e aspirare Il significato etimologico del termine aspirare è desiderare di raggiungere, cercare di conseguire qualche cosa. L’antropologo statunitense Appadurai fa il riferimento al concetto di «aspirare» inteso come la capacità di avere aspirazioni e di pensare il futuro. Il focus viene posto sul futuro, sulla dimensione culturale e sulla democrazia - deep democracy, la democrazia situata e praticata nella vita quotidiana. Per aspirare occorre: - Capacità culturale, possibilità di partecipare alle rappresentazioni sociali che danno forma e significato alla società e al suo futuro (configurazioni del possibile e del desiderabile) - Capacità di navigare tra norme sociali e di appoggiarvisi per perseguire i propri progetti di vita - Capacità di «voce», è il modo di esprimersi degli individui nel collettivo, la dimensione politica della configurazione del futuro Desiderare e aspirare Per Appadurai la cultura è sempre un dialogo tra aspirazioni e tradizioni già sedimentate (tradizioni). Gli intrecci tra rielaborazione del passato e prefigurazioni del futuro entrano in gioco nella costruzione di quei «ponti che i soggetti costruiscono tra il presente e il futuro» che, come osserva Paolo Jedlowski sono appunto le aspirazioni. La capacità di aspirare ha a che fare con la possibilità di immaginare e di esplorare, con i margini per aprire delle possibilità e quindi esplorarle ed esperirle. Là dove si esprime la capacità di aspirare, dice Appadurai, si costruisce un ancoraggio all’immaginazione. Un’immaginazione ancorata offre la possibilità di contrastare la potenza del dominio. Nelle società più povere e non democratiche viene negata la possibilità di coltivare e esprimere le aspirazioni. Per promuovere la capacità di aspirare è quindi necessario combattere le disuguaglianze. Desiderare e aspirare Un indebolimento della capacità di aspirare si registra in effetti anche nel cuore delle società più ricche e sviluppate: posti di fronte agli effetti perversi e ai disastri prodotti dalla stessa potentia tecnologica e finanziaria i cittadini delle società opulente sembrano infatti oscillare continuamente tra una cinica rassegnazione all’esistente e una fede indiscutibile nelle soluzioni tecnocratiche. La capacità di aspirare si esercita nel presente: ‹‹Aspirare a qualcosa vuol dire dare un senso al futuro: ma lo si fa nel presente, e il senso del futuro si riverbera così sul senso dell’ora, che dalla presenza dell’aspirazione è modificato›› (Jedlowski 2012: 4). In sostanza per poter nutrire delle aspirazioni è necessario individuare nel presente una ‹‹base minima di possibilità oggettive›› (Mandich 2012)..
Scene 10 (9m 41s)
La nascita delle convenzioni internazionali: la codificazione dei diritti umani I diritti umani Dal diritto naturale ad una codificazione dei diritti umani - La nozione di diritti umani si è sviluppata nel corso di un lungo processo che non è ancora concluso. Affonda le sue radici nella filosofia degli antichi greci e nella religione. - Assieme alla tradizione del diritto naturale secolare – i diritti umani si fondano sulla natura dell’essere umano e sulla sua dignità inconfondibile – la concezione dei diritti umani si è sviluppata come entità senza tempo. - Nel corso della storia, i conflitti, siano essi guerre o rivolte popolari, sono stati spesso una reazione a trattamenti disumani e ingiustizie e hanno generato risposte codificate. - Il Bill of Rights inglese del 1689, redatto sulla scia delle guerre civili del Paese, fu il risultato dell'aspirazione del popolo alla democrazia. - Esattamente un secolo dopo, la Rivoluzione francese produsse la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che proclamava l'uguaglianza universale. - I diritti sono sempre però codificati da uno Stato per i propri cittadini. → Diritto positivo → dopo i conflitti si sono stilati i diritti positivi dove vede tutti d’accordo La dichiarazione universale dei diritti umani: cambiamento di paradigma - Dopo la Seconda guerra mondiale e la creazione delle Nazioni Unite (= insieme di stati che hanno creato la carta dei diritti), la comunità internazionale ha giurato di non permettere mai più il verificarsi di atrocità come quelle commesse durante quel conflitto. - 70 milioni di morti - L’olocausto - La bomba atomica - Gli Stati non potevano più affermare di essere liberi di trattare i cittadini a loro piacimento, appellandosi alla sovranità e al divieto di ingerenza negli affari interni. Il carattere totalitario e criminale del nazionalsocialismo e gli orrori della Seconda guerra mondiale hanno originato un ripensamento di questi principi e il riconoscimento del fatto che la sovranità statale doveva essere limitata per proteggere le singole persone e la comunità degli Stati. - Processo di ricostruzione degli Stati e dei valori, con l’obbiettivo che quanto successo non si riproduca mai più. - Obbiettivo: riunire tutti i popoli del mondo sotto un simbolo forte. La dichiarazione universale dei diritti umani: contenuto - La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è ampiamente riconosciuta come il fondamento del diritto internazionale dei diritti umani. - La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha ispirato un ricco corpus di trattati internazionali sui diritti umani giuridicamente vincolanti e lo sviluppo dei diritti umani a livello internazionale negli ultimi sessant'anni, e continua a ispirare tutti noi, sia in tempi di conflitto, sia in società repressive, sia nella riparazione delle ingiustizie, sia nei nostri sforzi per raggiungere il godimento universale dei diritti umani. - È il primo riconoscimento universale del fatto che i diritti e le libertà fondamentali sono insiti in ogni essere umano, che sono inalienabili e si applicano a tutti allo stesso modo, che tutti nasciamo liberi e uguali in dignità e diritti. A prescindere dalla.
Scene 11 (10m 47s)
nazionalità, dal luogo di residenza, dal sesso, dall'origine nazionale o etnica, dal colore della pelle, dalla religione, dalla lingua o da qualsiasi altro status. La dichiarazione universale dei diritti umani: diritti descritti - La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU). Quale prima dichiarazione internazionale dei diritti umani essa rappresenta in un certo senso un «programma generale in materia di diritti umani». - Cosa sono i diritti umani? Sono i diritti che appartengono a ciascuno di noi perché esistiamo. Espressione di bisogni in diritti: abbiamo bisogno di essere tutelati perché siamo dotati in modo innato di diritti. - La Dichiarazione universale dei diritti umani Sancisce i – Diritti civili (diritto alla vita e all’integrità fisica) e – Diritti politici (diritto di voto, libertà politica) come pure i – Diritti economici, sociali e culturali. Caratteristiche dei diritti umani - Interdipendenti - Indivisibili - Intimamente legati - Universali → I diritti sono di tutti Cosa implica la codifica dei diritti umani per ciascuno di noi? Criterio di valutazione - In teoria: gli Stati si impegnano ad attuare i diritti umani. - In pratica: non tutti gli Stati possono o vogliono farlo (cfr. guerre, totalitarismo, limite all’attuazione dei diritti di certe categorie di persone, religione ecc.) - Conoscere i diritti umani è indispensabile per poterli difendere - Conoscere i diritti umani per potere lavorare come operatore sociale - Avere i diritti umani come criterio di valutazione sempre, di ogni situazione - L’attuazione dei diritti umani dipende da ciascuno di noi. - Aspetto evolutivo dei diritti umani: rispondere al bisogno attuale e urgente di protezione di ogni uomo (cfr. diritti umani della terza generazione non contenuti nella Dichiarazione dei diritti umani).
Scene 12 (11m 48s)
Lezione 16.10.2023 La finalità del lavoro sociale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale → Sono delle macro-finalità (= si possono utilizzare per tutte le professioni dell’operatore sociale) Promuovere: - Qualità di vita e salute - Benessere psichico, fisico, sociale e spirituale - L’empowerment e la capacitazione - L’autonomia, l’autodeterminazione, l’autoefficacia, l’autostima e la creatività - Processi di integrazione, inclusione e partecipazione sociale - Sviluppo della giustizia sociale, del rispetto dell’ambiente e dei contesti di vita Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Il modello della qualità di vita (QdV) Definizione Il concetto di Qualità di Vita (QdV) è ambito di interesse e di studio in diverse discipline. Ciascuna ha sviluppato una differente prospettiva in merito alla sua concettualizzazione ed applicazione (Bergland & Narum, 2007). In letteratura sono presenti molte definizioni. Ad esempio, il gruppo di lavoro sulla QdV dell’OMS l’ha definita nel 1995 come: «La percezione dell’individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi» (WHOQOL, The World healt organization quality of life assessment, 1995). Renwick e Brown parlano del «grado in cui una persona usufruisce a pieno delle possibilità/opportunità importanti della sua vita. Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Il modello della qualità di vita (QdV) Gli 8 domini della QdV Il paradigma della Qualità di Vita ha un carattere universale perché si applica ad ogni essere umano, ma anche personale poiché si declina in ogni storia di vita varia in funzione della percezione che ognuno/a di noi ha del suo stare -bene- nel mondo. Schema: - Benessere materiale (= di carattere economico) - Benessere fisico (= cura della propria parte biologica) - Benessere emozionale (= spiritualità) - Sviluppo personale (= l’individuo e le sue competenze).
Scene 13 (12m 52s)
- Autodeterminazione (= capacità che l’individuo ha di incidere sulla propria vita) - Relazioni interpersonali (= amici, famiglia, …) - Inclusione sociale - Diritti (= hanno un impatto sul nostro benessere) → Il modello nasce dalla disabilità ma ad oggi esiste a tutti i contesti sociali Il modello della qualità di vita (QdV) - L’interconnessione tra i diversi domini della QdV è inevitabile e ciò comporta che essi si influenzano reciprocamente. - La QdV di una persona non può essere spiegata, considerata o misurata mediante una visione approssimativa di una sola dimensione. - Occorre assumere la consapevolezza che ogni nuovo elemento che si inserisce nella vita della persona ha effetti, non solo sulla dimensione che si vuole potenziare, ma anche sulle altre in modo trasversale. Il modello della qualità di vita (QdV) I 7 principi di funzionamento del paradigma della QdV - Multidimensionalità Superamento degli approcci unidimensionali → Tenere in considerazioni più dimensioni per la QdV - Visione olistica Interconnessione e influenza reciproca dei vari aspetti considerati → Non è la semplice somma degli elementi, si influenzano - Elementi soggettivi ed elementi oggettivi (unicità) Necessità di considerare sia variabili socioculturali sia la narrazione di senso del soggetto - Estendibilità a tutte le persone Rilevanza del modello per tutte le persone, non solo per le persone con disabilità - Variabilità personale Diversa significatività che la persona attribuisce ai singoli domini - Temporalità Prospettiva longitudinale: i valori attribuiti dalla persona variano nel tempo (ai domini) - Empowerment Aspetti particolarmente legati all’emancipazione della persona Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Salute La Costituzione dell’OMS del 1948 ha definito la salute come: Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità. In promozione della salute, la salute viene considerata non tanto una condizione astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si può considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico. La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell’esistenza. Si tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle capacità fisiche. → Domini coinvolti: benessere fisico/emozionale/materiale e relazioni interpersonali Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Salute Partendo dall’assunto che la salute è un diritto umano fondamentale, la Carta di Ottawa mette in evidenza alcuni prerequisiti necessari: la pace, risorse economiche adeguate, il cibo e l’abitazione, un eco-sistema stabile ed un uso sostenibile delle risorse..
Scene 14 (13m 57s)
Il riconoscimento di questi prerequisiti sottolinea una visione olistica della salute in cui vengono considerati i complessi legami esistenti tra le condizioni sociali ed economiche, l’ambiente fisico, gli stili di vita individuali e la salute. Oggi viene riconosciuta sempre di più la dimensione spirituale della salute. Una comprensione globale della salute implica che tutti i sistemi e le strutture deputate a governare le condizioni socioeconomiche e l’ambiente fisico, debbano agire considerando l’impatto che il loro operato avrà sulla salute e sul benessere dei singoli individui e dell’intera comunità. → Domini coinvolti: benessere materiale/emozionale e diritti Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Benessere collettivo Sensazione positiva collettiva determinata dalla percezione di sentirsi riconosciuti come collettività, di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita sociale, poter usufruire di beni, servizi e di condividere una solidarietà sociale → Domini coinvolti: inclusione sociale, diritti e relazioni interpersonali Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Benessere individuale (Modello PERMA di Martin E. P. Seligman) Promozione del flourishing = funzionamento ottimale: stare bene e funzionare efficacemente - Emozioni positive: atteggiamento mentale positivo. Guardare al passato con orgoglio, nel futuro con speranza. - Coinvolgimento: essere completamente presente in quello che si sta facendo e negli obiettivi da raggiungere. Concentrarsi su cose che ci interessano e ci piacciono (Flow). - Relazioni sociali: costruire relazioni sociali forti e positive con le persone intorno a noi, i familiari, amici, colleghi, vicini. Impatto positivo sulla salute e in caso di difficoltà. - Significato fa riferimento ad una sfera quasi spirituale in Seligman. Sapere e sentire che la nostra vita ha un senso. Credere in qualcosa di grande o avere una missione nella vita (Dio, comunità…) - Realizzazione è la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo nella propria vita: essa alimenta pensieri positivi e autostima, e permette di guardare al futuro con ottimismo, slancio e nuova carica (principio di auto efficacia) → Elementi che contribuiscono il benessere nell’individuo → Domini coinvolti: autodeterminazione, sviluppo personale e benessere emozionale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Empowerment (def. OMS) L’empowerment è un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni. Attraverso questo processo gli individui riescono a percepire una più stretta corrispondenza tra i propri obiettivi di vita e il modo in cui raggiungerli, ma anche una correlazione tra gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti. Viene fatta una distinzione tra: - Empowerment degli individui - si riferisce soprattutto alla capacità del singolo individuo di prendere decisioni e di assumere il controllo della propria vita Empowerment di comunità- si riferisce agli individui che agiscono a livello collettivo per riuscire a influenzare e controllare maggiormente i determinanti di salute e la qualità della vita nella propria comunità..
Scene 15 (15m 2s)
→ Domini coinvolti: sviluppo personale e autodeterminazione Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Evoluzione del concetto di empowerment nel lavoro sociale Nel lavoro sociale il concetto di empowerment nasce inizialmente da una visione antioppressiva e radicale di lotta per la ridistribuzione del potere sociale, collegata ad una visione dell’utenza come persone svantaggiate e «bisognose», in situazione di disagio in quanto «vittime» della società. - Impegno soprattutto nella difesa politica dei diritti delle fasce deboli della popolazione, nella promozione di un modello di società più equa e solidale Segue una svolta individualistica e liberistica in cui l’utente è visto come consumatore, con potere di scelta del mercato assistenziale - Impegno in progetti di emancipazione individuale dell’individuo, con atteggiamento spesso connotato da laisser faire e contenimento della spesa pubblica Negli anni ‘90, prende piede l’approccio dell’empowerment agito autonomamente: le persone svantaggiate e i loro familiari tendono a costituirsi in movimenti e associazioni per promuovere da sé le azioni di intervento di aiuto. Vengono proposte soluzioni in contrapposizione con gli «esperti» della cura. → Domini coinvolti: autodeterminazione, diritti e sviluppo personale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Empowerment relazionale Nell’approccio postmoderno al lavoro sociale, in considerazione della complessità dei sistemi si tende ad integrare le diverse visioni precedenti. Nasce così il concetto di empowerment relazionale, legato strettamente al lavoro di rete inteso come processo collaborativo di apprendimento reciproco volto alla valorizzazione delle potenzialità degli individui e delle collettività, per accrescerne la possibilità di autodeterminazione nell’organizzazione della propria vita. In un processo di questo tipo, le persone coinvolte nella relazione di aiuto (esperti, utenti, familiari e cittadini), ricercano e sviluppano risorse e competenze individuali o collettive per trovare risposte efficaci ai propri bisogni. Gli esperti «cedono» parte del loro potere di trovare soluzioni alle persone con cui lavorano restituendo dignità e valore e acquisendo un ruolo di orientamento, accompagnamento e sostegno, più che di sostituzione direttiva. → Domini coinvolti: relazioni interpersonali e sviluppo personale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Capacitazione Approccio sulle capabilities Sen A.K. (2000) - Come potrebbe essere vista l’assistenza sociosanitaria se l’erogazione delle prestazioni si basasse sullo sviluppo delle capacità e delle potenzialità umane? - L’approccio sulle risorse (capabilities) riconosce come ogni persona abbia talenti importanti per lo sviluppo di sé e dell’intera comunità e vogliano contribuire in modo positivo allo sviluppo della stessa comunità a cui appartengono. - L’investimento delle risorse dovrebbe essere rivolto alle comunità e non esclusivamente ai singoli individui. La cornice di riferimento per l’agire dei servizi sociali dovrebbe essere la Comunità. → Domini coinvolti: inclusione sociale e sviluppo personale.
Scene 16 (16m 7s)
Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Capacitazione Un “approccio delle capacità”, fondato sulle libertà sostanziali, ossia sulle possibilità per le persone di “scegliersi una vita in cui si dia valore” (...) “non solo ai beni principali in possesso ad ogni singolo, ma anche delle caratteristiche personali pertinenti, quelle che governano la conversione dei beni principali in capacità di promuovere i propri scopi” Sen A.K., 2000 «nessuno sarà mai libero se non avrà risorse per poter decidere cosa fare di se stesso» → Domini coinvolti: autodeterminazione e sviluppo personale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Capacitazione Nella prospettiva di Sen è necessario rafforzare le capabilities delle persone, in maniera ampia, in modo da promuovere il benessere dell’intera comunità. Gli interventi sociali dovrebbero essere concepiti come qualcosa di cui ha bisogno la comunità per prosperare. Dovrebbero focalizzarsi sulle capacità delle persone, riservando loro un ruolo in quanto membri della comunità, un ruolo attivo nell’aumentare il benessere degli altri. La persona si fa risorsa. Gli interventi sono un diritto di ogni membro della comunità. Tutti possiedono delle capabilities, incluse le persone in situazione di vulnerabilità, e tutti devono poter partecipare attivamente e meritano l’accesso alle istituzioni chiave della società. Tutte le persone dovrebbero riceve i servizi di cui necessitano per contribuire alla vita della comunità. E l’intera comunità dovrebbe partecipare pienamente a questo processo, come comunità facilitante. → Domini coinvolti: inclusione sociale e sviluppo personale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Capacitazione Lo slittamento del fuoco dai bisogni e dalle risorse alle capacità comporta la ridefinizione del rapporto tra soggetto del welfare e politiche sociali che ponga al centro la persona, intesa non come terminale dell’attenzione (spesso compassionevole) e della valutazione del sistema professionale, ma come protagonista, a partire proprio dalla definizione dei bisogni, che nel welfare delle «politiche dell’emancipazione» era competenza esclusiva del sistema esperto. Nelle «politiche della vita» le persone sono considerate come «i migliori giudici di ciò che è bene per loro...» e quindi come partners responsabili e liberi, con le loro competenze esperienziali da mettere in gioco, a pari titolo con i sistemi esperti; altrimenti avviene che «impedendo a loro di agire in base a scelte autonome, li trattiamo come bambini» (Nussbaum, 2002). → Domini coinvolti: inclusione sociale e sviluppo personale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale La capacitazione nel percorso di Danilo Dolci → Danilo Dolci: idea di liberare gli operai dalla loro condizione attraverso l’educazione maieutica (= trarre fuori le risorse delle persone al fine di uscire dalla condizione oppressiva in cui ci si trova) Dalla riparazione alla promozione e alla capacitazione (capacitare/capacitarsi) “C'è pure chi educa, senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato.”.
Scene 17 (17m 12s)
→ Domini coinvolti: relazioni interpersonali e sviluppo personale Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Autodeterminazione È la possibilità di fare scelte e prendere decisioni in accordo con le proprie preferenze, valori e obiettivi, per determinare il grado di controllo che si desidera avere sulla propria vita e mantenere o aumentarne la qualità (Wehmeyer). Questo comprende i comportamenti e le abilità necessarie per agire in qualità di agente causa della propria vita, così da poter compiere scelte funzionali al proprio benessere (= qualità di vita) e alla propria emancipazione (agency). L’autodeterminazione può essere appresa purché vi siano opportunità per esercitarla fornite dall’ambiente, supporti e contesti che sostengano i comportamenti autodeterminati in maniera attiva ed esplicita. → Nessuno è totalmente autodeterminato, dipendiamo sempre dagli altri Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Autonomia La condizione di chi ha la capacità di organizzare le proprie azioni, scelte, comportamenti, tenendo conto di sé stessi e dei fattori che entrano in gioco nel proprio ambito esperienziale, nella complessa rete di dipendenze funzionali che lega il soggetto agli altri. Più che una caratteristica acquisita una volta per tutte, l’autonomia rappresenta piuttosto una delle mete del processo educativo che a seconda delle età e dei contesti di vita dell’individuo assume forme e caratteristiche diverse. Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Autostima Etimologicamente la parola autostima deriva dal verbo latino «aestimare», che significa sia «determinare il valore di» sia «avere un’opinione su». La stima di sé rappresenta quindi generalmente il modo in cui ciascuno vede e valuta se stesso. L’attribuzione di valore (esplicita o implicita) che l’individuo si conferisce ed è in gran parte determinata da: - Le aspettative dell’individuo su sé stesso (= obiettivi che ci poniamo) - La raggiungibilità o meno dei modelli di riferimento - La qualità delle relazioni sperimentata - I feedback ricevuti in ambito sociale, lavorativo e affettivo → Feedback accoglienti = creo empowerment → Feedback non accoglienti = non creo empowerment Finalità dell’intervento dell’operatore sociale Autoefficacia Le convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati. Si riferisce alla percezione di sé come capace di ottenere un dato effetto e di raggiungere uno scopo, di essere all’altezza di determinati eventi. Le convinzioni di autoefficacia sono il motore motivazionale dell’agentività umana: se le persone pensano di non essere capaci di produrre un effetto su una data situazione non investono energie nell’azione. L’autoefficacia non è, dunque una misura delle competenze possedute, ma la credenza che la persona ha in ciò che è in grado di fare in diverse situazioni con le capacità che possiede..