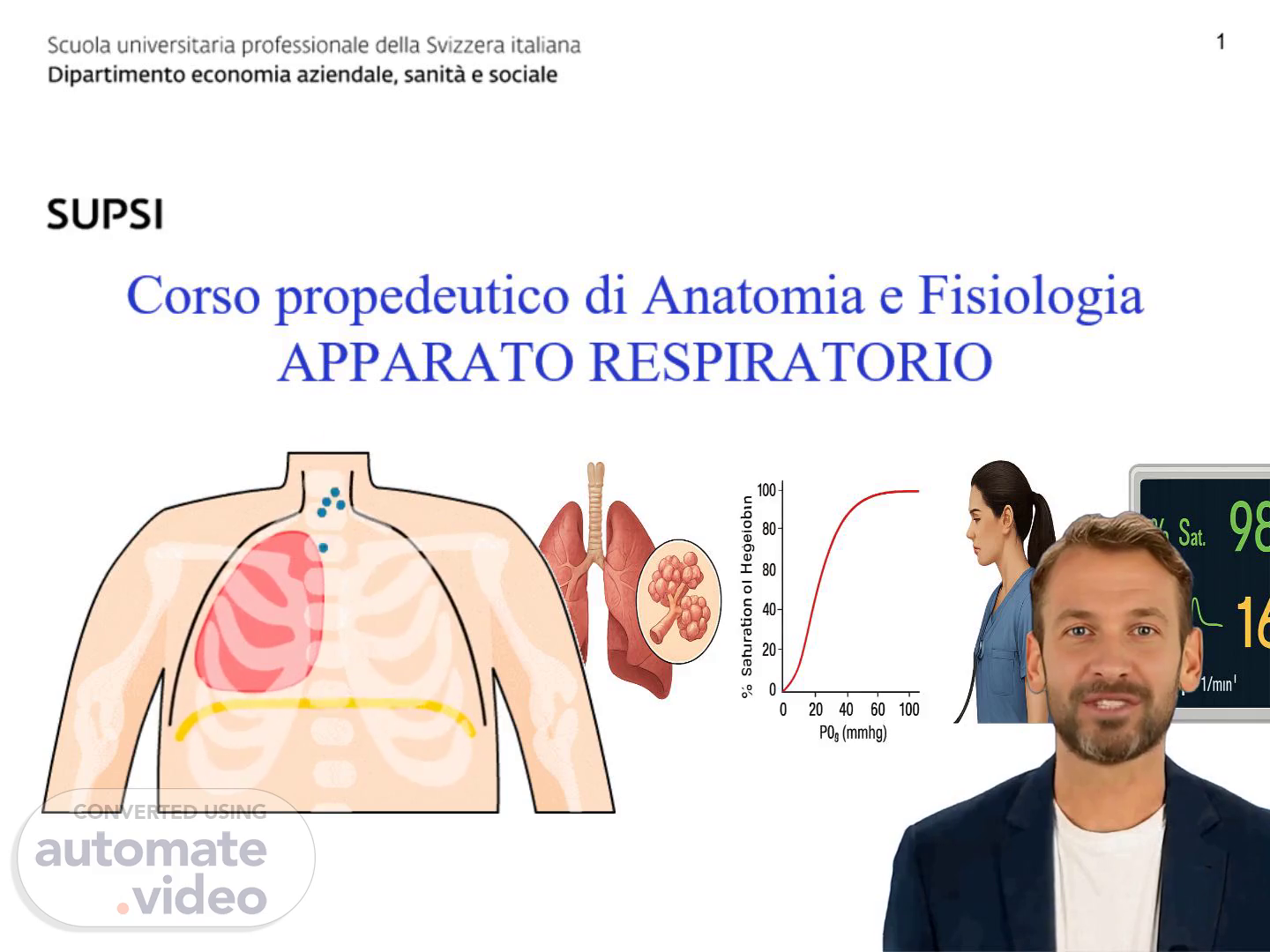
Corso propedeutico di Anatomia e Fisiologia APPARATO RESPIRATORIO
Scene 1 (0s)
[Virtual Presenter] Corso propedeutico di Anatomia e Fisiologia Apparato Respiratorio Matteo Manici e Marta Mantegazza supsi – deass – Bachelor in cure infermieristiche 11.09.2025 M Manici – M Mantegazza I testi nelle note sono sintesi elaborate con L-L-M dal testo di riferimento Martini, F H , Tallitsch, R B & Nath, J L (2019). Anatomia umana. Casa Editrice Ambrosiana (Luglio 2025).
Scene 2 (38s)
[Virtual Presenter] Indicazioni all’uso del corso Le diapositive contengono solo una traccia degli argomenti, utile come sommario La lezione è di breve durata: verranno presentati i contenuti considerati essenziali e irrinunciabili per la comprensione della tematica L’argomento deve essere approfondito sul testo di riferimento La lezione verrà registrata per essere fruibile con i suoi contenuti interattivi anche in modalità asincrona.
Scene 3 (1m 7s)
[Audio] Obiettivi didattici di apprendimento 1. Descrivere l'organizzazione anatomica e le funzioni delle vie aeree superiori e inferiori. 2. Spiegare i principi fisici della ventilazione polmonare e degli scambi gassosi (Leggi di Boyle, Dalton, Henry). 3. Illustrare i meccanismi di trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nel sangue, incluso il ruolo dell'emoglobina e l'Effetto Bohr. 4. Identificare i principali meccanismi di controllo nervoso e chimico della respirazione. 5. Collegare le conoscenze anatomiche e fisiologiche a rilevanti implicazioni infermieristiche (es. clearance muco ciliare, somministrazione O2, prelievo emogasanalisi)..
Scene 4 (1m 57s)
[Audio] Think Pair Share: due scenari clinici brevi Un assistito con tracheostomia ha spesso secrezioni dense. Quale meccanismo fisiologico è compromesso? Un paziente ansioso iperventila. Il suo pH ematico si alza o si abbassa? Perché?.
Scene 5 (2m 14s)
[Audio] Mappe concettuali Iperventilazione Secrezioni dense.
Scene 6 (2m 22s)
[Audio] Introduzione Quale rilevanza ha l’anatomia e la fisiologica respiratoria nella pratica infermieristica? Quali collegamenti con i contenuti didattici del bachelor di cure infermieristiche?.
Scene 7 (2m 34s)
[Audio] Lezioni di Anatomia Apparato respiratorio Risorsa addizionale: L'apparato respiratorio analizzato dal naso in giù, sia macroscopicamente che microscopicamente, con diversi cenni alla fisiologia respiratoria. Link alla risorsa.
Scene 8 (2m 51s)
[Audio] Organizzazione Apparato Respiratorio VIE AEREE superiori Naso (bocca) Cavità nasali Seni Faringe VIE AEREE INFERIORI Laringe Trachea Bronco Bronchioli Bronchioli respiratori Alveoli.
Scene 9 (3m 6s)
[Audio] Mucosa Respiratoria Dalla trachea ai bronchioli, la struttura della parete delle vie respiratorie cambia: Diminuiscono le ghiandole mucose e la cartilagine. Aumenta la presenza di muscolatura liscia che, nei bronchioli, forma bande circolari o a spirale attorno al lume. M Manici – M Mantegazza Componenti della mucosa respiratoria: Epitelio respiratorio: Riveste internamente le vie aeree. È un epitelio pseudostratificato cilindrico ciliato, con cellule caliciformi che producono muco. Lamina propria: È uno strato di tessuto connettivo lasso al di sotto dell'epitelio. Contiene ghiandole mucose (soprattutto nella trachea e nei bronchi) che secernono muco sulla superficie epiteliale. Nella parte inferiore del tratto respiratorio contiene fasci di muscolatura liscia. Sottomucosa: Si trova sotto la lamina propria, spesso anch’essa contiene ghiandole e tessuto connettivo più denso. Cartilagine ialina: Nella trachea e nei bronchi principali, aiuta a mantenere aperte le vie respiratorie. Progressivamente scompare nei bronchioli. Tonaca avventizia: È lo strato più esterno, costituito da tessuto connettivo che connette la struttura con i tessuti circostanti. Tipi di epitelio lungo il tratto respiratorio Cavità Nasali E Parte Superiore Della Faringe Tipo di epitelio: Cilindrico pseudostratificato ciliato con numerose cellule caliciformi mucipare. Funzione: Umidifica, riscalda e purifica l’aria inspirata. Le ciglia muovono il muco verso la faringe. Le cellule caliciformi producono muco che intrappola particelle. Parte Inferiore Della Faringe (orofaringe E Laringofaringe) Tipo di epitelio: Pavimentoso stratificato (come nella cavità orale). Funzione: Protezione meccanica contro abrasione da cibo e sostanze chimiche. Queste porzioni sono comuni a sistemi respiratorio e digerente. Tratto Iniziale Dell’apparato Respiratorio Inferiore (laringe, Trachea, Bronchi) Tipo di epitelio: Ancora cilindrico pseudostratificato ciliato, simile a quello delle cavità nasali. Funzione: Continua a filtrare e trasportare particelle estranee tramite muco e ciglia. Bronchioli Tipo di epitelio: Cubico semplice con poche ciglia sparse. Funzione: Transizione verso strutture più delicate; meno produzione di muco, ma ancora qualche capacità di pulizia. Alveoli (superfici 501 Scambio) Tipo di epitelio: Pavimentoso semplice molto sottile. Cellule coinvolte: Pneumociti di tipo 1: sottili, per lo scambio gassoso. Pneumociti di tipo 2: più grandi, producono surfattante (riduce tensione superficiale). Funzione: Consentire il passaggio efficiente di O₂ e CO₂. Clearance Muco ciliare (scala Mobile Del Muco Le ciglia battono ritmicamente verso la faringe. Spingono il muco (con particelle, polveri, microrganismi) fuori dalle vie aeree inferiori. Nelle cavità nasali, il muco intrappola particelle grandi e microrganismi. Le ciglia trasportano il muco verso la faringe, dove viene deglutito → nello stomaco gli acidi e gli enzimi distruggono gli agenti patogeni. Nelle vie aeree inferiori, le ciglia battono sempre verso l’alto, verso la faringe, in un movimento continuo chiamato Clearance muco ciliare (o scala mobile del muco) In base alla dimensione: > 10 µm Bloccate nelle cavità nasali (filtrazione meccanica e muco) 1 – 5 µm Intrappolate nel muco dei bronchioli o nel liquido alveolare < 0,5 µm Possono rimanere sospese nell’aria (difficili da eliminare) Particelle tra 1 e 5 µm, se sfuggono alla clearance ciliare, vengono fagocitate dai macrofagi alveolari, ultima linea di difesa nei polmoni. In risposta alla esposizione a vapori irritanti, polveri, allergeni, virus, si assiste ad un aumento della produzione di muco Congestione nasale, rinorrea (raffreddore). Virus respiratori (oltre 200 tipi) possono infettare l’epitelio e compromettere temporaneamente la clearance. La clearance muco ciliare è un sistema di difesa dinamico e coordinato, essenziale per pulire le vie respiratorie, proteggere da patogeni e inquinanti, mantenere l’efficienza respiratoria..
Scene 10 (6m 57s)
Introduction to Mucociliary Transport Video Microscopy.
Scene 11 (8m 6s)
[Audio] Vie Aeree Superiori La porzione di conduzione della parte superiore dell’apparato respiratorio filtra, riscalda e umidifica l’aria Cavità nasale e (Bocca) Seni paranasali Faringe (gola) M Manici – M Mantegazza Naso E Cavità Nasali Il naso è la via principale per l’aria: la filtra, riscalda, umidifica e ospita i recettori olfattivi. Il vestibolo nasale contiene peli che intrappolano le particelle più grosse. Le cavità nasali sono separate dal setto nasale e collegate ai seni paranasali. I cornetti nasali creano turbolenze che migliorano filtrazione, riscaldamento e percezione olfattiva. La mucosa respiratoria è riccamente vascolarizzata per riscaldare e umidificare l’aria. La mucosa olfattiva si trova nella parte superiore delle cavità nasali. Il palato duro separa cavità nasali e bocca; posteriormente si continua col palato molle. Le coane mettono in comunicazione le cavità nasali con la rinofaringe. Respirare con il naso protegge i polmoni; il respiro orale bypassa i meccanismi di difesa. Le epistassi sono frequenti a causa della vascolarizzazione superficiale e fragile del naso..
Scene 12 (9m 25s)
[Audio] Vie Aeree Superiori Faringe Condotto condiviso tra apparato respiratorio e digerente, collega coane a laringe ed esofago. Suddivisa in: Rinofaringe: conduce l’aria dal naso; epitelio ciliato; contiene tonsilla faringea e sbocchi delle tube uditive. Orofaringe: passaggio comune per aria e cibo; epitelio pavimentoso stratificato per protezione. Laringofaringe: dirige l’aria verso la laringe e il cibo verso l’esofago; rivestita da epitelio protettivo. Funzioni principali: trasporto di aria e alimenti, protezione meccanica e immunitaria, comunicazione con naso, bocca e orecchio medio..
Scene 13 (10m 10s)
[Audio] Ci servirà conoscerle per… Struttura / Meccanismo Funzione fisiologica Implicazione infermieristica Focus point Osservazioni / Interventi Cavità nasali / turbinati Umidificazione, riscaldamento, filtrazione dell’aria Verifica umidificazione dell'ambiente, dell’ossigeno somministrato Irritazione mucosa, epistassi Umidificatori, igiene nasale, corretta idratazione Mucosa respiratoria ciliata Trasporto del muco verso il faringe (clearance mucociliare) Educazione al respiro efficace Infezioni respiratorie (bronchiti, polmoniti) Idratazione, mobilizzazione, fisioterapia respiratoria (collaborativo) Tosse (riflesso protettivo) Espulsione di corpi estranei/secrezioni Valutazione e educazione alla tosse efficace Aspirazione (polmonite ab ingestis), infezioni, ostruzioni Registrare l’efficacia, stimolare la tosse, aspirare se necessario Faringe (deglutizione) Passaggio coordinato aria cibo Sorveglianza durante i pasti, posizionamento corretto Aspirazione (polmonite ab ingestis), disfagia Dieta modificata, supporto alla logopedista (collaborativo).
Scene 14 (11m 30s)
[Audio] Ci servirà conoscerle per… Struttura / Meccanismo Funzione fisiologica Implicazione infermieristica Focus point Osservazioni / Interventi Presenza di secrezioni Idratazione, lubrificazione e protezione mucose Aspirazione se secrezioni abbondanti e non eliminate Ostruzione, infezione Monitoraggio, documentazione tipo/quantità, gestione inalazioni (aerosol) Sonde naso gastriche (Non fisiologico) compromette mucosa nasale Sorveglianza del punto d’ingresso Lesioni, epistassi, sinusiti Igiene, rotazione, valutazione della pervietà Ossigenoterapia Supporto alla funzione respiratoria Umidificazione quando necessaria per evitare secchezza Secchezza mucose, croste, infezione Controllo flusso, monitoraggio comfort assistito.
Scene 15 (12m 26s)
[Audio] VIE AEREE INFERIORI porzione di conduzione La porzione di conduzione delle vie aeree inferiori porta aria alla porzione respiratoria e produce i suoni Laringe (fonazione) Trachea Bronchi principali Bronchioli Bronchioli respiratori Alveoli polmonari M Manici – M Mantegazza Laringe Collega faringe e trachea, regola il passaggio dell’aria e protegge le vie aeree durante la deglutizione. È composta da cartilagini (tiroidea, cricoidea, epiglottide, aritenoidi, corniculate, cuneiformi) connesse da legamenti e muscoli. La glottide (corde vocali plus rima) regola il flusso d’aria e produce i suoni. L’epiglottide si abbassa durante la deglutizione per impedire che cibo e liquidi entrino nelle vie respiratorie. Le corde vocali vibrano producendo suoni (fonazione); tono e volume dipendono da lunghezza, spessore e tensione. Le pieghe vestibolari (false corde vocali) proteggono le vere corde vocali. I muscoli intrinseci controllano apertura, chiusura e tensione della glottide. La tosse espelle corpi estranei tramite aumento della pressione intratoracica e apertura esplosiva della glottide. Il suono prodotto è modulato da lingua, denti, labbra e amplificato da faringe, cavità orale e seni paranasali. Le infiammazioni (laringite, epiglottite) possono compromettere la voce e la respirazione, con rischio di ostruzione..
Scene 16 (14m 4s)
[Audio] La porzione di conduzione delle vie aeree inferiori porta aria alla porzione respiratoria e produce i suoni Laringe (fonazione) Trachea Bronchi principali Bronchioli Bronchioli respiratori Alveoli polmonari Trachea La trachea è un condotto flessibile di circa 2,5 centimetri di diametro e 11 centimetri di lunghezza, che collega la laringe ai bronchi principali. È rinforzata da 15-20 anelli cartilaginei a C che impediscono il collasso e proteggono la via aerea. La parte posteriore aperta degli anelli è rivolta verso l’esofago, permettendo la deformazione della trachea durante la deglutizione. La trachea è rivestita da una mucosa con ghiandole mucose che mantengono umida la superficie interna. Il muscolo tracheale (muscolo liscio) tra gli anelli regola il diametro della trachea, modificando la resistenza al flusso d’aria. La stimolazione simpatica aumenta il diametro della trachea, facilitando il passaggio dell’aria..
Scene 17 (15m 8s)
[Audio] Vie Aeree Inferiori porzione di conduzione L’albero Bronchiale (bronchi E Bronchioli) L’albero bronchiale si origina dalla divisione della trachea nei bronchi principali, che si ramificano in bronchi lobari e successivamente in segmentari, formando un sistema ramificato che distribuisce l’aria ai polmoni. I bronchi sono sostenuti da cartilagini e trasportano l’aria ai lobi polmonari; il bronco destro è più largo e più verticale, facilitando l’ingresso di corpi estranei. I bronchi lobari e segmentari portano aria ai singoli lobi e segmenti broncopolmonari. Mano a mano che si ramificano, la cartilagine diminuisce e aumenta la muscolatura liscia, che regola il diametro bronchiale influenzando la resistenza al flusso. I bronchioli, privi di cartilagine, sono dominati da muscolatura liscia e controllati dal sistema nervoso autonomo: Simpatico → broncodilatazione, Parasimpatico → broncocostrizione. I bronchioli terminali (∼6500 per bronco segmentario) sono le vie aeree più piccole e regolano finemente il flusso e la distribuzione dell’aria. In condizioni patologiche (asma, allergie), l’eccessiva contrazione della muscolatura liscia può ostruire il passaggio dell’aria..
Scene 18 (16m 30s)
[Audio] Vie Aeree Inferiori porzione respiratoria La porzione respiratoria delle vie aeree inferiori è quella in cui avvengono gli scambi gassosi Laringe (fonazione) Trachea Bronchi principali Bronchioli Bronchioli respiratori Alveoli polmonari Bronchioli Respiratori I bronchioli respiratori derivano dai bronchioli terminali e sono le vie più sottili che portano l’aria agli alveoli, dove avvengono gli scambi gassosi. Dotti Alveolari E Alveoli I dotti alveolari collegano i bronchioli respiratori agli alveoli, unità terminali in cui avviene l’ossigenazione del sangue. Ogni alveolo è circondato da capillari e fibre elastiche che facilitano il ritorno elastico durante l’espirazione. Gli pneumociti di I tipo formano la parete degli alveoli e favoriscono la diffusione dei gas; gli pneumociti di 2 tipo secernono surfattante, che riduce la tensione superficiale e mantiene gli alveoli aperti. I macrofagi alveolari rimuovono particelle e patogeni arrivati agli alveoli. Membrana Respiratoria La membrana respiratoria, composta da pneumociti di I tipo, endotelio e lamina basale, è il sito degli scambi O₂/CO₂, rapidi grazie alla sottile barriera e all’ampia superficie. Patologie come la polmonite o la carenza di surfattante compromettono la funzione respiratoria e possono portare a collasso alveolare o insufficienza respiratoria. I bronchioli sono avvolti da muscolatura liscia, che regola il diametro delle vie aeree..
Scene 19 (18m 6s)
[Audio] I Polmoni Lobi pomonari Lobuli polmonari M Manici – M Mantegazza Anatomia E Fisiologia Del Polmone Forma e posizione: Organi pari, conici, con apice oltre la prima costa e base poggiante sul diaframma. Suddivisione: Polmone destro: 3 lobi (sup., medio, inf.) separati da scissure orizzontale e obliqua. Polmone sinistro: 2 lobi (sup., inf.) divisi da scissura obliqua; presenta incisura cardiaca. Relazioni: Cuore spostato a sinistra → polmone sinistro più lungo ma più piccolo. Ilo polmonare = ingresso/uscita di bronchi, vasi, nervi e linfatici → formano la radice del polmone. Organizzazione Interna Trabecole: Estensioni connettivali che suddividono i lobi in lobuli. Lobulo polmonare: Unità funzionale vascolarizzata da arteria e vena polmonare plus bronchiolo..
Scene 20 (19m 10s)
[Audio] Vascolarizzazione Del Polmone Vascolarizzazione Circolo polmonare: Apporta sangue deossigenato per scambio gassoso. Capillari avvolgono alveoli e formano la membrana respiratoria. Circolo bronchiale: Nutre le vie aeree di conduzione, origina dall’aorta toracica. Le arterie bronchiali, che hanno il ruolo di fornire sangue ossigenato al tessuto polmonare, in particolare a bronchi, tessuto connettivo polmonare, pleura viscerale, vasi linfatici e nervi del polmone. Il sangue venoso drenato in parte nel circolo sistemico, in parte nelle vene polmonari attraversi anastomosi, con mescolamento artero venoso. Quindi, mentre l’arteria polmonare trasporta sangue povero di ossigeno verso i polmoni per lo scambio gassoso (che arriva agli pneumociti per diffusione), le arterie bronchiali nutrono le strutture esterne all’alveolo (porzione di conduzione, altre strutture) con sangue ricco di ossigeno. Funzione aggiuntiva: Endotelio alveolare produce ACE → conversione angiotensina I in 2 → regolazione PA e volume..
Scene 21 (20m 21s)
[Audio] Cavità Pleurica E Membrane Pleuriche M Manici – M Mantegazza Cavità Pleurica E Membrane Pleuriche Cavità toracica: Tronco di cono delimitato da gabbia toracica e diaframma. Cavità pleuriche: Due, separate dal mediastino, ospitano ciascuna un polmone. Pleura parietale: Riveste parete toracica, diaframma e mediastino. Pleura viscerale: Riveste il polmone e penetra nelle scissure. Spazio pleurico: Virtuale; tra i due foglietti → permette scorrimento fluido. Liquido pleurico: Secreto da entrambi i foglietti → lubrifica, riduce attrito durante la respirazione..
Scene 22 (21m 3s)
[Audio] Circolazione Linfatica M Manici – M Mantegazza Circolazione Linfatica La circolazione linfatica polmonare è il sistema di vasi e linfonodi che drena la linfa dai polmoni, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio dei liquidi e alla risposta immunitaria. La linfa, un fluido trasparente, viene raccolta dai capillari linfatici e trasportata attraverso vasi di diametro maggiore fino ai dotti collettori, per poi essere riversata nella circolazione venosa. Anatomia della circolazione linfatica polmonare: Rete superficiale: Si trova sotto la pleura, la membrana che riveste i polmoni. Rete profonda: Drena la parete dei bronchi e dei vasi, passando attraverso piccoli linfonodi, che non sono semplici noduli, ma veri e propri linfonodi. Linfonodi: 1 linfonodi polmonari principali sono quelli dell'ilo e del peduncolo polmonare, e fanno capo ai linfonodi bronchiali, che possono presentare un colore più scuro a causa del deposito di pigmento. Funzioni della circolazione linfatica polmonare: Drenaggio dei liquidi: Rimuove l'eccesso di liquido e proteine che fuoriescono dai capillari sanguigni nei tessuti polmonari. Funzione immunitaria: I linfonodi polmonari fungono da filtro, catturando e distruggendo patogeni e cellule estranee, e partecipando alla risposta immunitaria. Mantenimento dell'omeostasi: Contribuisce a mantenere l'equilibrio dei liquidi e a prevenire l'edema polmonare. Trasporto di lipidi: Partecipa al trasporto dei lipidi assorbiti dall'intestino tenue nella circolazione sistemica, specialmente attraverso i vasi che drenano l'intestino..
Scene 23 (22m 48s)
[Audio] La Respirazione La respirazione esterna e la respirazione interna permettono gli scambi gassosi all’interno dell’organismo M Manici – M Mantegazza Respirazione Respirazione esterna: Scambi di O₂ e CO₂ tra ambiente esterno e fluido interstiziale. → Obiettivo: garantire ossigenazione cellulare (funzione primaria dell’apparato respiratorio). Respirazione interna: Utilizzo di O₂ e produzione di CO₂ da parte delle cellule → respirazione cellulare mitocondriale. Fasi Della Respirazione Esterna Ventilazione polmonare: Ingresso/uscita meccanica dell’aria dai polmoni. Diffusione alveolo capillare: Passaggio dei gas attraverso la membrana respiratoria. Trasporto sistemico: Circolazione di O₂ e CO₂ tra polmoni e tessuti. Conseguenze Fisiopatologiche Ipossia: ↓ O₂ nei tessuti → ↓ metabolismo cellulare (es. ischemia coronarica, cerebrale, periferica, ecc.). Anossia: Assenza totale di O₂ → morte cellulare rapida (es. ictus, infarto) → Ogni alterazione di una fase respiratoria compromette l'omeostasi tissutale..
Scene 24 (24m 8s)
[Audio] La Ventilazione Polmonare Lo scambio di aria tra l’atmosfera e i polmoni coinvolge movimenti muscolari e cambiamenti di volume che provocano cambiamenti pressori Legge di Boyle (P = 1/V) M Manici – M Mantegazza Ventilazione Polmonare Definizione: Movimento fisico dell’aria dentro e fuori i polmoni. Obiettivo: Mantenere una ventilazione alveolare efficace → evitare accumulo di CO₂ e garantire apporto costante di O₂ agli alveoli. Meccanica Della Ventilazione Forza propulsiva: Pressioni differenziali → l’aria si muove da zone a pressione maggiore verso zone a pressione minore. Inspirazione: P intrapolmonare P atmosferica Legge di Boyle (P = 1/V) A temperatura costante, pressione e volume di un gas sono inversamente proporzionali: ↓ Volume → ↑ Pressione ↑ Volume → ↓ Pressione Implicazione fisiologica: Durante inspirazione, l'espansione toracica ↑ volume polmonare → ↓ pressione alveolare → aria entra. Durante espirazione, il ritorno elastico ↓ volume → ↑ pressione → aria esce..
Scene 25 (25m 30s)
[Audio] Legge di Boyle (P = 1/V) M Manici – M Mantegazza Ventilazione Polmonare: Meccanica E Dinamiche Pressorie Ciclo respiratorio: Inspirazione = ingresso aria Espirazione = uscita aria → Guidati da variazioni di volume polmonare → creano gradienti di pressione (P = 1/V → legge di Boyle). Ruolo Della Pleura Pleure (parietale e viscerale) aderiscono grazie al liquido pleurico → consentono scorrimento, ma impediscono il distacco. Conseguenza: Qualsiasi movimento toracico o diaframmatico si trasmette direttamente al polmone, modificandone il volume. Muscoli Respiratori Diaframma: Contrazione → abbassamento cupola → ↑ volume toracico → ↓ pressione → aria entra → ≈75% dell’aria inspirata a riposo Rilascio → risalita → ↓ volume toracico → ↑ pressione → aria esce Muscoli intercostali esterni: Sollevano gabbia toracica (coste) → ↑ diametro antero posteriore e laterale → ↑ ampiezza toracica → ↑ volume intratoracico → ≈25% del volume inspirato a riposo Muscoli accessori dell’inspirazione (attivi in inspirazione forzata o aumentato fabbisogno): Sternocleidomastoideo, scaleni, piccolo pettorale, dentato anteriore → Potenziano l’elevazione costale → ↑ volume e velocità del flusso inspiratorio Intercostali interni e Muscoli addominali sono implicati nell’espirazione attiva, tirano le coste verso il basso e spingono i visceri contro il diaframma → ↓ volume toracico Dinamica Pressoria Stato di riposo: P interna = P esterna → nessun flusso d’aria Inspirazione: ↑ volume toracico → ↓ P alveolare → aria entra Espirazione: ↓ volume toracico → ↑ P alveolare → aria esce.
Scene 26 (27m 34s)
[Audio] Cambiamenti di volume Tipi 501 Ventilazione Polmonare Respirazione tranquilla (eupnea) Inspirazione attiva → contrazione di: Diaframma (→ respirazione diaframmatica/profonda) Intercostali esterni (→ respirazione costale/superficiale) Espirazione passiva → grazie a: Rilascio muscolare Ritorno elastico di fibre polmonari, parete toracica e antagonisti muscolari Note cliniche: In gravidanza o ↑ pressione addominale → prevale la respirazione costale Diaframmatica → tipica del riposo profondo 2. Respirazione forzata (iperpnea) Inspirazione attiva intensa → coinvolge: Muscoli accessori (SCOM, scaleni, piccolo pettorale, dentato anteriore) Espirazione attiva → coinvolge: Intercostali interni Muscoli addominali → spingono i visceri contro il diaframma ↓ volume toracico.
Scene 27 (28m 38s)
[Audio] Tipi 501 Ventilazione Polmonare Respirazione tranquilla (eupnea) Inspirazione attiva → contrazione di: Diaframma (→ respirazione diaframmatica/profonda) Intercostali esterni (→ respirazione costale/superficiale) Espirazione passiva → grazie a: Rilascio muscolare Ritorno elastico di fibre polmonari, parete toracica e antagonisti muscolari Note cliniche: In gravidanza o ↑ pressione addominale → prevale la respirazione costale Diaframmatica → tipica del riposo profondo 2. Respirazione forzata (iperpnea) Inspirazione attiva intensa → coinvolge: Muscoli accessori (SCOM, scaleni, piccolo pettorale, dentato anteriore) Espirazione attiva → coinvolge: Intercostali interni Muscoli addominali → spingono i visceri contro il diaframma ↓ volume toracico.
Scene 28 (29m 54s)
[Audio] Tipi 501 Ventilazione Polmonare Respirazione tranquilla (eupnea) Inspirazione attiva → contrazione di: Diaframma (→ respirazione diaframmatica/profonda) Intercostali esterni (→ respirazione costale/superficiale) Espirazione passiva → grazie a: Rilascio muscolare Ritorno elastico di fibre polmonari, parete toracica e antagonisti muscolari Note cliniche: In gravidanza o ↑ pressione addominale → prevale la respirazione costale Diaframmatica → tipica del riposo profondo 2. Respirazione forzata (iperpnea) Inspirazione attiva intensa → coinvolge: Muscoli accessori (SCOM, scaleni, piccolo pettorale, dentato anteriore) Espirazione attiva → coinvolge: Intercostali interni Muscoli addominali → spingono i visceri contro il diaframma ↓ volume toracico.
Scene 29 (31m 3s)
[Audio] Cambiamenti di pressione Variazioni 501 Pressione Nella Ventilazione Pressione atmosferica Standard: 1 atm = 760 millimetri Hg (a livello del mare), costituisce il riferimento esterno per il movimento dell’aria. 2. Pressione intrapolmonare (o intra alveolare), determinante direzione del flusso (rispetto a P atmosferica) Durante respirazione tranquilla: Inspirazione: ↓ a 759 millimetri Hg → –1 millimetri Hg → aria entra Espirazione: ↑ a 761 millimetri Hg → plus 1 millimetri Hg → aria esce Durante respirazione forzata (es. atleta): Inspirazione: fino a –30 millimetri Hg Espirazione forzata a glottide chiusa: fino a plus 100 millimetri Hg → Rischio: rottura alveoli / ernia → espirare sotto sforzo 3. Pressione intrapleurica Pressione nello spazio tra pleura viscerale e parietale (A riposo: ≈ –4 millimetri Hg, Inspirazione profonda: fino a –18 millimetri Hg) Sempre negativa rispetto all’atmosferica → Mantiene adesione dei polmoni alla parete toracica, Impedisce il collasso polmonare spontaneo, Favorisce il ritorno venoso → funzione di pompa respiratoria.
Scene 30 (32m 38s)
[Audio] La Ventilazione Polmonare Cambiamenti di pressione M Manici – M Mantegazza Fattori Fisiologici Che Mantengono La Pressione Intrapleurica Negativa 1. Tensione elastica dei polmoni Le fibre elastiche polmonari tendono a retrarre il polmone verso l’interno (verso il suo volume minimo). Questa forza tira via il polmone dalla parete toracica → contribuisce a creare una pressione negativa nello spazio pleurico. 2. Tensione elastica della parete toracica La gabbia toracica tende elasticamente a espandersi verso l’esterno. Si oppone alla retrazione polmonare → questo tiro in direzioni opposte tra polmoni e parete toracica crea una forza di trazione che abbassa la pressione intrapleurica. 3. Adesione tra le due pleure (viscerale e parietale) La presenza di liquido pleurico crea una adesione per coesione molecolare (come tra due lastre di vetro bagnate). Impedisce il distacco tra le pleure, anche se polmoni e parete toracica tendono a muoversi in direzioni opposte → questa resistenza allo scollamento mantiene la pressione bassa. 4. Funzione del drenaggio linfatico Il sistema linfatico pleurico drena continuamente liquido dallo spazio pleurico. Questo contribuisce a mantenere il volume pleurico ridotto e quindi una pressione subatmosferica stabile. Valore medio fisiologico della pressione intrapleurica A riposo: circa –4 millimetri Hg, durante inspirazione profonda: può scendere fino a –18 millimetri Hg Importanza clinica: Una perdita di pressione negativa (es. pneumotorace) → porta al collasso polmonare per perdita dell’adesione pleurica..
Scene 31 (34m 30s)
[Audio] Fattori Fisici Che Influenzano La Ventilazione Polmonare Resistenza delle vie aeree (calibro bronchiale) Tensione superficiale alveolare Compliance (distensibilità) polmonare Costo energetico M Manici – M Mantegazza Fattori Fisici Che Influenzano La Ventilazione Polmonare Resistenza delle vie aeree (calibro bronchiale) Broncodilatazione → ↓ resistenza → ↑ flusso d’aria. Broncocostrizione → ↑ resistenza → ↓ flusso d’aria. Funzione: regola la distribuzione dell’aria agli alveoli e protegge da sostanze irritanti. Tensione superficiale alveolare Le superfici alveolari sono rivestite da acqua, la cui tensione superficiale tende a far collassare gli alveoli. Il surfattante, secreto dagli pneumociti di tipo II, riduce la tensione superficiale e mantiene gli alveoli aperti. Funzione: essenziale per prevenire l’ateloectasia (collasso alveolare), soprattutto durante l’espirazione. Compliance (distensibilità) polmonare Misura quanto i polmoni si espandono per ogni unità di pressione applicata. Alta compliance = polmoni si espandono facilmente. Bassa compliance = maggiore sforzo muscolare per la ventilazione. Influenzano la compliance: Tessuto connettivo polmonare: ↓ connettivo (es. enfisema) → ↑ compliance (polmoni flaccidi). Surfattante: ↓ surfattante (es. sindrome da distress respiratorio) → ↓ compliance → ↑ rischio collasso alveolare. Mobilità toracica: Patologie articolari (es. artrite) → ↓ escursione toracica → ↓ compliance. Costo energetico A riposo, la ventilazione consuma 3–5% del metabolismo basale. In condizioni di compliance ridotta o resistenza aumentata, il costo energetico aumenta drasticamente, fino a rendere faticosa anche la respirazione a riposo..
Scene 32 (36m 41s)
[Audio] Misurazione Della Frequenza Respiratoria E Dei Volumi Respiratori Le Misurazioni Della Frequenza E Dei Volumi Respiratori Frequenza Respiratoria (f): numero di atti respiratori/min. Valori normali: Adulti: 12–18 atti/min Bambini: 18–20 atti/min I volumi respiratori principali rappresentano le quantità di aria che i polmoni mobilizzano durante i diversi momenti del ciclo respiratorio. Il volume corrente (V-T---) è la quantità di aria che entra o esce dai polmoni durante un respiro tranquillo; il valore medio è di circa 500 mL sia negli uomini che nelle donne. Il volume di riserva inspiratoria (V-R-I--) è la quantità addizionale di aria che si può inspirare forzatamente dopo una normale inspirazione; in media è pari a 3300 mL nei maschi e 1900 mL nelle femmine. Il volume di riserva espiratoria (V-R-E--) rappresenta invece l’aria che può essere espulsa volontariamente dopo un’espirazione tranquilla: mediamente 1000 mL nei maschi e 700 mL nelle femmine. Il volume residuo (V-R---) è la quantità di aria che permane nei polmoni anche dopo un’espirazione massimale: è di circa 1200 mL negli uomini e 1100 mL nelle donne. Il volume minimo, che rappresenta l’aria che resterebbe nei polmoni in caso di completo collasso: non può essere misurato in condizioni normali e varia tra 30 e 120 mL. La ventilazione polmonare descrive il movimento dell’aria durante la respirazione ed è rappresentata da diversi parametri funzionali: Il volume minuto respiratorio (V-E---) si ottiene moltiplicando la frequenza respiratoria per il volume corrente (V-T---); in condizioni di riposo (con 12 atti/min e 500 mL per atto) risulta di circa 6 litri al minuto Non tutta l’aria inspirata raggiunge gli alveoli: una parte rimane nello spazio morto anatomico (V-D---), che corrisponde a circa 150 mL, ovvero il 30% del volume corrente (Comprende tutte le vie aeree di conduzione, come naso, faringe, laringe, trachea, bronchi e bronchioli terminali, aree del’apparato respiratorio che non provvedono agli scambi gassosi) La quantità d’aria che effettivamente arriva agli alveoli per partecipare agli scambi gassosi è detta ventilazione alveolare (V-A---), e a riposo è pari a circa 4,2 litri al minuto (12 atti/min × 350 mL, dove 350 mL è il volume corrente meno lo spazio morto) In condizioni di massima attività, il volume minuto respiratorio può arrivare fino a 200 litri al minuto, grazie a un aumento combinato di frequenza respiratoria e volume corrente..
Scene 33 (39m 46s)
[Audio] Gli Scambi Gassosi Legge di Dalton Per comprenderlo, consideriamo: Le pressioni parziali dei gas coinvolti (Legge di Dalton) la diffusione delle molecole tra gas e liquidi (Legge di Henry) Solubilità dei gas 760 millimetri Hg = 101,3 kPa (1 millimetri Hg ≈ 01333 kPa) Legge 501 Dalton E Pressioni Parziali L’aria atmosferica è una miscela di gas, costituita per circa il 78,6% da azoto (N₂), 20,9% da ossigeno (O₂), e 0,04% da biossido di carbonio (CO₂), con il resto costituito da vapore acqueo. La pressione atmosferica totale è di circa 101,3 kPa (equivalente a 760 millimetri Hg). Secondo la legge di Dalton, ogni gas contribuisce in modo proporzionale alla pressione totale..
Scene 34 (40m 52s)
[Audio] Gli Scambi Gassosi Legge di Dalton Per comprenderlo, consideriamo: Le pressioni parziali dei gas coinvolti (Legge di Dalton) la diffusione delle molecole tra gas e liquidi (Legge di Henry) Solubilità dei gas 760 millimetri Hg = 101,3 kPa (1 millimetri Hg ≈ 01333 kPa) Provenienza Azoto (N₂) Ossigeno (O₂) Biossido di carbonio (CO₂) Vapore acqueo (H₂O) Aria inspirata (secca) 79,6 kPa (78,6%) 21,2 kPa (20,9%) 0,04 kPa (0,04%) 0,49 kPa (0,5%) Aria alveolare (satura) 76,4 kPa (75,4%) 13,3 kPa (13,2%) 5,3 kPa (5,2%) 6,3 kPa (6,2%) Aria espirata (satura) 75,8 kPa (74,8%) 15,5 kPa (15,3%) 3,7 kPa (3,7%) 6,3 kPa (6,2%) Legge 501 Dalton E Pressioni Parziali La pressione parziale dell’ossigeno (PO₂) nell’aria atmosferica è circa 21,2 kPa (20,9% di 101,3). La pressione parziale dell’azoto (PN₂) è circa 79,6 kPa. La pressione parziale del CO₂ (PCO₂) atmosferico è circa 0,04 kPa..
Scene 35 (43m 4s)
[Audio] Gli Scambi Gassosi Legge di Henry Legge 501 Henry E Diffusione Gas/liquidi Secondo la legge di Henry, a temperatura costante, la quantità di gas disciolto in un liquido è proporzionale alla sua pressione parziale. Se la pressione parziale di un gas aumenta, più molecole entrano in soluzione; se diminuisce, le molecole escono dalla soluzione. Un esempio è l’effervescenza di una bibita gassata appena aperta..
Scene 36 (43m 33s)
[Audio] Solubilità dei gas M Manici – M Mantegazza Solubilità Dei Gas A parità di pressione e temperatura, la quantità di gas disciolta dipende anche dalla solubilità. Il CO₂ è molto solubile nei liquidi corporei, l’O₂ lo è meno, l’N₂ pochissimo. Ad esempio, nel sangue delle vene polmonari: CO₂: 2,62 mL/dL con PCO₂ = 5,3 kPa O₂: 0,29 mL/dL con PO₂ = 13,3 kPa N₂: 1,25 mL/dL con PN₂ = 76,4 kPa Quindi, pur avendo una pressione parziale molto inferiore, il CO₂ è presente in quantità maggiore rispetto all’azoto, grazie alla maggiore solubilità..
Scene 37 (44m 18s)
[Audio] Efficienza Della Diffusione Lo scambio di gas a livello della membrana respiratoria è efficiente per: Gradiente pressorio (elevati Δ P) Distanza di diffusione (0,1-0,5 µm) Solubilità nei lipidi (O2 e C-O-2--) Ampia superficie di scambio (70-140 m2) Coordinazione ventilazione/perfusione (V/Q) M Manici – M Mantegazza Scambio Gassoso Alveolo capillare – Fattori 501 Efficienza Gradiente pressorio: differenze elevate di pressione parziale (soprattutto PO₂) tra alveoli e sangue favoriscono la diffusione dei gas; a quote elevate la PO₂ diminuisce, riducendo l’ossigenazione. Distanza di diffusione: sottile membrana respiratoria (0,1–0,5 µm) garantisce rapido passaggio dei gas; edema o infiammazione aumentano la distanza, ostacolando gli scambi. Solubilità nei lipidi: O₂ e CO₂ attraversano facilmente il surfattante e le membrane cellulari per via della loro lipofilia. Ampia superficie di scambio: circa 70–140 metri quadrati di area alveolare permettono un’adeguata ossigenazione; patologie come enfisema riducono l’efficienza. Coordinazione ventilazione/perfusione (V/Q): il flusso ematico si adatta alla ventilazione alveolare ottimizzando l’assorbimento di O₂; alterazioni del V/Q (es. embolia, occlusione) compromettono la funzione respiratoria..
Scene 38 (46m 7s)
[Audio] Scambi Gassosi Sintesi Respirazione esterna Respirazione interna Respirazione Esterna: Scambio Alveolo capillare Durante il passaggio nei capillari, si assiste a una diffusione passiva dei gas: O₂ entra nel sangue → ↑ PO₂ CO₂ esce dal sangue → ↓ PCO₂ Quando il sangue entra nelle venule polmonari, è in equilibrio con l’aria alveolare: PO₂ ≈ 13,3 kPa (100 millimetriHg), PCO₂ ≈ 5,3 kPa (40 millimetriHg) Il sangue lascia gli alveoli pronto per la circolazione sistemica Tempistiche dello scambio A riposo: Un eritrocita impiega ~0,75 s nel capillare polmonare Durante esercizio fisico: Tempo ridotto a < 0,3 s, ma lo scambio resta efficace: equilibrio raggiunto Respirazione Interna: Scambio Sangue Sistemico tessuti Il sangue ossigenato esce dai capillari alveolari e rientra al cuore tramite le vene polmonari, dove si mescola con sangue refluo dalla circolazione bronchiale. Questo sangue ha ↓ PO₂ perché non ha partecipato agli scambi alveolari La PO₂ nelle vene polmonari è scende a circa 95 millimetriHg ≈ 12,6 kPa. Questo è il valore con cui il sangue entra nel circolo sistemico La PO₂ sistemica rimane costante finché il sangue non raggiunge i capillari periferici. O₂ diffonde verso i tessuti finché la PO₂ del sangue non eguaglia quella del fluido interstiziale. CO₂ segue il gradiente opposto: dai tessuti → sangue capillare In altre parole nei capillari periferici, l’ossigeno diffonde dal sangue (PO₂ ≈ 12,6 kPa) al fluido interstiziale (PO₂ ≈ 5,3 kPa), mentre il biossido di carbonio si sposta in direzione opposta, dai tessuti (PCO₂ ≈ 6,0 kPa) al sangue (PCO₂ ≈ 5,3 kPa)..
Scene 39 (46m 55s)
[Audio] Trasporto 501 Gas Nel Sangue Trasporto O2 Trasporto C-O-2 O2 O2 Trasporto di gas nel sangue Ossigeno e CO₂ sono poco solubili nel plasma: a PO₂ alveolare normale, solo 0,3 mL di O₂ si sciolgono in 100 mL di plasma. Questo non basta per i tessuti, che richiedono più ossigeno e producono più CO₂ di quanto il plasma possa trasportare. Il problema è compensato dai globuli rossi, che legano l’O₂ all’emoglobina e trasformano la CO₂ in composti solubili. Queste reazioni sono reversibili: i GR assorbono gas quando sono in eccesso nel plasma e li rilasciano quando scarseggiano. La CO₂ viaggia nel sangue in tre forme: come acido carbonico (la quota principale), legata all’emoglobina o disciolta nel plasma..
Scene 40 (47m 48s)
[Audio] Emoglobina Trasporto O2 Trasporto C-O-2 L’emoglobina L’emoglobina è una proteina tetramerica costituita da 4 subunità, ognuna con un gruppo eme contenente un atomo di ferro (Fe²⁺) centrale. Ogni gruppo eme lega una molecola di ossigeno → una molecola di Hb può legare fino a 4 O₂ → formazione di ossiemoglobina (HbO₂). Il legame è reversibile: consente la captazione dell’ossigeno nei polmoni e il rilascio nei tessuti. Ogni eritrocita (G-R---) contiene circa 280 milioni di molecole di Hb, quindi può trasportare oltre un trilione di molecole di ossigeno. Saturazione = percentuale di gruppi eme occupati da ossigeno (100% = tutti i gruppi eme legati a O₂, 50% = mediamente 2 O₂ per molecola di Hb) La saturazione dipende dalla conformazione dell’emoglobina, che può cambiare in risposta all’ambiente (pH, temperatura, ecc.). Il fattore chiave che regola il legame O₂-Hb è la pressione parziale dell’ossigeno (PO₂): Alta PO₂ → Hb lega ossigeno (polmoni), Bassa PO₂ → Hb rilascia ossigeno (tessuti) Questa è una reazione reversibile che si adatta dinamicamente al contesto fisiologico. La curva che descrive la saturazione dell’Hb in funzione della PO₂ è sigmoide (S italica) per via del legame cooperativo: Il legame della prima molecola di O₂ facilita il successivo. Inizialmente, il legame di una molecola di ossigeno all'emoglobina aumenta l'affinità per l'ossigeno delle subunità rimanenti, facilitando ulteriormente il legame di altre molecole di ossigeno. Questo processo rende la curva ripida nella parte centrale, mentre la parte iniziale e finale sono più piatte. Dopo la prima, la curva cresce rapidamente fino a un plateau vicino al 100%. A PO₂ > 60 millimetriHg → saturazione > 90% (La curva garantisce efficienza anche in condizioni ipossiche come in alta quota o nelle patologie respiratorie) A PO₂ alveolare = 100 millimetriHg → Hb saturazione ≈ 97,5% (Saturazione completa solo a PO₂ ≈ 250 millimetriHg (non fisiologica). Ciò che conta è la capacità della Hb di rilasciare O₂ nel range funzionale: 100 → 15 millimetriHg).
Scene 41 (50m 31s)
[Audio] EMOGLOBINA: Effetto di alcuni fattori Il rilascio di ossigeno da parte dell’emoglobina aumenta in condizioni di acidità (effetto Bohr), temperatura elevata e concentrazione di B-P-G aumentata, adattandosi alle esigenze metaboliche dei tessuti. Trasporto O2 Trasporto C-O-2 M Manici – M Mantegazza L’emoglobina Effetto del pH (Effetto Bohr) Quando il pH del sangue si abbassa, l’emoglobina modifica la propria struttura e rilascia più ossigeno. Nei tessuti attivi, l’accumulo di acidi riduce il pH locale, facilitando così la cessione di ossigeno. A parità di PO₂, una lieve acidificazione può far scendere la saturazione dell’emoglobina anche del 15-20%. Questo meccanismo prende il nome di effetto Bohr. Ruolo della CO₂ nell’effetto Bohr La CO₂ prodotta dai tessuti entra nei globuli rossi e, grazie all’anidrasi carbonica, si trasforma in acido carbonico. L’acido si dissocia in ioni idrogeno e bicarbonato, abbassando il pH del plasma. Più CO₂ significa più H⁺ e quindi maggiore rilascio di ossigeno. Meno CO₂ ha l’effetto opposto: il pH sale e l’emoglobina trattiene più a lungo l’ossigeno. Effetto della temperatura Quando la temperatura aumenta, l’emoglobina rilascia ossigeno con maggiore facilità. Questo accade soprattutto nei tessuti che lavorano molto, come i muscoli in attività. Il calore prodotto dall’attività muscolare facilita lo svincolo dell’ossigeno dal legame con l’emoglobina. Al contrario, temperature più basse aumentano l’affinità dell’Hb per l’ossigeno. Ruolo del B-P-G (2,3-bisfosfoglicerato, prodotto dell’attività metabolica che si sta svolgendo all’interno dei GR) Il BPG è un prodotto della glicolisi nei globuli rossi. Quando è presente in concentrazioni elevate, l’emoglobina libera più ossigeno a parità di PO₂. Situazioni come ipossia cronica, pH elevato o stimoli ormonali aumentano la produzione di B-P-G--. Un aumento di B-P-G rende più efficace la cessione di ossigeno ai tessuti. Nei globuli rossi invecchiati il B-P-G diminuisce, riducendo la capacità di rilascio dell’ossigeno. Questo è uno dei motivi per cui il sangue conservato troppo a lungo può diventare inefficace per le trasfusioni..
Scene 42 (53m 6s)
[Audio] Emoglobina Fetale Trasporto O2 Trasporto C-O-2 L’emoglobina fetale ha un’affinità più elevata per l’ossigeno e garantisce un efficace trasferimento di O₂ dalla madre al feto anche a basse PO₂. L’emoglobina Fetale I globuli rossi del feto contengono una forma diversa di emoglobina, chiamata emoglobina fetale (HbF). Rispetto all’emoglobina adulta (HbA), l’HbF ha una struttura differente che le conferisce un’affinità molto più alta per l’ossigeno. A parità di PO₂, l’HbF riesce a legare più ossigeno rispetto all’HbA. Questo vantaggio è cruciale perché il feto deve estrarre ossigeno dal sangue materno, dove la PO₂ è relativamente bassa. Nella placenta, il sangue materno può arrivare con PO₂ di circa 40 millimetriHg e avere una saturazione del 75%. Il sangue fetale, pur partendo da una PO₂ più bassa (≈ 20 millimetriHg), mantiene comunque una saturazione del 58%, grazie all’HbF. Questo squilibrio tra saturazione materna e fetale garantisce il trasferimento netto di ossigeno al feto, anche a basse pressioni parziali. La curva di dissociazione dell’HbF è più ripida nella zona bassa della PO₂. Questo significa che piccole variazioni di PO₂ nei tessuti fetali provocano un rilascio efficace di ossigeno, favorendo lo scambio anche in ambienti ipossici..
Scene 43 (54m 40s)
[Audio] Trasporto Del Biossido 501 Carbonio Trasporto O2 Trasporto C-O-2 La CO₂ prodotta nei tessuti entra nel sangue e viene trasportata come acido carbonico, legata all’emoglobina o disciolta nel plasma; tutte le reazioni sono reversibili e garantiscono l’eliminazione del gas negli alveoli. Trasporto Del Biossido 501 Carbonio Il biossido di carbonio (CO₂) è il risultato del metabolismo aerobico nei tessuti. Trasporto del CO₂: tre modalità, tutte reversibili Il biossido di carbonio generato nei tessuti è trasportato nel sangue in tre forme. Tutte le reazioni coinvolte sono reversibili, così da permettere la raccolta del gas nei tessuti e il suo rilascio nei polmoni: 1. Ioni bicarbonato (≈ 70%) La maggior parte del CO₂ diffonde nei globuli rossi, dove si combina con l’acqua per formare acido carbonico. Questa reazione è catalizzata dall’enzima anidrasi carbonica. L’acido si dissocia immediatamente in ione H⁺ e bicarbonato (HCO₃⁻). Gli ioni idrogeno sono tamponati dall’emoglobina (formando HbH⁺), evitando variazioni brusche del pH. Il bicarbonato esce dai globuli rossi in cambio di ioni cloruro (Cl⁻), in un processo chiamato shift del cloruro. Questo scambio mantiene l’equilibrio ionico senza consumo di A-T-P-. 2. CO₂ legata all’emoglobina (≈ 23%) Una parte del CO₂ si lega direttamente alla porzione proteica (globina) dell’emoglobina. Il legame avviene con i gruppi amminici (−NH₂), formando carbaminoemoglobina (HbCO₂). Questo legame riduce l’affinità dell’Hb per l’ossigeno, favorendone il rilascio nei tessuti. Anche questa reazione è completamente reversibile. 3. CO₂ disciolta nel plasma (≈ 7%) Solo una piccola quota di CO₂ rimane disciolta come gas nel plasma. Questa frazione, sebbene ridotta, è importante perché rappresenta la forma che più facilmente diffonde negli alveoli. Dinamica complessiva del trasporto Il trasporto del CO₂ è un processo flessibile e adattabile. Nei tessuti (PCO₂ ≈ 45 millimetriHg / 6,0 kPa), la CO₂ entra nel sangue e viene rapidamente trasformata o legata. Negli alveoli (PCO₂ ≈ 40 millimetriHg / 5,3 kPa), il gradiente favorisce il rilascio del gas verso l’esterno. Tutte le reazioni chimiche coinvolte possono invertire direzione, a seconda del contesto (tessuti against polmoni).
Scene 44 (57m 30s)
[Audio] Controlli Della Respirazione: Locale E V/p M Manici – M Mantegazza Regolazione Locale Del Rilascio 501 Ossigeno E Del Rapporto Ventilazione perfusione Nei tessuti attivi: ↓PO₂ e ↑PCO₂ → più O₂ rilasciato plus vasodilatazione locale. Nei polmoni: ↓PO₂ alveolare → vasocostrizione capillari → il sangue è diretto agli alveoli più ventilati. ↑PCO₂ alveolare → broncodilatazione → più aria agli alveoli attivi. Questi aggiustamenti ottimizzano gli scambi gassosi e compensano eventuali zone danneggiate..
Scene 45 (58m 12s)
[Audio] Controlli Della Respirazione: Nervoso M Manici – M Mantegazza Controllo Nervoso Della Respirazione Aumento attività → ↑ richiesta di O₂ → ↑ frequenza respiratoria, regolata da: Controllo volontario Origina dalla corteccia cerebrale, che può modulare i centri bulbari e agire direttamente sui motoneuroni spinali (via corticospinale). Utile per parlare, cantare, trattenere il respiro. Controllo involontario Attivo a riposo e durante l'esercizio. Gestito da centri respiratori nel bulbo e nel ponte (formazione reticolare). Regola i muscoli respiratori in base alle necessità metaboliche. Centri Del Ritmo Respiratorio (bulbo) formati da un gruppo respiratorio dorsale (G-R-D--) e uno ventrale (G-R-V--) G-R-D-: attivo in ogni respiro; controlla l’inspirazione tranquilla (→ diaframma e intercostali esterni). G-R-V-: attivo solo nella respirazione forzata; controlla muscoli accessori per inspirazione ed espirazione forzata. I neuroni inspiratori ed espiratori si inibiscono reciprocamente. Nella Respirazione tranquilla, durante l’inspirazione G-R-D attivo per ~2 s (→ contrazione muscoli) e nell’espirazione passiva G-R-D inattivo per ~3 s (→ rilassamento muscoli). Nella Respirazione forzata, G-R-D stimola il G-R-V (→ attivazione muscoli accessori per inspirazione ed espirazione attive). Centri Del Ponte (modulazione) Centro apneustico (stimola GRD → prolunga inspirazione e Inibito dal centro pneumotassico e dai segnali vagali dai polmoni). Centro pneumotassico (Inibisce apneustico → favorisce espirazione. ↑ attività → respirazione più rapida e superficiale. ↓ attività → respirazione più lenta e profonda) Complesso di Pre Bötzinger (Situato nel bulbo, agisce da pacemaker respiratorio, essenziale per generare il ritmo base della respirazione) Note Cliniche Farmaci stimolanti (caffeina, anfetamine): ↑ frequenza respiratoria Depressori SNC (oppioidi, barbiturici): ↓ frequenza sids (morte in culla): possibile difetto nei riflessi respiratori dovuto a malformazioni del pacemaker respiratori..
Scene 46 (1h 0m 54s)
[Audio] Controlli Della Respirazione: Nervoso M Manici – M Mantegazza.
Scene 47 (1h 1m 6s)
[Audio] CONTROLLI della respirazione: Afferenze sensoriali Barocettori Recettori da stiramento Recettori irritativi Altri stimoli Modulazione Dell’attività Respiratoria: Afferenze Sensoriali Barocettori Situati in seni aortici e carotidei. Sensibili a variazioni della pressione arteriosa. Alterano la respirazione per aiutare a mantenere l’omeostasi cardiovascolare. Recettori Da Stiramento Nei bronchi e polmoni. Rilevano il volume polmonare. Riflessi di Hering Breuer: Inspirazione troppo prolungata → inibizione dell’inspirazione (protezione da sovradistensione). Recettori Irritativi In naso, laringe, bronchi. Stimoli chimici o meccanici (polveri, fumo, sostanze irritanti) → tosse, starnuto, broncocostrizione, apnea riflessa. Altri Stimoli Dolore, febbre, sensazioni viscerali, ansia → possono modificare frequenza e profondità respiratoria..
Scene 48 (1h 2m 9s)
[Audio] CONTROLLI della respirazione: Chemocettivo M Manici – M Mantegazza Controllo Chemocettivo Della Respirazione Chemocettori Centrali: nell’area ventrolaterale del bulbo → sensibili a PCO₂ e pH del liquido cerebrospinale. Chemocettori Periferici: glomi carotidei (→ nervo glossofaringeo, IX): sensibili a ↓ PO₂, ↓ pH, ↑ PCO₂. glomi aortici (→ nervo vago, X): stessi stimoli dei carotidei. ⟶ Aumento di PCO₂ → stimolo principale che aumenta frequenza e profondità respiratoria I chemocettori sono sensibili a: CO₂ (principalmente), O₂ e pH. Risposta più potente alla variazione di PCO₂ (anche del 10%). La PO₂ stimola i centri respiratori solo quando < 60 millimetri Hg Iperventilazione prima di trattenere il respiro → ↓PCO₂ → rischio svenimento per ipossia → pericoloso! Nella stimolazione cronica = ↓sensibilità. In malattie croniche (es. BPCO) PO₂ cronicamente bassa, PCO₂ cronicamente alta. I chemocettori si adattano e presentano difficoltà a ripristinare i valori normali Ruolo del pH e dell’Acidosi i chemocettori centrali → sensibili anche al pH. Nell’esercizio fisico: accumulo acido lattico → ↓pH → stimolazione respiratoria Ipercapnia: aumento di PCO₂ arteriosa Stimola chemocettori periferici plus centrali, CO₂ attraversa la barriera ematoencefalica → ↓pH LCR → stimolo respiratorio. Risultato: ↑frequenza e profondità del respiro, ↑eliminazione CO₂ → ritorno all’omeostasi Causa più comune: ipoventilazione Ipocapnia: diminuzione di PCO₂, indotta da iperventilazione. ↓PCO₂ → ↓stimolazione chemocettori → ↓attività respiratoria, respiro rallenta fino a ristabilire la PCO₂ normale Riflessi Barocettivi e Respirazione Barocettori (aortici, carotidei) → coinvolti anche nella regolazione respiratoria, ↓PA → ↑frequenza respiratoria ↑PA → ↓frequenza respiratoria, Vie afferenti: n glossofaringeo (I-X---) e vago (X) Riflessi di Hering Breuer L’informazione sensitiva coinvolta in questi riflessi è distribuita ai centri apneustici e al gruppo respiratorio ventrale, ma non interviene durante la respirazione tranquilla o finché il volume corrente è inferiore a 1000 mL 1. Inspiratorio (Previene sovradistensione polmonare, Recettori da stiramento → n vago → inibizione GRD → attivazione GRV → espirazione) 2. Espiratorio (Solo in espirazione forzata, Recettori nella parete alveolare → stimolano l’inspirazione quando i polmoni sono svuotato) Riflessi Protettivi. Gli stimoli possono essere vapori irritanti, particelle, stimoli meccanici. I Recettori sono sull’epitelio delle vie aeree. I Riflessi principali sono lo starnuto (irritazione nasale), la tosse (irritazione laringe/trachea/bronchi) e il laringospasmo (chiusura glottide per irritanti o corpi estranei). Il meccanismo prevede apnea → chiusura glottide → contrazione muscoli espiratori → espulsione violenta ma sviluppa un rischio di laringospasmo severo → asfissia Limiti del Controllo Volontario. I riflessi chemocettivi sono predominanti. Non è possibile sopprimere volontariamente la respirazione fino alla morte. A livelli critici di CO₂ → il corpo forza l’atto respiratorio (Es.Il test di apnea è utilizzato in corso di determinazione di morte cerebrale per l’identificazione del potenziale donatore di organi)..
Scene 49 (1h 3m 7s)
[Audio] Prestazione Respiratoria Ed Età M Manici – M Mantegazza Sviluppo Respiratorio Alla Nascita Il sistema respiratorio cambia lungo tutto l’arco della vita, ma molte modifiche non producono sintomi finché la persona resta in buona salute. Il declino funzionale con l’età è in parte inevitabile, ma può essere contenuto attraverso stili di vita sani. Non fumare è uno dei fattori protettivi più significativi per mantenere una buona funzione polmonare in età avanzata. Alla nascita, il passaggio dalla vita fetale a quella extrauterina richiede un adattamento respiratorio drammatico. Durante la vita fetale, i polmoni sono collassati e pieni di liquido, e la resistenza vascolare polmonare è molto alta. Il parto innesca cambiamenti rapidi: l’ossigeno crolla, il CO₂ sale, e il neonato deve iniziare a respirare per sopravvivere. Primo respiro: Lo sforzo richiesto è notevole: forti contrazioni del diaframma e degli intercostali esterni permettono all’aria di entrare superando la tensione superficiale e aprendo i bronchi e la maggior parte degli alveoli. La conseguente pressione negativa stimola anche la perfusione del circolo polmonare. Modificazioni circolatorie: L’aumento dell’ossigeno nel sangue favorisce la chiusura del forame ovale (tra gli atri) e la chiusura del dotto arterioso (tra tronco polmonare e aorta). Dopo il primo respiro, i polmoni non tornano più completamente collassati il tessuto connettivo e le cartilagini mantengono aperte le vie aeree, il surfattante alveolare impedisce il collasso degli alveoli residui Aspetto forense utile: I polmoni di un neonato che ha respirato galleggiano in acqua; quelli di un feto morto prima del parto affondano(contenendo solo liquido amniotico). Modificazioni respiratorie nella terza età. Con l’invecchiamento, il sistema respiratorio va incontro a modificazioni strutturali e funzionali, spesso asintomatichenelle persone sane, ma che riducono la capacità di riserva respiratoria. Questi comprendono: 1. Perdita di elasticità Il tessuto elastico polmonare si degrada gradualmente → ciò comporta: ↓ compliance (capacità del polmone di espandersi) ↓ capacità vitale 2. Rigidità toracica Processi degenerativi (es. artrosi costale) e perdita di flessibilità delle cartilagini limitano i movimenti del torace → questo comporta una riduzione del volume minuto respiratorio e della tolleranza all'esercizio. 3. Enfisema senile Una certa quantità è fisiologica dopo i 50 anni, ma è marcata nei fumatori, è variabile a seconda dell’esposizione a irritanti ambientali (fumo, inquinamento) Confronta visivamente la funzione respiratoria in soggetti fumatori e non fumatori → evidenziando il forte impatto del fumo sul deterioramento precoce della funzione respiratoria..
Scene 50 (1h 6m 20s)
[Audio] Integrazione Tra Apparato Respiratorio E Cardiovascolare M Manici – M Mantegazza Integrazione Tra Apparato Respiratorio E Cardiovascolare L’obiettivo dell’attività respiratoria non è solo ventilare i polmoni, ma garantire l’omeostasi dei gas nei tessuti periferici. Questo traguardo non può essere raggiunto dalla respirazione da sola: è necessaria una sinergia continua con il sistema cardiovascolare. La regolazione della frequenza respiratoria deve coordinarsi con variazioni della portata cardiaca e della perfusione locale per essere efficace. A livello polmonare, piccole variazioni locali nella PO₂ alveolare influenzano la perfusione capillare. Le aree con PO₂ più alta ricevono più sangue Migliora così l’efficienza dello scambio gassoso. Questa regolazione fine garantisce che ventilazione e perfusione siano ben bilanciate a livello dei lobuli polmonari. Quando i chemocettori sono stimolati (es. ↑CO₂, ↓O₂), ↑ Frequenza respiratoria, ↑ Pressione arteriosa sistemica, ↑ Gittata cardiaca e questo comporta un'azione sinergica per aumentare l’apporto di ossigeno ai tessuti. I barocettori polmonari, invece, attraverso il riflesso inspiratorio aumentano la frequenza cardiaca, facilitano un maggior ritorno venoso e un incremento del flusso ematico alveolare. Ogni atto respiratorio profondo è accompagnato da un aumento della gittata cardiaca, ottimizzando il trasporto dell’ossigeno. In alta quota la PO₂ alveolare si riduce fisiologicamente (Es. a 3300 m: PO₂ ≈ 60 millimetri Hg). Abitanti di Denver o Città del Messico: PO₂ ≈ 80–90 millimetri Hg. Nonostante ciò, milioni di persone vivono in modo stabile a queste altitudini, grazie a meccanismi adattativi, che comprendono ↑ Frequenza respiratoria, ↑ Frequenza cardiaca, ↑ Produzione di BPG (2,3-bisfosfoglicerato (facilita il rilascio di O₂ ai tessuti), ↑ Ematocrito (più emoglobina disponibile). Anche se la saturazione di emoglobina è ridotta, la quantità assoluta di ossigeno nel sangue aumenta, e la velocità di circolazione accelera (migliorando la distribuzione del gas ai tessuti). Questi adattamenti non sono immediati: servono giorni o settimane per stabilizzarsi. Per gli atleti, allenarsi in alta quota in anticipo è cruciale. L’organismo ha bisogno di tempo per adattare la ventilazione e la perfusione, aumentare l’efficienza dell’apporto di ossigeno, evitare cali di performance legati all’ipossia. Il controllo della respirazione non può essere considerato in modo isolato. I meccanismi respiratori e cardiovascolari cooperano costantemente per adattarsi alle condizioni locali e sistemiche, mantenendo stabili i livelli di ossigeno e anidride carbonica nel sangue e nei tessuti..