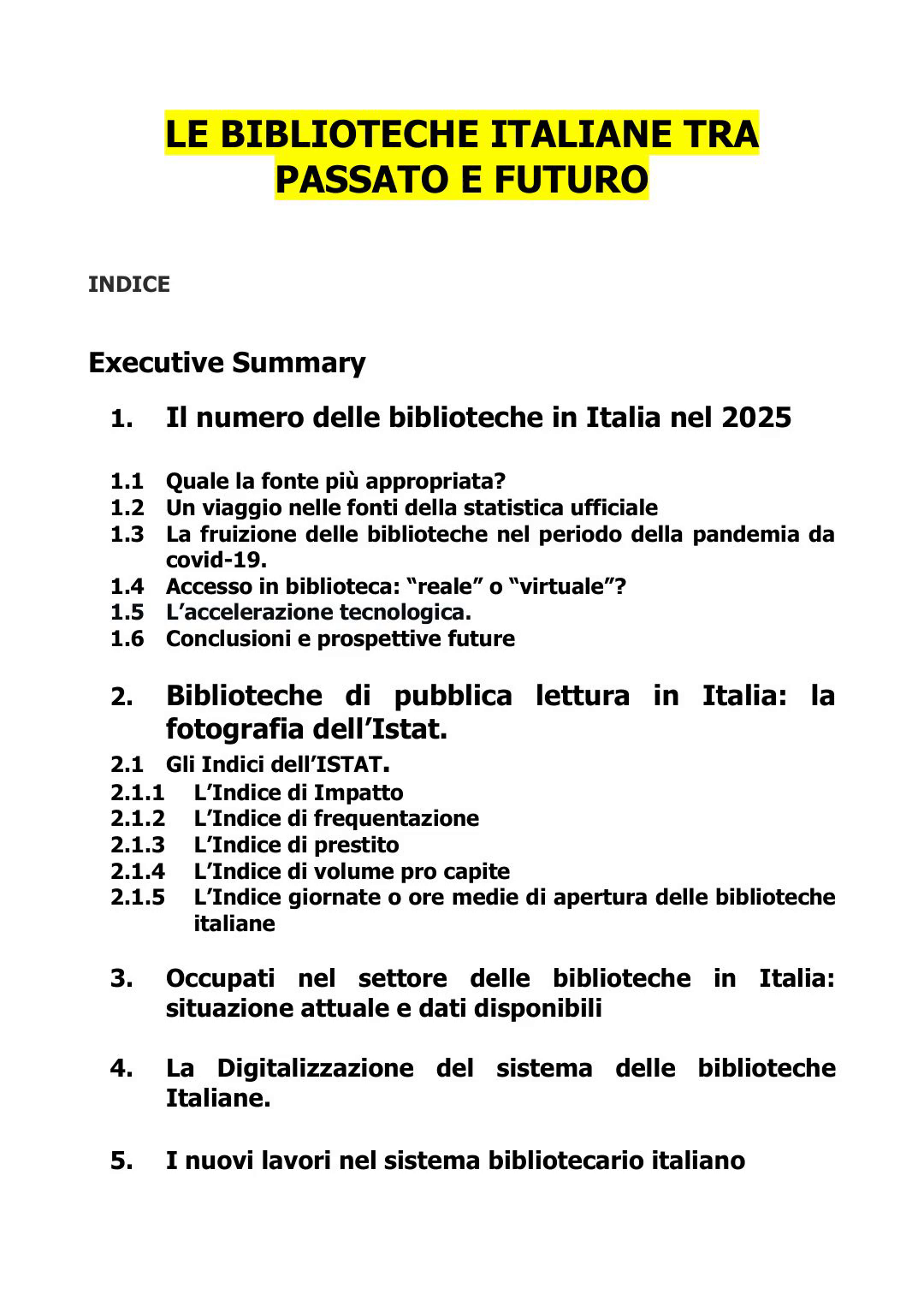Scene 1 (0s)
LE BIBLIOTECHE ITALIANE TRA PASSATO E FUTURO INDICE Executive Summary 1. Il numero delle biblioteche in Italia nel 2025 1.1 Quale la fonte più appropriata? 1.2 Un viaggio nelle fonti della statistica ufficiale 1.3 La fruizione delle biblioteche nel periodo della pandemia da covid-19. 1.4 Accesso in biblioteca: “reale” o “virtuale”? 1.5 L’accelerazione tecnologica. 1.6 Conclusioni e prospettive future 2. Biblioteche di pubblica lettura in Italia: la fotografia dell’Istat. 2.1 Gli Indici dell’ISTAT. 2.1.1 L’Indice di Impatto 2.1.2 L’Indice di frequentazione 2.1.3 L’Indice di prestito 2.1.4 L’Indice di volume pro capite 2.1.5 L’Indice giornate o ore medie di apertura delle biblioteche italiane 3. Occupati nel settore delle biblioteche in Italia: situazione attuale e dati disponibili 4. La Digitalizzazione del sistema delle biblioteche Italiane. 5. I nuovi lavori nel sistema bibliotecario italiano.
Scene 2 (41s)
[Audio] 5.1 Evoluzione del profilo del bibliotecario in Italia: nuove competenze per una professione in trasformazione 5.2 Evoluzione del profilo del bibliotecario in Italia: nuove competenze per una professione in trasformazione. 5.3 Nuove figure professionali nelle biblioteche italiane 6. Verso le biblioteche del futuro: più di semplici luoghi di libri 6.1 Dalla casa dei libri alla casa di comunità 6.2 La rivoluzione digitale non esclude nessuno 6.3 Biblioteche come medicina sociale 6.4 I nuovi abitanti delle biblioteche 6.5 Il bibliotecario del futuro: un facilitatore di comunità 6.6 Storie di trasformazione dal territorio 6.7 Le sfide che ci aspettano 6.8 Un futuro che è già presente 6.9 Il cuore pulsante della società Executive Summary Il sistema bibliotecario italiano si trova oggi in una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da sfide e opportunità che ridefiniscono il panorama culturale nazionale. Secondo i dati più aggiornati dell'Anagrafe delle biblioteche italiane gestita dall'ICCU, al 31 dicembre 2024 risultano censite 13.639 biblioteche, rappresentando il database più completo del patrimonio bibliotecario nazionale. Questo numero include una vasta gamma di tipologie istituzionali: dalle 7.175 biblioteche di enti territoriali alle 1.183 universitarie statali, dalle 1.225 di enti ecclesiastici alle altre categorie specializzate che completano il quadro nazionale. La distribuzione geografica rivela uno squilibrio territoriale significativo, con il Nord Italia che ospita il 60,2% delle biblioteche di pubblica lettura, seguito dal Mezzogiorno con il 27,2% e dal Centro con il 12,6%. Questa disparità territoriale si riflette in modo evidente anche negli indicatori di performance e fruizione, configurando un paese a due velocità nel settore bibliotecario. La pandemia da COVID-19 ha rappresentato uno spartiacque per il sistema bibliotecario italiano, causando una contrazione senza precedenti nella fruizione delle biblioteche. Se fino al 2019 la fruizione si era consolidata attorno al 15,0% della popolazione di 3 anni e più, il crollo è stato drammatico e progressivo: nel 2020 si è registrata una flessione a 12,4%, mentre nel 2021 il dato è precipitato al 7,4%, dimezzando di fatto l'utenza rispetto al periodo pre-pandemico. Il 2022 ha segnato l'inizio di una ripresa ancora parziale, con la quota di utenti che si è attestata al 10,2%, recuperando quasi 3 punti percentuali rispetto al 2021 ma rimanendo ancora distante di 5,1 punti percentuali dai livelli del 2019. Particolarmente colpiti sono stati.
Scene 3 (4m 5s)
[Audio] i giovani di 6-24 anni, tradizionalmente la fascia più attiva nell'utilizzo delle biblioteche, i cui comportamenti di studio sono stati profondamente modificati dalle chiusure prolungate di scuole e università. Paradossalmente, proprio durante la pandemia ha preso avvio un processo di accelerazione digitale straordinario che ha trasformato radicalmente il panorama bibliotecario. I dati quantitativi parlano chiaro: confrontando i primi quattro mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2019, si sono registrati incrementi senza precedenti in tutti i servizi digitali. La piattaforma MLOL (Media Library OnLine), che rappresenta la principale rete italiana di biblioteche digitali con oltre 5.000 biblioteche aderenti, ha registrato incrementi superiori al 100% negli accessi utenti (+111,6%), negli utenti unici (+114,8%) e nei prestiti e-book (+122,4%). Contrariamente alle aspettative di un ridimensionamento post-emergenziale, questa crescita si è consolidata negli anni successivi. Il 2024 ha registrato un ulteriore incremento del 6,3% rispetto al 2023, con la piattaforma MLOL che ha totalizzato 19.642.544 transazioni, oltre un milione in più rispetto all'anno precedente. Questa trasformazione digitale non rappresenta più un fenomeno emergenziale, ma una trasformazione strutturale che ha ridefinito il rapporto tra cittadini e servizi bibliotecari. L'analisi degli indicatori ISTAT rivela un quadro di forte eterogeneità territoriale nelle performance del sistema bibliotecario italiano. L'indice di impatto nazionale, che misura la percentuale di iscritti al prestito rispetto alla popolazione residente, si attesta al 9,2% nel 2022, con variazioni regionali significative che spaziano dal 20,9% della Valle d'Aosta al 2,4% della Campania. Il Piemonte si posiziona in una fascia intermedia con un indice di impatto del 10,6%, superiore alla media nazionale ma ancora lontano dai livelli pre-pandemici quando raggiungeva il 19,3%. Questa performance si colloca all'8° posto nazionale, evidenziando una situazione di sostanziale tenuta rispetto ad altre regioni ma con margini di miglioramento significativi. L'indice di frequentazione, che misura il rapporto tra visite annue e popolazione residente, presenta una situazione ancora più critica. La media nazionale si attesta a 0,6 visite per abitante, mentre il Piemonte raggiunge solo 0,5, posizionandosi al 10° posto nazionale. Questo dato evidenzia criticità strutturali nell'accessibilità fisica alle biblioteche, con orari di apertura limitati, carenze infrastrutturali e disparità territoriali significative. Il settore bibliotecario italiano occupa oltre 26.000 addetti nelle sole biblioteche di pubblica lettura, secondo i dati ISTAT 2022. Tuttavia, la composizione del personale rivela una precarietà strutturale preoccupante: il 31,7% è composto da volontari, il 30,4% da personale interno dipendente, mentre il restante 37,9% si divide tra operatori di ditte esterne, operatori del servizio civile e consulenti. Questa frammentazione riflette un sistema caratterizzato da un elevato grado di esternalizzazione e precarizzazione. Oltre il 68% del personale lavora con forme contrattuali atipiche o non retribuite, situazione che genera turnover elevato, difficoltà nella programmazione dei servizi e demotivazione del personale qualificato. Particolarmente.
Scene 4 (8m 37s)
[Audio] critica è la situazione delle biblioteche statali, dove il personale è stato ridotto da 779 a circa 310 bibliotecari negli ultimi anni. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un punto di svolta decisivo per la digitalizzazione delle biblioteche italiane. L'investimento M1C3 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" prevede un finanziamento di 500 milioni di euro suddivisi in 12 sub-investimenti, mentre per il 2025 sono previsti 54,8 milioni di euro per biblioteche ed editoria, raddoppiando rispetto ai 24,8 milioni del 2024. La Digital Library, istituita nel 2020 all'interno del Ministero della Cultura, ha elaborato il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale per il quinquennio 2022-2026, articolando la strategia in quattro ambiti principali: servizi abilitanti, servizi di produzione, servizi di conservazione e servizi di accesso. Questa visione strategica sta posizionando l'Italia come protagonista nel panorama internazionale dell'innovazione bibliotecaria digitale. Il settore sta vivendo una trasformazione professionale epocale. Da un lato emergono figure tradizionali in estrema difficoltà: catalogatori minacciati dall'automazione, addetti al prestito sostituiti da sistemi automatizzati, bibliotecari anziani con difficoltà nell'adattamento alle tecnologie digitali. Dall'altro si stanno affermando nuove figure professionali altamente specializzate: Data Librarian per la gestione dei dati della ricerca, Digital Librarian per la gestione della complessità digitale, Electronic Resources Librarian per le risorse elettroniche, AI Librarian per l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Questa trasformazione richiede investimenti significativi nella formazione continua del personale esistente e nella creazione di nuovi percorsi formativi specialistici. L'Associazione Italiana Biblioteche ha identificato 12 profili professionali che riflettono questa diversificazione, delineando un ecosistema professionale più articolato e specializzato. Il sistema bibliotecario italiano si trova a un bivio cruciale. La trasformazione digitale accelerata dalla pandemia, sostenuta dagli investimenti del PNRR e accompagnata dall'evoluzione delle professioni, offre opportunità senza precedenti per ridefinire il ruolo delle biblioteche nella società contemporanea. Tuttavia, questa evoluzione deve affrontare sfide strutturali significative: la riduzione del divario territoriale Nord-Sud, l'aggiornamento delle competenze professionali, il mantenimento dell'equilibrio tra innovazione tecnologica e missione sociale. Il futuro delle biblioteche italiane si delinea sempre più ibrido e integrato, con spazi polifunzionali dove la tecnologia digitale si integra con la dimensione fisica e sociale. Per realizzare questa visione sarà necessario un intervento coordinato su più fronti: investimento massiccio in formazione continua del personale, standardizzazione degli orari di apertura su tutto il territorio, potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nelle aree periferiche, riforma normativa per adeguare la governance ai nuovi scenari, e sviluppo di metriche qualitative oltre agli indicatori quantitativi tradizionali..
Scene 5 (12m 29s)
[Audio] La sfida principale per i prossimi anni sarà mantenere l'equilibrio tra innovazione e tradizione, garantendo che la digitalizzazione non sia fine a se stessa ma strumento per una maggiore accessibilità, inclusione e partecipazione culturale. In questo contesto, le biblioteche devono evolversi da custodi statici del sapere a centri dinamici di innovazione culturale e sociale, mantenendo al centro la loro missione di democratizzazione dell'accesso alla cultura e alla conoscenza. Il numero delle biblioteche in Italia nel 2025. Secondo i dati più aggiornati disponibili, l'Anagrafe delle biblioteche italiane gestita dall'ICCU censisce 13.639 biblioteche al 31 dicembre 2024, rappresentando il database più completo del patrimonio bibliotecario nazionale.1 Il dato di 13.639 biblioteche si riferisce alla fine del 2024 e rappresenta l'informazione più aggiornata disponibile per l'inizio del 2025. Questo numero include tutte le tipologie di biblioteche censite nell'Anagrafe: biblioteche di enti territoriali (7.175), universitarie statali (1.183) e di altre istituzioni.2 È importante notare che esistono diverse fonti con numeri leggermente diversi: ISTAT - Censimento biblioteche pubbliche e private: Nel 2022 ha censito 8.131 biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico. Questa rilevazione esclude le biblioteche scolastiche e universitarie e si concentra specificamente su quelle che offrono servizi regolari al pubblico. Anagrafe ICCU3: Conta 13.639 biblioteche (dato 2024), includendo come precedentemente ricordato una gamma più ampia di tipologie: statali, comunali, universitarie, scolastiche, ecclesiastiche, di accademie e fondazioni. Del totale censito nell'Anagrafe, la distribuzione per macro-categorie comprende: 7.175 biblioteche di enti territoriali, 1.183 biblioteche universitarie statali, 1.225 biblioteche di enti ecclesiastici e Altre tipologie per il completamento del totale. Il sistema di censimento è in continua evoluzione. L'ISTAT conduce dal 2019 un censimento annuale sistematico che coinvolge oltre 9.000 biblioteche, mentre l'Anagrafe dell'ICCU viene aggiornata costantemente attraverso protocolli d'intesa con Regioni, Ministero della Cultura 1 Anagrafe delle Biblioteche Italiane al 31 dicembre 2024 2 I dati vengono aggiornati regolarmente attraverso diversi canali. Gli Aggiornamenti regionali: nel dicembre 2024 sono stati aggiornati i dati di 1.580 istituti grazie al contributo delle Regioni e Province autonome. Le Integrazioni ecclesiastiche: Nel febbraio 2024 sono state aggiunte 639 biblioteche dall'Anagrafe delle Istituzioni Culturali Ecclesiastiche (AICE). I Dati regionali specifici: Ad esempio, 424 biblioteche della Campania sono state aggiornate nel maggio 2024. 3 L'acronimo ICCU sta per Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche..
Scene 6 (16m 17s)
[Audio] e altri enti. Per il 2025, il numero più attendibile e aggiornato rimane quello dell'Anagrafe delle biblioteche italiane con 13.639 biblioteche censite, dato che rappresenta la fonte più completa e sistematicamente aggiornata del patrimonio bibliotecario nazionale. Quale la fonte più appropriata? La scelta della fonte più appropriata dipende strettamente dagli obiettivi specifici dell'analisi che intende condurre. Entrambe le fonti principali - ISTAT e ICCU presentano caratteristiche metodologiche distinte che le rendono più adatte per diversi tipi di ricerca. L'indagine ISTAT rappresenta la fonte più rigorosa dal punto di vista metodologico per gli studi statistici ufficiali. È condotta attraverso un Protocollo d'Intesa tra ISTAT, Ministero della Cultura, Regioni e Province autonome, con le seguenti caratteristiche: Punti di forza metodologici: rilevazione censuaria obbligatoria con questionario online standardizzato; tasso di risposta elevatissimo del 97,3%; controlli di qualità rigorosi: verifica telefonica delle non risposte, correzioni deterministiche, confronto con fonti multiple; coordinamento istituzionale strutturato con Comitato tecnico-scientifico; metodologia costante nel tempo per analisi longitudinali (2019, 2020, 2022). Questa fonte ha dei limiti perché esclude biblioteche universitarie e scolastiche. Il focus limitato alle sole strutture aperte al pubblico e la frequenza triennale degli aggiornamenti. L'Anagrafe ICCU invece, costituisce la fonte più completa per la mappatura del sistema bibliotecario soprattutto per la copertura totale di tutte le tipologie: statali, comunali, universitarie, scolastiche, ecclesiastiche, per l'aggiornamento continuo attraverso sistema partecipato, per la visione d'insieme completa del panorama bibliotecario nazionale e per la Interoperabilità con sistemi regionali ed ecclesiastici. Anche in questo caso ci sono dei limiti soprattutto per l'aggiornamento volontario non sistematico; per i controlli di qualità meno rigorosi rispetto a ISTAT e per possibili disomogeneità nei dati per la natura partecipata. Rispetto all'oggetto dell'analisi trattato che riguarda le Policy pubbliche la fonte più appropriata per indagare in profondità rimane l'ISTAT infatti i suoi dati sono innanzitutto certificati per usi governativi,4 ha una metodologia rigorosa conforme agli standard internazionali5 e soprattutto possiede indicatori standardizzati per valutazioni comparative.6 Un viaggio nelle fonti della statistica ufficiale. La biblioteca è un presidio culturale: è, come è stata già definita, una piazza del sapere7 un territorio aperto a individui, gruppi, associazioni, spazio di comunità e centro di riflessione e di condivisione del sapere; un nodo, insieme ad altri nodi, di una rete di istituzioni culturali. Quando si parla di biblioteche si fa riferimento a concetti differenti che rimandano a spazi fisici, ma non solo, che delimitano attività, incontri, forme ed espressioni di socialità e partecipazione. La biblioteca è stata per lungo tempo presente solo in modo residuale all'interno dell'agenda della statistica ufficiale in Italia. Tornando indietro nel tempo, infatti, in un viaggio tra le fonti della statistica, troviamo già a partire dai primi anni '50 vari segnali 4 La ricerca di dati statistici nel web in Università degli studi di Padova.it 5 Alessandra Federici, "Indagine sulle biblioteche pubbliche e private" in Istat del Dicembre 2022. 6 La Redazione, "Le biblioteche di pubblica lettura in Italia" Nota informativa Istat del 2 luglio 2024. 7 Agnoli A. 2009. Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà. Bari, Italia: Laterza..
Scene 7 (20m 44s)
[Audio] di interesse verso il monitoraggio della produzione libraria (lato offerta culturale) e dei comportamenti di lettura e di impiego del tempo libero (lato domanda culturale) che vengono monitorati e che via via diventano parte integrante di rilevazioni statistiche condotte a cadenza sempre più costante. Più sporadica e occasionale è stata, invece, la raccolta di informazioni sulla fruizione delle biblioteche e sull'offerta di biblioteche presenti sul territorio. In particolare, per quanto riguarda la fruizione delle biblioteche, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) inizia a condurre le sue indagini a partire dal 2000, inserendo alcune domande specifiche all'interno del questionario dell'indagine su partecipazione culturale e tempo libero "I cittadini e il tempo libero-Anno 2000" 8. Questa indagine, condotta su individui e famiglie, rileva per la prima volta, per tutte le persone di 11 anni e più, la fruizione delle biblioteche9, il numero di volte in cui si è andati in biblioteca, se per svago o per studio/lavoro e l'avere effettuato una serie di attività durante le visite. Successivamente la stessa indagine verrà condotta nel 2006 e nel 2015.10 Nel tempo cresce l'interesse verso il tema: nel 2015 si abbassa la soglia di età per misurare la fruizione e le informazioni vengono rilevate a partire dai 6 anni e, oltre a questo, viene ampliata la lista di attività svolte in biblioteche che vengono rilevate e, per la prima volta, si rileva anche la fruizione dei servizi on line offerti dalle biblioteche. Si tratta comunque fino a questo momento ancora di indagini occasionali che non prevedono un monitoraggio costante nel tempo del fenomeno. La svolta in questo senso arriva nel 2019, quando l'Istat inizia a monitorare con cadenza annuale la fruizione delle biblioteche inserendo un set di quesiti all'interno dell'indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana" nella quale si chiede, a tutte le persone di 3 anni e più 11, se, nei 12 mesi precedenti l'intervista si sono recate in una biblioteca, quante volte e per svolgere quali attività12. Cosa molto importante, poiché la raccolta di informazioni si rivolge anche alla fascia dei più piccoli di 3-10 anni, si espandono le attività svolte in biblioteca che vengono rilevate, comprendendo anche attività notoriamente rivolte ai più piccoli (corsi, gioco, aiuto compiti, ...). Quello compiuto nel 2019 è un vero e proprio giro di boa, un cambiamento molto rilevante sia perché si calendarizza un'indagine che annualmente rileverà la fruizione e si amplia il target di popolazione di riferimento, sia perché si comincia ad affermare anche in ambito statistico l'idea secondo la quale le biblioteche sono un presidio culturale rilevante, un'agenzia culturale che, insieme alla scuola, alle università ed alle altre infrastrutture culturali, è parte fondante di una comunità, fonte di benessere per famiglie ed individui e che è necessario monitorare nel tempo in modo costante. La disponibilità di dati annuali ha avuto come effetto ulteriore il transito dell'indicatore della fruizione all'interno del progetto Istat BES che, a partire dal 2013, vuole superare il PIL per definire il benessere della 8 Istituto Nazionale di Statistica Istat (a cura di). 2002. Letture e linguaggio. Roma, Italia: Istat. 9 Si rileva la fruizione negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista. Non viene data una definizione specifica di cosa si debba intendere per biblioteca, comprendendo quindi sia le biblioteche pubbliche che private, le biblioteche scolastiche... 10 Attualmente si sta riprogrammando la prossima edizione per il.
Scene 8 (24m 53s)
[Audio] popolazione attraverso il consolidamento di 12 domini di interesse per un totale di più di 150 indicatori.13 Riguardo, invece, alle statistiche sull'offerta di biblioteche sul territorio, la prima rilevazione risale al 1927 e successivamente altre rilevazioni sono state condotte occasionalmente e si sono susseguite fino al 1972. Dopo molto tempo da allora, nel 2019, l'Istat ha iniziato a realizzare una rilevazione a carattere censuario e con cadenza annuale (8), in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico (Iccu), le Regioni e le Province Autonome, finalizzata a rilevare e diffondere informazioni sulle biblioteche pubbliche e private, escluse le biblioteche scolastiche e delle università, per aggiornare l'anagrafica delle biblioteche italiane attraverso una mappatura esaustiva e dettagliata delle biblioteche presenti sul territorio nazionale, raccogliendo, verificando e integrando i dati identificativi disponibili e fornendo una descrizione delle loro caratteristiche strutturali e funzionali, del patrimonio posseduto, delle attività svolte, dell'utenza e dei servizi erogati.14 La fruizione delle biblioteche nel periodo della pandemia da covid-19. La chiusura delle biblioteche, protrattasi a lungo durante il periodo pandemico,15 ha determinato a partire dal 2020 una forte riduzione dei livelli di fruizione. Se, infatti, fino al 2019 la fruizione delle biblioteche si era consolidata con una quota di circa il 15% tra le persone di 3 anni e più,16 si segnala dapprima nel 2020 una flessione di quasi 3 punti percentuali (si arriva al 12,4%) e successivamente nel 2021 una ulteriore riduzione che porta il numero di fruitori a dimezzarsi rispetto al periodo precovid (7,4%). Negli anni della pandemia il crollo è stato trasversale tra gli utenti di tutte le zone del Paese, mantenendo pressoché inalterata la geografia della fruizione con livelli più elevati nelle regioni del Centro-nord del Paese rispetto a quelle del Mezzogiorno. Inoltre, le riduzioni hanno interessato sia gli uomini sia le donne, ma queste ultime, come in passato, si sono mantenute le maggiori fruitrici. Sia nel 2020 sia nel 2021, le diminuzioni hanno interessato 13 Istituto Nazionale di Statistica – Istat. La misurazione del benessere (BES): https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes) 14 L'indagine sulle "Biblioteche pubbliche e private" (IST-02777) è realizzata nella cornice del "Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi di cultura", siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni da Istat, MiC, Regioni e Province autonome di Trento (Ispat) e di Bolzano (Astat), e in stretta collaborazione con la CEI – Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto, che ha fornito i dati degli istituti di enti ecclesiastici raccolti nell'ambito delle proprie attività istituzionali. L'indagine è condotta annualmente grazie anche alla convenzione stipulata tra Istat e l'Autorità di Gestione del PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", relativa all'attuazione del Progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020", che vede nel ruolo di soggetti proponenti l'Istat e il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione(NUVAP). https://www.istat.it/it/archivio/217094 15 Sono oggetto della rilevazione le biblioteche di pubblica lettura, le biblioteche specializzate, purché aperte anche ad un pubblico esterno, e quelle di conservazione. Sono escluse dalla rilevazione tutte le biblioteche che non prevedono servizio al pubblico, quelle che consentono esclusivamente un accesso e una fruizione interna o.
Scene 9 (29m 33s)
[Audio] principalmente i giovani di 6-24 anni, il target di età generalmente con i livelli di fruizione più elevati. Ciò e avvenuto anche a causa della chiusura delle scuole e delle Università, specialmente nei primi periodi della pandemia, che ha sicuramente prodotto dei cambiamenti nelle abitudini di studio di bambini e ragazzi. Le riduzioni registrate tra gli utenti più giovani hanno eroso la distanza rispetto agli utenti adulti ed anziani, determinando un appiattimento della curva di fruizione per età, con un conseguente livellamento verso il basso dei livelli di fruizione17. La ripresa della fruizione nel post pandemia. Nel 2022, la quota di utenti delle biblioteche si attesta al 10,2%, recuperando quasi 3 punti percentuali 18 rispetto al 2021, ma rimanendo ancora distante dal livello pre-pandemia (-5,1 punti percentuali rispetto al 2019). Anche nel 2022 si conferma più elevata la prevalenza di donne che si sono recate in biblioteca: l'11,7% a fronte dell'8,6% degli uomini, con differenze di genere più ampie tra i giovani di 15-24 anni (+12,1 punti percentuali). Malgrado la ripresa, nel 2022, rispetto al pre-pandemia, le prevalenze risultano più ridotte per i giovani e i giovanissimi di 6-24 anni, che, comunque, continuano a frequentare le biblioteche in misura maggiore rispetto al resto della popolazione (con quote pari al 37,0% nel 2019 e al 23,5% nel 2022). A partire dai 25 anni, invece, la fruizione diminuisce significativamente, riducendosi ulteriormente nelle fasce di età successive. Anche nel 2022 la fruizione delle biblioteche è più elevata nelle regioni del Nord (13,9%) rispetto a quelle del Centro (9,2%) e soprattutto del Mezzogiorno (5,7%), sebbene la ripresa della fruizione delle biblioteche si sia osservata in modo trasversale in tutte le zone del Paese.19 Nel complesso, le attività più diffuse tra gli utenti delle biblioteche sono "prendere libri in prestito" (57,6%), "leggere o studiare" (37,2%) e "raccogliere informazioni" (22,2%). Tuttavia, i motivi della fruizione si diversificano ampiamente in base all'età. L'attività del prendere libri in prestito è svolta con prevalenza più alta dai giovani utenti fino a 14 anni e dagli anziani di 65-74 anni (circa 7 su 10). Al contrario, si recano in biblioteca per leggere o studiare prevalentemente i giovani tra 15 e 34 anni, con picchi che superano l'80,0% tra i 20-24enni. Tra i motivi meno diffusi troviamo, invece, "incontrare gli amici" (7,7%; 20,5% tra i giovani utenti di 20-24 anni), "partecipare a conferenze, dibattiti, lezioni, ..." e "consultare quotidiani/riviste" (entrambi circa il 7,0% degli utenti). Accesso in biblioteca: "reale" o "virtuale"? 17 Istituto Nazionale di Statistica-Istat. 2019. "Produzione e lettura di libri in Italia. Anno 2018". Statistiche Report. Roma. https://www.istat.it/it/files/2019/12/Report-Produzione-lettura-libri-2018.pdf 18 Istituto Nazionale di Statistica- Istat. 2022. Bes 2021. Il benessere equo e sostenibile in Italia. Roma, Italia: Istat. 19 Nell'analisi temporale, per il confronto tra stime si considera la distanza tra le prevalenze in punti percentuali..
Scene 10 (33m 50s)
[Audio] Durante il periodo pandemico l'accesso on-line alle biblioteche ha in parte mitigato le difficoltà di fruizione e partecipazione in presenza. Nel 202120 la quota di persone di 6 anni e più che ha effettuato un accesso "in presenza" o "virtuale" alle biblioteche è stata dell'11,7%. Di questi, il 6,8% ha effettuato almeno un accesso on-line (per consultare cataloghi, libri, prenotare prestiti o altro), mentre il 4,8% ha usufruito dei servizi bibliotecari recandosi fisicamente nella struttura. Nel 2022, l'accesso totale ha registrato un aumento di 1,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 13,5%. Ad aumentare sono stati gli accessi non virtuali, passati dal 4,8% del 2021 al 7,2% del 2022. È rimasta pressoché stabile, invece, la quota di coloro che hanno usufruito di servizi bibliotecari online, pari al 6,4%. L'accelerazione tecnologica. Nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, l'utilizzo dei servizi digitali delle biblioteche italiane ha registrato una crescita straordinaria, rappresentando una delle trasformazioni più significative mai registrate nel settore bibliotecario nazionale. L'accelerazione digitale innescata dalla pandemia COVID-19 non solo si è mantenuta negli anni successivi, ma ha continuato a espandersi, consolidando un cambiamento strutturale nelle abitudini di fruizione culturale degli italiani. I primi segnali dell'esplosione digitale si sono manifestati già nei primi mesi del 2020. Un'indagine condotta dall'Associazione Italiana Biblioteche su oltre 1.134 biblioteche italiane ha documentato come l'85% delle strutture abbia fornito esclusivamente materiale elettronico durante il lockdown, mentre solo il 6% ha continuato a offrire materiale cartaceo.21 I dati quantitativi raccolti confrontando i primi quattro mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2019 mostrano incrementi senza precedenti. Servizio Incremento Percentuale MLOL - Accessi utenti +111,56% MLOL - Utenti unici +114,77% MLOL - Prestiti e-book +122,40% MLOL - Prestiti altri media +127,22% Internet Culturale - Visite +116,25% Rete Indaco - Prestiti digitali +234,61% Torrossa - Visualizzazioni online +280% 20 Istituto Nazionale di Statistica – Istat. 2023. "Lettura di libri e fruizione delle biblioteche". Statistica Today. Roma. https://www.istat.it/it/files//2023/05/STATISTICA_TODAY_Libri_biblioteche.pdf 21 Silvia Giannini, Stefania Lombardi e Anna Molino, "Le biblioteche italiane durante la pandemia Covid 19: una indagine sui servizi" Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Innovazione A. Faedo" CNR ISTI TR 2020/012..
Scene 11 (37m 43s)
[Audio] La piattaforma MLOL (Media Library OnLine), che rappresenta la principale rete italiana di biblioteche digitali con oltre 5.000 biblioteche aderenti, ha registrato più che un raddoppio degli accessi e dei prestiti digitali già nel 2020.22 Contrariamente alle aspettative di un ridimensionamento post-emergenziale, i dati successivi hanno dimostrato una consolidazione e un'ulteriore crescita dei servizi digitali bibliotecari. La piattaforma MLOL, operando in 19 regioni italiane, fornisce una prospettiva nazionale della crescita digitale. Il 2024 ha registrato una crescita del 6,3% rispetto al 2023, passando da 18.479.726 transazioni a 19.642.544, con oltre un milione di prestiti aggiuntivi. La trasformazione digitale delle biblioteche italiane appare irreversibile. Come evidenziato dall'indagine CNR del 2020, la maggioranza dei bibliotecari ritiene che questa situazione "influenzerà significativamente il mondo delle biblioteche, digitali o meno, dopo la pandemia". I dati 2024 confermano questa previsione: la crescita del digitale non rappresenta più un fenomeno emergenziale, ma una trasformazione strutturale che ha ridefinito il rapporto tra cittadini e servizi bibliotecari, creando nuove opportunità di accesso alla cultura e alla conoscenza per milioni di italiani. La digitalizzazione delle biblioteche ha dimostrato di essere non solo una risposta efficace all'emergenza sanitaria, ma un'evoluzione naturale e necessaria dei servizi bibliotecari nel XXI secolo, capace di ampliare significativamente la base di utenti e di democratizzare l'accesso alle risorse culturali e informative.23 Conclusioni e prospettive future. Le Biblioteche occupano finalmente un posto di rilievo nell'ambito della statistica ufficiale. Il percorso compiuto, che ha attribuito loro sempre più importanza, si è concretizzato nella realizzazione periodica (e non una tantum) di rilevazioni ad hoc sia della domanda sia dell'offerta. La possibilità di avere dati periodici e aggiornati incoraggia nella possibilità di poter effettuare un monitoraggio costante che metta insieme le due prospettive che, se integrate, possono dare una visione complessiva delle biblioteche nel nostro Paese. I dati analizzati hanno messo in evidenza gli effetti che la pandemia ha avuto sulla fruizione delle biblioteche che si è notevolmente ridotta nel biennio 2020-2021, specialmente tra i più giovani, notoriamente gli utenti più affezionati. Ancora nel 2022 non si è segnalato un ritorno al livello di utenza pre-pandemia, bisognerà vedere cosa accadrà nel prossimo futuro. 22 Alessandra Rotondo, "Nel 2020 il prestito digitale è cresciuto del 100%. Le potenzialità degli editori" in Giornale della libertà.it del 26 gennaio 2021. 23 Giulio Blasi, "Report MLOL 2024. Dati e Tendenze del 17 marzo 2025.
Scene 12 (41m 19s)
[Audio] Molti ancora i temi da esplorare, ad esempio la rilevazione delle biblioteche scolastiche e della loro utenza e un approfondimento maggiore della fruizione on line,24 per citare solo alcune delle dimensioni che rimangono sullo sfondo dell'agenda della statistica ufficiale. Biblioteche di pubblica lettura in Italia: la fotografia dell'Istat. Nel 2022, delle 8.131 biblioteche pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale, quasi otto su 10 (77,0%) sono di pubblica lettura, svolgono cioè una funzione orientata prevalentemente alla comunità locale del proprio territorio. Quasi tutte (92,0%) sono gestite da enti locali. E' quanto emerge dal focus "Biblioteche di pubblica lettura in Italia" diffuso dall'Istat che rileva anche come le biblioteche di pubblica lettura conservano e rendono accessibile agli utenti un patrimonio quantificabile in 166.950.000 unità; oltre la metà delle biblioteche (59,9%) possiede più di 10.000 volumi. Rispetto all'anno precedente, nel 2022 il patrimonio bibliotecario è aumentato del 6,0%. Dal focus emerge che la maggiore quota di biblioteche di pubblica lettura è localizzata al Nord (60,2%), seguono il Mezzogiorno (27,2%) e il Centro (12,6%). Le prime cinque Regioni per numero di strutture presenti sul territorio sono: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna. Complessivamente ci sono circa tre biblioteche ogni 100 km, con una media di una ogni 8.500 abitanti. Due Comuni italiani su tre (66,3%) hanno almeno una biblioteca di pubblica lettura. La metà delle strutture è nei piccoli e piccolissimi Comuni, con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; il 32,5% è in Comuni di medie dimensioni, dai 5 ai 30.000 abitanti. Nel 2022 più della metà delle biblioteche di pubblica lettura (57,5%) è stata aperta agli utenti per circa 200 giorni su 252 giorni lavorativi; la maggioranza (84,8% del totale) ha prestato servizio al pubblico con orario prestabilito per 4 o 5 giorni settimanali (52,0%). Viene anche evidenziato che a fronte di maggiori risorse finanziare disponibili, quasi un terzo delle biblioteche promuoverebbe attività volte a coinvolgere il territorio (30,3%) e organizzerebbe incontri ed eventi culturali per ampliare l'offerta culturale (29,2%). Le biblioteche maggiormente orientate a interagire con il territorio sono quelle dei Comuni più piccoli, fino a 10.000 abitanti. Tra le altre evidenze: un terzo dei Comuni italiani (33,7%) non ha alcuna biblioteca né di pubblica lettura né di altro tipo. La maggioranza di questi Comuni appartiene alle cinture dei grandi Centri e alle Aree intermedie (69,7%) mentre il restante 30,3% è in posizione periferica o ultraperiferica rispetto ai poli urbani, ricchi di servizi e infrastrutture.25 Gli Indici dell'ISTAT. L'ISTAT pubblica regolarmente un dataset dedicato con 17 indicatori specifici sulle biblioteche e produce report annuali di approfondimento statistico sul tema delle biblioteche di pubblica lettura. Qui esamineremo i sei Indici più importanti. 24 I dati relativi alla fruizione on line dei servizi bibliotecari sono stati rilevati per la prima volta nel 2021. Non è possibile quindi effettuare un confronto con il periodo prepandemico. 25 La Redazione, "Le Biblioteche di pubblica lettura in Italia – Anno 2022", in Statistiche Focus Istat del 1luglio 2024..
Scene 13 (45m 43s)
[Audio] L' Indice di impatto. Gli indicatori di impatto delle biblioteche non sono solo riconosciuti dall'ISTAT, ma rappresentano parte integrante del sistema di statistica ufficiale italiana per la misurazione delle performance culturali e del benessere del Paese. Misura la percentuale di iscritti al prestito rispetto alla popolazione residente. È considerato l'indicatore fondamentale perché verifica l'impatto della biblioteca sui suoi utenti potenziali, cioè il suo radicamento nel territorio di riferimento. L'"indice di impatto" adottato da ISTAT nel Censimento delle biblioteche pubbliche e private misura il livello di radicamento dei servizi bibliotecari nella comunità locale. Si calcola come rapporto percentuale tra il numero di iscritti al prestito bibliotecario e il numero di residenti nella popolazione di riferimento. Questo indicatore quantifica dunque la capacità delle biblioteche di coinvolgere la comunità nell'accesso ai servizi legati al libro e alla lettura, restituendo una percentuale che rappresenta il peso degli utenti attivi rispetto alla popolazione servita. Nel 2022, l'indice di impatto nazionale si attestava al 9,2%, con significative variazioni regionali. La distribuzione regionale dell'indice di impatto delle biblioteche nel 2022 mostra significative disparità territoriali che riflettono il divario culturale tra Nord e Sud Italia. Classificazione Regionale Primo Gruppo - Eccellenza (oltre 19%): Valle d'Aosta: 20,9% (1° posto) Provincia di Trento: 20,6% (2° posto) Provincia di Bolzano/Bozen: 19,1% (3° posto) Secondo Gruppo - Performance Elevate (12-15%): Veneto: 14,3% (4° posto) Emilia-Romagna: 13,5% (5° posto) Lombardia: 12,7% (6° posto) Friuli-Venezia Giulia: 12,3% (7° posto) Terzo Gruppo - Sopra la Media Nazionale (8,1-11%): Piemonte: 10,6% (8° posto) Toscana: 8,6% (9° posto) Marche: 8,2% (10° posto) Quarto Gruppo - Sotto la Media Nazionale (3-8%): Basilicata: 7,5% (11° posto) Sardegna: 6,8% (12° posto) Umbria: 6,4% (13° posto) Abruzzo: 6,0% (14° posto) Liguria: 5,9% (15° posto).
Scene 14 (48m 58s)
[Audio] Quinto Gruppo - Performance Critiche (sotto 4%): Sicilia: 3,8% (16° posto) Lazio: 3,6% (17° posto) Calabria: 3,3% (18° posto) Puglia: 3,2% (19° posto) Molise: 3,1% (20° posto) Campania: 2,4% (21° posto) 26 Sul Piemonte è da far rilevare che non si è ancora riusciti a recuperare il gap determinato dalla pandemia quando nel 2019 il dato regionale si attestava al 19,3%. Ultimo dato disponibile (2022): L'indice d'impatto del Piemonte era del 10,6% superiore alla media nazionale dell'8,1%. Regione Piemonte ha avviato la rilevazione annuale dei dati di funzionamento delle biblioteche pubbliche per l'anno 2024 tramite la piattaforma Simonlib Questa rilevazione: È iniziata il 3 giugno 2025 Ha scadenza il 31 luglio 2025 (prorogata) Raccoglie dati relativi all'anno 2024 Coinvolge tutte le biblioteche pubbliche piemontesi Mentre aspettiamo i dati ufficiali 2024, alcuni indicatori locali mostrano segnali positivi: Osservatorio Culturale del Piemonte (2023): Le 111 biblioteche civiche monitorate hanno registrato: 224.000 iscritti che hanno effettuato almeno un prestito (+3% rispetto al 2021) 1,7 milioni di prestiti totali 7,7 prestiti per iscritto in media (in aumento rispetto ai 5,9 del 2021) Esempi locali significativi (2024): Biblioteca di San Mauro Torinese: 5.069 utenti iscritti totali, con la fascia 20-29 anni come la più numerosa (1.095 utenti) Biblioteca di Cuneo: crescita su tutti i principali indicatori nel 2024 Previsioni per il Dato 2025 Considerando i trend positivi evidenziati dall'Osservatorio Culturale del Piemonte, che parla di "piccoli segnali di ripresa dell'utilizzo dei servizi delle biblioteche", è probabile che l'indice d'impatto 2024-2025 mostri: 1. Un leggero miglioramento rispetto al 10,6% del 2022 2. Mantenimento della posizione superiore alla media nazionale 3. Graduale recupero verso i livelli pre-pandemici (19,3% del 2019) 26 La Redazione, "Le biblioteche di pubblica lettura in Italia" in Statistiche Focus.it -2022 del 1 luglio 2024..
Scene 15 (52m 16s)
[Audio] I risultati ufficiali dell'indice d'impatto 2024 saranno disponibili presumibilmente nel secondo semestre 2025, dopo l'elaborazione dei dati raccolti dalla piattaforma Simonlib e la pubblicazione del prossimo report ISTAT sulle biblioteche italiane. Le difficoltà nell'implementazione e utilizzo degli indici di impatto in Piemonte si articolano su diversi livelli, dai problemi metodologici di base alle sfide organizzative e di governance. La ricerca evidenzia un quadro complesso di criticità che coinvolgono sia gli aspetti tecnici della misurazione che quelli pratici dell'applicazione sul territorio. L'implementazione degli strumenti di valutazione dell'impatto in Piemonte si scontra con significative carenze di personale qualificato negli enti locali. Il rapporto di monitoraggio PNRR evidenzia come la mancanza di competenze specifiche e la carenza numerica del personale costituiscano ostacoli ricorrenti nella gestione delle procedure complesse e nella corretta applicazione degli strumenti di valutazione. L'insufficiente dotazione tecnologica e informatica costituisce un limite significativo. Alcuni enti lamentano la carenza di database regionali, modelli matematici di simulazione e altri strumenti informatici che potrebbero facilitare la gestione e il monitoraggio degli impatti. L'Indice di frequentazione. Rappresenta uno dei principali indicatori per valutare l'efficacia e l'attrattività delle biblioteche di pubblica lettura in Italia. Secondo i dati più recenti disponibili dell'ISTAT riferiti al 2022, questo indicatore fornisce informazioni cruciali sulla capacità delle biblioteche di coinvolgere i cittadini del territorio. L'Indice di Frequentazione è definito come il rapporto tra il numero totale di visite annue in biblioteca e la popolazione residente. Nel 2022, l'indice di frequentazione nazionale si è attestato a 0,63, il che significa meno di una visita per ciascun cittadino italiano. Questo valore rappresenta un incremento rispetto al 2021, quando era di 0,435 per mille abitanti, ma rimane ancora distante dai livelli pre-pandemici. Le biblioteche di pubblica lettura hanno registrato complessivamente quasi 34 milioni di accessi fisici nel 2022, con una media di circa 5.900 ingressi per ciascuna struttura e 30 visite per ogni giorno di apertura dichiarato. Le biblioteche di pubblica lettura italiane presentano le seguenti caratteristiche: 6.259 biblioteche di pubblica lettura attive nel 2022 (77% del totale) Distribuzione geografica: 60,2% al Nord, 27,2% al Mezzogiorno, 12,6% al Centro Copertura territoriale: due Comuni italiani su tre (66,3%) hanno almeno una biblioteca Orario medio di apertura: 22 ore settimanali. Sebbene non siano ancora disponibili dati completi per il 2025, le tendenze recenti suggeriscono: Incremento dei finanziamenti: per il 2025 sono previsti 54,8 milioni di euro per biblioteche ed editoria, raddoppiando rispetto ai 24,8 milioni del 2024.
Scene 16 (55m 57s)
[Audio] Digitalizzazione crescente: il 27,1% delle biblioteche ha avviato processi di digitalizzazione del patrimonio Evoluzione dei servizi: crescente integrazione di attività culturali e servizi digitali L'indice di frequentazione evidenzia le seguenti criticità: 1. Disparità territoriali: il divario Nord-Sud richiede interventi mirati 2. Accessibilità: necessità di migliorare gli orari e i servizi nelle aree periferiche 3. Modernizzazione: accelerazione dei processi di digitalizzazione 4. Inclusività: sviluppo di servizi per categorie specifiche di utenti Ecco la distribuzione regionale dell'indice di frequentazione delle biblioteche di pubblica lettura in Italia per l'anno più recente disponibile (2022, dati ISTAT). Questo indice è calcolato come rapporto fra il numero totale di visite annue e la popolazione residente della regione. Regione Indice di Frequentazione 2022 Provincia di Bolzano/Bozen 3,55 Valle d'Aosta 3,47 Provincia di Trento 2,69 Emilia-Romagna 1,46 Lombardia 0,85 Friuli-Venezia Giulia 0,82 Veneto 0,79 Toscana 0,76 Italia (media nazionale) 0,63 Sardegna 0,50 Piemonte 0,48 Puglia 0,48 Marche 0,46 Liguria 0,41 Umbria 0,38 Lazio 0,30 Abruzzo 0,16 Basilicata 0,15 Molise 0,14 Sicilia 0,06 Campania 0,05 Calabria 0,05 I valori più alti si riscontrano nelle province autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna..
Scene 17 (58m 33s)
[Audio] Al Sud la frequentazione delle biblioteche risulta molto più bassa della media italiana. La media nazionale è 0,63. Il Piemonte, secondo i dati ISTAT più recenti (2022), presenta un indice di frequentazione delle biblioteche pari a 0,48. Questo valore indica che, in media, ogni cittadino piemontese ha effettuato poco meno di una visita all'anno presso una biblioteca di pubblica lettura. Rispetto alla media nazionale (0,63), il Piemonte si colloca leggermente al di sotto. La regione tuttavia supera i valori registrati in molte regioni del Centro e, soprattutto, del Mezzogiorno, ma è distante dai livelli delle province autonome di Bolzano/Bozen (3,55), Trento (2,69) ed Emilia-Romagna (1,46), dove la cultura bibliotecaria è storicamente più radicata e le reti di servizi più estese ed efficienti. In sintesi: il Piemonte ha una performance intermedia, superiore al Sud e a molte regioni del Centro, ma inferiore alle migliori realtà del Nord Italia, segnalando quindi spazi di miglioramento soprattutto sul lato dell'attrattività e dell'intensità d'uso delle biblioteche rispetto alla popolazione residente.27 L'indice di frequentazione delle biblioteche piemontesi si attesta a 0,48 nel 2022, posizionando la regione al 10° posto nazionale su 21 regioni. Questo valore, significativamente inferiore alla media nazionale (0,843), evidenzia diverse criticità strutturali che ostacolano l'accesso fisico alle biblioteche da parte dei cittadini. Il Piemonte presenta un paradosso bibliotecario: mentre l'indice di prestito (0,60) supera quello di frequentazione (0,48), suggerendo che chi accede alle biblioteche è relativamente attivo nel prendere libri in prestito. Il rapporto prestito/frequentazione di 1,25 indica una buona efficienza nell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti che effettivamente visitano le strutture. Tuttavia, la regione si colloca nella fascia "media" per frequentazione, distante dalle eccellenze alpine (Provincia di Bolzano/Bozen: 3,55; Valle d'Aosta: 3,47; Provincia di Trento: 2,69) e sotto regioni come Emilia-Romagna (1,46) e Lombardia (0,85). Le biblioteche piemontesi presentano orari di apertura ridotti rispetto ad altre regioni. Nel 2014, il Piemonte registrava una media di sole 15 ore settimanali di apertura, tra i valori più bassi d'Italia insieme a Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Questa limitazione rappresenta un ostacolo significativo per i lavoratori e gli studenti che potrebbero accedere solo in orari serali o nel weekend. La gestione affidata a volontari in molte biblioteche comporta irregolarità negli orari e possibili chiusure improvvise. Le carenze di personale qualificato e l'impossibilità di assumere nuovo personale per sostituire quello in pensione creano un circolo vizioso che limita gli orari di servizio.28 27 La Redazione, "Le Biblioteche di pubblica lettura in Italia – Anno 2022", in Statistiche Focus Istat del 1luglio 2024. 28 La Redazione "Le Biblioteche in Piemonte tra tradizione ed innovazione" Osservatorio culturale del Piemonte.
Scene 18 (1h 2m 29s)
[Audio] Nonostante gli interventi del PNRR per l'eliminazione delle barriere architettoniche, molte biblioteche piemontesi presentano ancora difficoltà di accesso per persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali. Solo una piccola percentuale delle biblioteche ha eliminato completamente le barriere percettive e cognitive.29 Esistono "differenze enormi tra centro e periferia", con le biblioteche delle aree urbane centrali che godono di maggiore visibilità e accessibilità rispetto a quelle periferiche. Questa disparità territoriale influisce negativamente sulla frequentazione complessiva. Molte biblioteche piemontesi dispongono di spazi limitati per la consultazione e lo studio. Il 25,6% delle biblioteche offre più di 30 postazioni, mentre il 30,1% ne ha al massimo 10. La carenza di posti a sedere scoraggia la frequentazione, specialmente da parte degli studenti. Le dotazioni informatiche inadeguate rappresentano un deterrente significativo: 28,4% delle biblioteche manca di PC per consultazione OPAC 10,2% è sprovvista di PC con connessione internet 31,7% non offre connessione Wi-Fi gratuita Queste carenze limitano l'attrattività delle biblioteche per gli utenti più giovani e digitalmente orientati.30 Molte biblioteche piemontesi soffrono di scarsa visibilità sul territorio. La mancanza di campagne promozionali efficaci e l'assenza da social media e piattaforme digitali limitano la conoscenza dei servizi offerti da parte della cittadinanza. L'assenza di sistemi di orientamento adeguati all'interno delle biblioteche e la mancanza di segnaletica appropriata creano difficoltà per i nuovi utenti, scoraggiando visite ripetute. La digitalizzazione dei contenuti e i nuovi modelli di fruizione culturale richiedono una riorganizzazione degli spazi bibliotecari che spesso non avviene per mancanza di risorse. Le biblioteche faticano a intercettare i nuovi bisogni dell'utenza digitale. La presenza di spazi alternativi per studio e socializzazione (coworking, caffetterie, centri commerciali) sottrae utenza potenziale alle biblioteche tradizionali, soprattutto quando queste non riescono a innovare la propria offerta. I piccoli segnali di recupero registrati nel 2022 con 224.000 iscritti (+3% rispetto al 2021) nelle 111 biblioteche civiche monitorate evidenziano la lenta ripresa dopo la pandemia. Tuttavia, rimane la difficoltà nel riportare i lettori fisicamente in sede, nonostante l'aumento della fedeltà degli utenti (7,7 prestiti per iscritto rispetto ai 5,9 del 2021).31 29 PNRR, "Piano strategico per l'eliminazione delle barriere architettoniche" Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2 30La Redazione "Sapere digitale. Educazione civica digitale in biblioteca" Biblioteche Oggi n.3 2021 31 Relazione 2023-2024. La Cultura in Piemonte. Una sintesi presentata 23 ottobre 2024 presso la sala Gynnasium di Camera Centro italiano per la fotografia..
Scene 19 (1h 6m 13s)
[Audio] Per migliorare l'indice di frequentazione piemontese sarà necessario: 1. Estendere gli orari di apertura con personale adeguato 2. Eliminare completamente le barriere architettoniche e cognitive 3. Potenziare le dotazioni tecnologiche e la connettività 4. Riorganizzare gli spazi per renderli più accoglienti e funzionali 5. Sviluppare campagne promozionali efficaci e presenza digitale 6. Formare il personale sulle nuove esigenze dell'utenza 7. Creare sinergie territoriali per ridurre le disparità centro-periferia Solo un intervento sistemico su questi fronti potrà trasformare le biblioteche piemontesi in luoghi realmente attrattivi e accessibili per tutta la cittadinanza. L'indice di prestito. Rappresenta uno degli indicatori più significativi per misurare l'efficacia e la capacità delle biblioteche di promuovere l'uso del patrimonio documentale posseduto a livello territoriale. Questo indicatore, calcolato come rapporto tra il numero di prestiti totali effettuati in un anno e la popolazione dei comuni dove è presente almeno una biblioteca, fornisce una misura quantitativa dell'attività bibliotecaria sul territorio. Secondo i dati più recenti dell'ISTAT relativi al 2022, l'indice di prestito nazionale per le biblioteche di pubblica lettura italiane si attesta a 0,57, significando meno di un prestito per utente potenziale. Questo dato rivela un panorama nazionale caratterizzato da forti disparità territoriali. Distribuzione regionale dell'Indice di Prestito delle biblioteche italiane nel 2022 Analisi per Macroaree Nord Italia: Eccellenza Consolidata Il Nord Italia registra una media di 1,596, superando di oltre il doppio la media nazionale (0,768). Le regioni settentrionali dominano la classifica con: Provincia di Bolzano/Bozen: 5,34 (valore massimo nazionale) Provincia di Trento: 2,25 Valle d'Aosta: 2,22 Lombardia: 1,10 Emilia-Romagna: 0,98 Nove regioni del Nord su diciotto complessivamente superano la media nazionale, dimostrando un sistema bibliotecario maturo e ben organizzato. Centro Italia: Performance Intermedie Il Centro Italia presenta una media di 0,258, significativamente inferiore alla media nazionale. La distribuzione mostra: Toscana: 0,49 (migliore performance del Centro) Marche: 0,23.
Scene 20 (1h 9m 2s)
[Audio] Umbria: 0,19 Lazio: 0,12 (sorprendentemente basso per la regione della capitale) Sud e Isole: Criticità Strutturali Il Mezzogiorno evidenzia le maggiori criticità con una media di soli 0,091, circa un decimo della media nazionale. La Sardegna (0,45) rappresenta l'unica eccezione positiva, mentre le altre regioni mostrano valori drammaticamente bassi: Campania: 0,01 (valore minimo nazionale) Calabria: 0,02 Sicilia, Puglia, Basilicata: 0,04 Piemonte si colloca con un indice di prestito di 0,60 nel 2022, un valore superiore alla media delle regioni del Centro-Sud ma inferiore alla media nazionale (0,768). Classificazione: fascia "media" (0,20–0,76). Posizione: o 8ᵃ nella graduatoria nazionale (su 21 regioni) o 7ᵃ nel Nord Italia (su 9 regioni) Questo risultato evidenzia una performance intermedia: superiore a molte regioni del Centro e del Mezzogiorno, ma ancora distante dai livelli d'eccellenza delle Province autonome alpine. Per innalzare ulteriormente l'indice di prestito in Piemonte, potrebbe essere utile potenziare le iniziative di promozione della lettura e i servizi digitali delle biblioteche, in coerenza con le linee di investimento nazionali per il 2025. Questa distribuzione evidenzia la necessità di interventi mirati per ridurre il divario territoriale. Le Province autonome dimostrano che investimenti adeguati e gestione efficiente possono produrre risultati eccellenti, mentre il Mezzogiorno richiede strategie specifiche per sviluppare una cultura bibliotecaria diffusa. L'incremento dei fondi governativi per il 2025 (54,8 milioni di euro) rappresenta un'opportunità per avviare politiche di riequilibrio territoriale, concentrando gli investimenti nelle regioni con maggiori criticità per costruire un sistema bibliotecario nazionale più omogeneo ed efficace. L'indice di prestito delle biblioteche piemontesi (0,60 nel 2022) riflette diverse criticità strutturali che impediscono di raggiungere performance più elevate. L'analisi delle problematiche evidenzia un quadro complesso di difficoltà che coinvolgono aspetti organizzativi, normativi, professionali e tecnologici. Le biblioteche piemontesi affrontano significative difficoltà nella gestione del personale. Molte strutture sono gestite da personale non qualificato o da volontari che "fanno molta fatica ad applicare le conoscenze statistiche", compromettendo la qualità dei servizi offerti. La impossibilità di realizzare nuove assunzioni per sopperire al turn over professionale rappresenta un aspetto critico ricorrente. Questa situazione costringe le.
Scene 21 (1h 12m 13s)
[Audio] biblioteche a dipendere eccessivamente dal volontariato, creando un paradosso: i volontari sono una "risorsa preziosissima" ma necessitano di "integrazione con professionalità bibliotecarie". Emerge una riluttanza al cambiamento del personale bibliotecario che "spesso nasce proprio da una mancanza di formazione". Le competenze tradizionali non sono più sufficienti a dare risposte efficaci ai nuovi bisogni dell'utenza, richiedendo un aggiornamento professionale che spesso non viene fornito. Il contesto finanziario risulta particolarmente problematico: negli ultimi cinque anni, il 67,7% delle biblioteche non ha ricevuto finanziamenti specifici per implementare il digitale2. La maggior parte dei rispondenti considera inadeguati i finanziamenti, soprattutto per la formazione del personale2. L'incertezza delle risorse e del quadro normativo ostacola la programmazione di medio e lungo periodo. La Regione Piemonte sta progressivamente riducendo il proprio ruolo di "contribuzione economica" per assumere maggiormente funzioni di "indirizzo e programmazione". Le biblioteche piemontesi presentano importanti carenze tecnologiche: 68,2% non dispone di tablet 65,3% non ha e-reader 76,1% è priva di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) 83% non possiede stampanti 3D 28,4% manca di PC per consultazione OPAC 10,2% è sprovvista di PC con connessione internet I bibliotecari indicano come priorità "PC nuovi, aggiornati, moderni, veloci" a disposizione sia dell'utenza che del personale. Esiste una scarsa dimestichezza tra i bibliotecari nell'uso dei Social Media e degli strumenti digitali, richiedendo "corsi di alfabetizzazione informatica ad hoc". Manca il tempo per la formazione in ambito digitale del personale bibliotecario. La Legge Regionale 78/78 viene considerata "ormai datata" sia per la disciplina dei servizi che per la "coesione territoriale e cooperazione" tra diverse tipologie di biblioteche. Tutti i partecipanti agli incontri di studio hanno dichiarato la necessità di una revisione di tale legge regionale. Il sistema di monitoraggio regionale presenta un basso tasso di risposta (2012) e utilizza esclusivamente indicatori quantitativi che non riescono a "catturare quegli elementi qualitativi" che forniscono informazioni su cosa accade realmente negli spazi bibliotecari. L'organizzazione reticolare delle biblioteche piemontesi presenta una "doppia incrinatura": Nel modello di biblioteca pubblica di riferimento Nel modello territoriale di governance.
Scene 22 (1h 15m 15s)
[Audio] Molti sistemi bibliotecari soffrono per la mancanza di formalizzazione delle convenzioni con la Regione Piemonte, impedendo una programmazione strutturata. Le biblioteche faticano a cogliere le nuove domande dell'utenza e a rispondere in maniera adeguata. Cresce la "domanda di assistenza" e di "costruzione di percorsi ludici", ma mancano le competenze per fornire risposte efficaci. Esistono "differenze enormi tra centro e periferia", soprattutto sul tema della formazione dei bibliotecari. Questa disparità contribuisce a mantenere basso l'indice di prestito nelle aree più periferiche. Queste criticità sistemiche si traducono direttamente in un indice di prestito contenuto (0,60) per il Piemonte. La combinazione di personale sottodimensionato e poco formato, risorse finanziarie inadeguate, dotazioni tecnologiche carenti e un quadro normativo obsoleto crea un circolo vizioso che limita l'efficacia dei servizi bibliotecari. Per migliorare l'indice di prestito piemontese sarà necessario un intervento coordinato su tutti questi fronti: aggiornamento normativo, investimenti in formazione e tecnologia, riorganizzazione dei sistemi territoriali e definizione di standard qualitativi chiari per i servizi bibliotecari.32 L'indice di volume procapite. che misura il numero di volumi disponibili per abitante, ha un impatto notevole sulle biblioteche italiane, evidenziando differenze territoriali significative e ponendosi come uno dei principali indicatori della capacità delle biblioteche di rispondere ai bisogni della popolazione. Insomma rappresenta il rapporto tra il numero di volumi posseduti da una biblioteca (o da un sistema bibliotecario) e la popolazione di riferimento servita dalla biblioteca stessa. Questo indice serve a misurare in modo sintetico l'adeguatezza delle collezioni in relazione al bacino d'utenza potenziale. In altre parole, indica quanti libri sono disponibili in media per ciascun abitante del territorio su cui insiste la biblioteca. Cosa significa in pratica? Un valore più alto suggerisce una maggiore offerta documentaria e, potenzialmente, una maggiore capacità della biblioteca di rispondere ai bisogni informativi e culturali della comunità. Un valore basso, invece, può essere sintomo di una dotazione documentaria insufficiente rispetto alla popolazione servita, evidenziando possibili "zone d'ombra" nell'accesso ai saperi e alla lettura. In sintesi: l'indice di volume pro capite è un importante indicatore quantitativo per la programmazione bibliotecaria e per valutare se una biblioteca offre un patrimonio adeguato alle esigenze della propria comunità. 32 La Redazione, "Le Biblioteche di pubblica lettura in Italia – Anno 2022", in Statistiche Focus Istat del 1luglio 2024..
Scene 23 (1h 18m 20s)
[Audio] Secondo il rapporto ISTAT sulle biblioteche di pubblica lettura italiane, nel 2022 l'indice di volume pro capite risultava pari a circa tre volumi per abitante a livello nazionale. Tuttavia, il dato presenta forti divari regionali: Nord Italia: Le regioni settentrionali superano la media nazionale, con valori particolarmente elevati in Valle d'Aosta (11 volumi pro capite), Provincia autonoma di Trento (7), Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia (5 ciascuna), Provincia di Bolzano/Bozen e Veneto (4). Centro e Sud: Alcune regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia e Molise) fanno registrare valori inferiori a due volumi per abitante. Sardegna: Si distingue come eccezione nel Sud, raggiungendo i quattro volumi pro capite. Un indice più alto si associa a una maggiore potenzialità delle biblioteche nella promozione della lettura e della crescita culturale delle comunità locali. Le differenze regionali richiedono ancora importanti interventi di riequilibrio per garantire pari opportunità di accesso alla cultura sull'intero territorio nazionale. Oltre metà delle biblioteche possiede più di 10.000 volumi; solo l'8,6% supera i 50.000. Il patrimonio bibliotecario complessivo è cresciuto del 6% rispetto al 2021, con un incremento medio di circa 1.800 volumi per struttura. I dati ISTAT suggeriscono correlazione tra ampiezza della dotazione e maggiore "vitalità" delle biblioteche, ossia maggior uso, frequentazione e soddisfazione degli utenti. Nonostante la progressiva crescita del patrimonio, persiste uno squilibrio nell'offerta, con il Sud in forte ritardo rispetto al Nord e con conseguenti criticità nell'erogazione omogenea di servizi su tutto il territorio nazionale. Il Piemonte nel 2022 presentava un indice superiore alla media nazionale (pari a circa 3 volumi pro capite): pur non raggiungendo i livelli delle regioni del Nord con l'indice più alto, si colloca tra le aree italiane più virtuose. La regione mostra inoltre una buona capillarità della rete bibliotecaria: con circa 1,8 biblioteche ogni 10.000 abitanti, garantisce un servizio diffuso su tutto il territorio, soprattutto nelle aree urbane e nei comuni di medie e grandi dimensioni. Oltre la metà delle biblioteche piemontesi conserva più di 10.000 volumi; il patrimonio complessivo regionale si aggira su circa 9 milioni di documenti cartacei, confermando una dotazione considerevole a livello nazionale. Accessibilità culturale: Un indice elevato supporta la funzione di inclusione e democratizzazione culturale della biblioteca, offrendo maggiori opportunità individuali di lettura, formazione e aggiornamento. Vitalità del sistema: L'articolazione territoriale delle collezioni e un buon livello di dotazione media corrispondono anche a una "vitalità" della rete bibliotecaria, con un'elevata frequenza di prestiti e attività nelle grandi città e nei poli metropolitani..
Scene 24 (1h 21m 42s)
[Audio] Squilibri interni: La concentrazione di patrimonio nei maggiori centri urbani (ad esempio Torino e area metropolitana) genera una distribuzione non perfettamente omogenea, lasciando alcune aree con minore copertura quantitativa.33 Competitività regionale: Il Piemonte, grazie a questo indice, si posiziona tra le regioni italiane maggiormente in grado di sostenere la domanda di servizi pubblici per la lettura, ponendosi come riferimento per modelli di gestione e investimenti nelle collezioni. In sintesi, l'impatto di un indice di volume procapite soddisfacente in Piemonte si traduce in una rete bibliotecaria capillare, in dotazioni documentarie mediamente elevate e in una migliore capacità di risposta alle esigenze culturali dei cittadini, pur evidenziando talvolta la necessità di riequilibrare la distribuzione interna del patrimonio nella regione.34 Emergono alcune importanti criticità. Innanzitutto quasi la metà del patrimonio librario piemontese è concentrato nei comuni più grandi (oltre 30.000 abitanti) e in particolare nelle aree metropolitane come Torino e il suo hinterland. Questo significa che molte biblioteche nei comuni medio-piccoli hanno un patrimonio pro capite sensibilmente inferiore rispetto alla media regionale, generando disuguaglianze di accesso alla risorsa libro sul territorio. Purtroppo il sistema di monitoraggio statistico regionale presenta lacune e disomogeneità nella raccolta dei dati, con una difficoltà costante delle biblioteche nel fornire regolarmente le informazioni entro le scadenze. Questo comporta dati parziali e comparazioni problematiche sia all'interno della regione che rispetto ad altre realtà nazionali e internazionali. L'indice di volume pro capite, se preso da solo, non restituisce la qualità, l'aggiornamento o la pertinenza della collezione rispetto agli interessi e ai bisogni della popolazione. Ad esempio, una biblioteca può avere una dotazione numericamente adeguata ma composta da volumi obsoleti o poco rilevanti per l'utenza locale. La crescita numerica del patrimonio, inoltre, non sempre si traduce in un aumento parallelo dei prestiti o della fruizione. Si riscontrano difficoltà di pianificazione nell'acquisto di nuovi titoli e una crescita che non sempre tiene conto degli effettivi bisogni dell'utenza. La scarsità di risorse economiche può limitare la capacità di aggiornare le collezioni, mantenendo alto il numero complessivo di volumi ma riducendo il valore aggiornato e rispondente del patrimonio. L'indice di volume pro capite si focalizza poi esclusivamente sulla componente cartacea e fisica delle collezioni. Non contabilizza la crescente dotazione di risorse digitali e multimediali, che rappresenta una quota sempre più rilevante dell'offerta bibliotecaria moderna. Questo può portare a una 33 La Redazione, "Le Biblioteche di pubblica lettura in Italia – Anno 2022", in Statistiche Focus Istat del 1luglio 2024 34 La Redazione "Le Biblioteche in Piemonte. Tra innovazione e trasformazione" in Osservatorio Culturale del Piemonte 2015.
Scene 25 (1h 25m 19s)
[Audio] sottovalutazione delle reali opportunità di accesso all'informazione offerte dalle biblioteche, soprattutto nelle realtà più dinamiche o innovative.35 In sintesi, l'indice di volume pro capite in Piemonte è mediamente buono, ma le sue reali potenzialità sono in parte limitate da forti squilibri territoriali, incompletezza dei dati rilevati, scarso peso attribuito alla qualità e all'attualità delle collezioni, difficoltà di pianificazione degli acquisti e mancanza di aggiornamenti relativi all'offerta digitale. Questi elementi suggeriscono la necessità di integrare l'uso di questo indicatore con misure qualitative e funzionali più aggiornate e rappresentative della domanda sociale di cultura e lettura.36 L'indice giornate o ore medie di apertura delle biblioteche italiane. Rappresenta un indicatore chiave dell'accessibilità del servizio bibliotecario sul territorio nazionale, ovvero quanto le biblioteche siano realmente fisicamente raggiungibili dagli utenti durante l'anno e nella settimana. Ore settimanali di apertura: nel 2022, una biblioteca di pubblica lettura italiana è stata aperta in media per 21-22 ore a settimana. Più della metà delle strutture (53,2%) ha aperto fra le 12 e le 30 ore settimanali, circa un quinto (22,1%) fra 31 e 60 ore, mentre solo il 9,1% delle biblioteche ha superato le 40 ore settimanali di apertura, con punte più alte nel Centro e Nord Italia e valori minimi nel Sud. Giorni di apertura annuale: il 57,5% delle biblioteche è rimasto aperto per almeno 200 giorni su 252 lavorativi. Circa l'85% delle biblioteche ha assicurato almeno 4 o 5 giorni di apertura alla settimana. Differenze territoriali: le biblioteche dei piccoli comuni e delle aree interne sono state mediamente aperte soltanto per 13 ore e 3 giorni a settimana (contro una media di 22 ore e oltre 4 giorni a livello nazionale). Nei poli urbani si sale oltre 32 ore settimanali. Apertura nei comuni periferici: solo il 45-46% delle biblioteche nei comuni periferici era aperto per almeno 180 giorni l'anno, scendendo nei comuni ultraperiferici, rispetto a quote sopra il 60% nei poli urbani. Questo indice misura il livello concreto di accessibilità del servizio biblioteca e quindi la sua capacità di svolgere una funzione educativa e sociale. Un maggior numero di ore e giorni di apertura amplia le possibilità per la popolazione di usufruire della biblioteca come luogo di lettura, studio, socialità e partecipazione culturale. Le forti differenze tra aree urbane, piccoli centri e aree interne evidenziano la necessità di politiche di riequilibrio dell'offerta e, più in generale, il rischio di minori opportunità per i cittadini residenti nelle zone meno centrali. In sintesi: nel 2022 l'accessibilità fisica delle biblioteche italiane si è mantenuta su livelli mediamente buoni, ma continua a presentare forti squilibri territoriali sia in termini di 35 La Redazione "Le Biblioteche in Piemonte. Tra innovazione e trasformazione" in Osservatorio Culturale del Piemonte 2015 36 Giovanni Arganese, "Biblioteche e città: la funzione civica" delle biblioteche del MiBAC" in Studi, doi 10.2426/aibstudi-6302, vol. 52 n. 2 (maggio/agosto 2012), p. 127-150..
Scene 26 (1h 29m 27s)
[Audio] ore/giornate di apertura sia per le potenzialità effettive di fruizione da parte di tutta la popolazione. Nel 2022 la distribuzione regionale dell'indice di giornate o ore medie di apertura delle biblioteche italiane conferma una forte eterogeneità territoriale, riflettendo disparità di accessibilità ai servizi bibliotecari tra Nord, Centro, Sud e Isole. Il quadro regionale è così rappresentato: Lazio: è la regione con la quota più alta di biblioteche aperte più di 40 ore a settimana (18,1% delle strutture della regione). Toscana: segue con il 17,3%. Emilia-Romagna: 14,5% di biblioteche aperte più di 40 ore. Veneto: 10,9%. Liguria, Puglia, Sicilia: si attestano tra il 9,7% e il 9,1% (cioè circa 1 biblioteca su 10 raggiunge più di 40 ore). Friuli-Venezia Giulia: solo il 10,8% supera le 30 ore, contro una media nazionale del 22,1%. Regioni con meno biblioteche con orari ampi: Abruzzo (2,9%), Basilicata e Trentino-Alto Adige (3%) registrano la presenza più bassa (meno di 3% di biblioteche con oltre 40 ore settimanali aperte)37. In Piemonte L'impatto dell'indice di giornate o ore medie di apertura delle biblioteche in Piemonte riflette il livello di accessibilità reale ai servizi bibliotecari sul territorio regionale e la capacità del sistema di rispondere alle esigenze della comunità. Nel 2022, le biblioteche piemontesi hanno garantito una media di circa 20-21 ore settimanali di apertura, dato leggermente inferiore o allineato alla media nazionale (22 ore). L'orario minimo previsto dalla regolamentazione regionale varia in base alla dimensione del comune: ad esempio, almeno 12 ore settimanali nei piccoli comuni e fino a 36 ore nei grandi centri urbani, ma molti centri minori faticano a raggiungere queste soglie. Nelle città grandi e aree metropolitane, la disponibilità di biblioteche aperte con orari ampi è superiore rispetto ai comuni periferici e rurali, dove la media può scendere anche a circa 13 ore su 3 giorni settimanali, riflettendo uno squilibrio nell'accessibilità dei servizi. Tutto ciò produce effetti e criticità. Gli orari ridotti delle biblioteche nei comuni poco popolati o isolati limitano concretamente la possibilità per buona parte della popolazione piemontese di usufruire dei servizi, sia per lo studio che per altre attività sociali e formative. 37 La Redazione, "Orari di apertura più ampi nelle biblioteche di Lazio, Toscana, Emilia Romagna" in Openpolis.it del 22 marzo 2022..
Scene 27 (1h 32m 42s)
[Audio] Vantaggio competitivo delle aree urbane: Le biblioteche delle principali città (come Torino) garantiscono apertura ampia e quindi maggiore accesso, promozione culturale e impatto positivo sulla comunità locale. Disuguaglianze territoriali: Il dato piemontese conferma la necessità di interventi di riequilibrio, sia per aumentare le ore di apertura nelle zone meno servite, sia per favorire la fruizione della biblioteca come luogo di aggregazione a tutte e tutti, superando la sola funzione di prestito. Organizzazione e risorse: Il raggiungimento di standard più elevati di apertura dipende, oltre che dalla volontà di programmazione, anche dalla disponibilità di personale e di risorse economiche specifiche per garantire la sostenibilità degli orari più ampi. L'indice delle ore di apertura in Piemonte mostra una buona base nei centri urbani ma segnala ancora difficoltà strutturali e logistiche nelle aree interne e periferiche, con impatti concreti sulla fruizione e sull'inclusione sociale. L'aumento delle ore di apertura rimane quindi un obiettivo strategico per rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio civico e culturale, soprattutto nei territori più fragili.38 Occupati nel settore delle biblioteche in Italia: situazione attuale e dati disponibili Non esistono dati ufficiali ISTAT specifici per gli occupati nel settore bibliotecario in Italia per il 2025. I dati più recenti disponibili si riferiscono al 2022 e provengono dall'indagine ISTAT sulle biblioteche di pubblica lettura. Secondo l'ultimo Focus ISTAT sulle biblioteche di pubblica lettura pubblicato nel 2024, nel 2022 risultavano oltre 26.000 addetti nelle biblioteche di pubblica lettura italiane, con una media di cinque addetti per ogni struttura censita. La composizione del personale nelle biblioteche di pubblica lettura nel 2022 era così distribuita: 31,7% composto da volontari 30,4% personale interno (dipendenti) 16,9% operatori di ditte esterne 11,9% operatori del servizio civile 9,1% consulenti e professionisti esterni.39 Per avere un quadro evolutivo, è utile confrontare questi dati con quelli del 2019 Nel 2019: circa 18.000 addetti su 7.425 biblioteche pubbliche e private Di questi, 10.738 erano bibliotecari 38 La Redazione, "Le Biblioteche di pubblica lettura in Italia – Anno 2022", in Statistiche Focus Istat del 1luglio 2024 REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2021, n. 11/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della legge regionale 1agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)". 39 La Redazione, "Le biblioteche di pubblica lettura in Italia" 2022 in Statistiche Focus Istat.it del 1 luglio 2024..
Scene 28 (1h 36m 38s)
[Audio] Nel 2022: oltre 26.000 addetti nelle sole biblioteche di pubblica lettura40 L'indagine ISTAT del 2019 evidenziava che quattro biblioteche su dieci erano aperte solo con il lavoro di personale volontario, sottolineando la forte dipendenza del settore dal volontariato. Il 57,1% delle biblioteche ha almeno un addetto che ricopre la figura professionale del bibliotecario, con una media di due bibliotecari per biblioteca. Nel 2022, il personale del 60,8% delle biblioteche ha frequentato almeno un corso di formazione o aggiornamento professionale tra il 2019 e il 2022. La maggior parte della formazione (89,0%) è stata orientata allo sviluppo di competenze specialistiche per la gestione bibliotecaria.41 Per quanto riguarda le Biblioteche Pubbliche Statali, la situazione appare particolarmente critica. Nel 2016 il personale in servizio contava 779 bibliotecari, oggi ridotti a circa 310. Diverse biblioteche nazionali hanno denunciato carenze di organico significative.42 Non essendo disponibili dati ufficiali per il 2025, è necessario attendere la prossima rilevazione ISTAT per avere informazioni aggiornate sul numero esatto di occupati nel settore bibliotecario. I dati del 2022 rimangono pertanto il riferimento più recente e affidabile per comprendere le dimensioni occupazionali del settore delle biblioteche in Italia. Forme di lavoro dei dipendenti nel settore bibliotecario italiano. I dipendenti del settore bibliotecario in Italia operano attraverso diverse forme contrattuali, caratterizzate da un elevato grado di frammentazione e precarietà. La composizione del personale riflette un sistema ibrido tra pubblico e privato, con una crescente esternalizzazione dei servizi. Principali contratti collettivi applicati CCNL Enti Locali Applicato ai dipendenti pubblici di biblioteche comunali e provinciali. Prevede le figure di: Istruttore Culturale (categoria C) Istruttore Direttivo Culturale (categoria D) È il contratto che garantisce maggiore stabilità e riconoscimento professionale, con stipendi che vanno dai 1.000 ai 1.400 euro netti mensili per i neoassunti. CCNL Federculture 40 Laura Pasotti, "Lavorare in biblioteca: in Italia significa precariato, contratti non adeguati e stipendio risicato" in Osservatorio Diritti.it del 25 ottobre 2022. 41La Redazione, "Le biblioteche di pubblica lettura in Italia" 2022 in Statistiche Focus Istat.it del 1 luglio 2024. 42https://www.socialnews.it/blog/2022/03/28/sos-bibliotecari-la-situazione-delle-biblioteche-pubbliche-initalia/.
Scene 29 (1h 40m 0s)
[Audio] Il primo contratto specifico per il settore culturale, sottoscritto nel 1999 con CGIL, CISL e UIL. È l'unico che riconosce esplicitamente le figure di "Bibliotecario" e "Aiuto Bibliotecario". Tuttavia, la sua applicazione è stata limitata da diversi fattori: Ammissione delle cooperative sociali alle gare d'appalto Diffusione delle aziende multiservizi Orientamento delle amministrazioni al risparmio piuttosto che alla qualità Altri contratti utilizzati Per i servizi esternalizzati si applicano spesso contratti non specifici del settore: CCNL Commercio e Servizi CCNL Multiservizi (scaduto nel 2013) CCNL Cooperative Sociali Questi contratti prevedono solo figure generiche adattate alle funzioni bibliotecarie, senza riconoscimento delle specificità professionali.43 Forme contrattuali specifiche Dipendenti pubblici. Accesso tramite concorso pubblico con prove specifiche per accertare la professionalità bibliotecaria. Possono essere assunti: Tempo indeterminato (full-time o part-time) Tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali.44 Lavoro esternalizzato. Attraverso appalti pubblici, le amministrazioni affidano la gestione dei servizi bibliotecari a soggetti privati. I lavoratori hanno spesso: Contratti a tempo indeterminato con le cooperative Contratti part-time (maggioranza dei casi) Retribuzioni molto basse (7-8 euro lordi/ora) Applicazione di CCNL inadeguati (es. Commercio invece di Federculture)45 Forme precarie diffuse Collaborazioni coordinate continuative per progetti specifici46 Somministrazione di lavoro tramite agenzie interinali 43 Francesca Cadeddu Concas, "Bibliotecari e Aiuto bibliotecari e possibili livelli di inquadramento in riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro maggiormente applicati in Italia" in Riviste. AIB 44 Nerio Agostini, "La gestione delle risorse umane nelle biblioteche pubbliche" in Biblioteche Oggi.it settembre 2006 45 Marco Dalla Valle, "Emergenza Cultura, "La Biblioterapia nella biblioteca per il benessere in un'ottica di biblioteeconomia critica" in Biblioteche oggi Trends, vol. 9, n. 2 (dicembre 2023) p. 52 46 Nerio Agostini, "La gestione delle risorse umane nelle biblioteche pubbliche" in Biblioteche Oggi.it settembre 2006.
Scene 30 (1h 43m 2s)
[Audio] Contratti misti con più tipologie per lo stesso lavoratore Lavoro "a cottimo" (retribuzione per quantità di documenti catalogati).47 Problematiche del sistema contrattuale Alta precarietà. Oltre il 68% del personale lavora con forme contrattuali atipiche o non retribuite. Questa situazione genera: Turnover elevato e perdita di competenze Difficoltà nella programmazione dei servizi Demotivazione del personale qualificato.48 Disparità retributive. Esistono forti disparità tra: Dipendenti pubblici e lavoratori esternalizzati Lavoratori con contratti diversi nello stesso servizio Bibliotecari con stesse mansioni ma inquadramenti differenti Inadeguatezza dei contratti. La maggior parte dei contratti applicati non riconosce le specificità professionali del bibliotecario, portando a: Inquadramenti generici inadeguati alle competenze richieste Sottovalutazione economica della professione Mancanza di percorsi di carriera specifici Evoluzione e prospettive La crescente esternalizzazione dei servizi bibliotecari ha portato a una progressiva precarizzazione del settore49. Esempi significativi includono: Firenze: 109 lavoratori esternalizzati contro 50 dipendenti pubblici Milano: Biblioteca Braidense ridotta da 145 a 33 dipendenti in 15 anni Biblioteche statali: personale ridotto da 779 a circa 310 bibliotecari La situazione richiede interventi strutturali per garantire: 47https://www.perunaltracitta.org/homepage/2015/03/24/silenzio-inammissibile-e-doloroso-sulla-bibliotecanazionale/ 48 La Redazione, "Le biblioteche di pubblica lettura in Italia" Anno 2022 in Statistiche Focus Istat.it del 1 luglio 2024. 49 Esempi significativi includono: Firenze:109 lavoratori esternalizzati contro 50 dipendenti pubblici; Milano: Biblioteca Braidense ridotta da 145 a 33 dipendenti in 15 anni; Biblioteche statali: personale ridotto da 779 a circa 310 bibliotecari.
Scene 31 (1h 45m 35s)
[Audio] Applicazione del CCNL Federculture Riconoscimento delle competenze professionali Percorsi di stabilizzazione per i precari Investimenti nella formazione continua del personale.50 La Digitalizzazione del sistema delle biblioteche italiane. La digitalizzazione del sistema bibliotecario italiano rappresenta uno dei processi di trasformazione più significativi e complessi del panorama culturale nazionale. Questo processo, accelerato dall'emergenza pandemica e sostenuto da importanti investimenti pubblici, sta ridefinendo il ruolo delle biblioteche nella società contemporanea, trasformandole da custodi statici del sapere in centri dinamici di innovazione culturale e sociale. L'Italia ha costruito nel tempo un'infrastruttura bibliotecaria digitale articolata e complessa, fondata su tre pilastri fondamentali. Il "Servizio Bibliotecario Nazionale" (SBN) costituisce la spina dorsale del sistema, coordinato dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU).51 Questa rete, operativa dal 1992, connette migliaia di biblioteche attraverso un catalogo collettivo che contiene descrizioni bibliografiche di materiali antichi, moderni, musicali, grafici e audiovisivi.52 Il portale "Internet Culturale" rappresenta il secondo elemento chiave, fungendo da aggregatore di repository digitali sparsi sul territorio nazionale.53 Questo sistema consente l'accesso unificato alle collezioni digitali di biblioteche di diversa provenienza, dal Ministero della Cultura agli enti locali, dalle università alle fondazioni private. La piattaforma gestisce oltre 21 milioni di immagini appartenenti alle collezioni più importanti delle biblioteche italiane.54 Il terzo pilastro è costituito dalla "Biblioteca Digitale Italiana" (BDI), istituita per coordinare e promuovere i programmi di digitalizzazione a livello nazionale. Questo progetto ha finanziato dal 2001 al 2004 quaranta progetti di digitalizzazione per un totale di oltre 5 milioni di euro, creando le basi per l'attuale ecosistema digitale.55 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha rappresentato un punto di svolta decisivo per la digitalizzazione delle biblioteche italiane. L'investimento M1C3 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" prevede un finanziamento di 500 milioni di euro suddivisi in 12 sub-investimenti.56 50 Marco Dalla Valle, "Emergenza Cultura, "La Biblioterapia nella biblioteca per il benessere in un'ottica di biblioteeconomia critica" in Biblioteche oggi Trends, vol. 9, n. 2 (dicembre 2023) p. 52 51La Redazione, Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) per le biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche. 52 La Redazione, "Cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche italiane. Biblioteca digitale italiana" in IC Internet culturale.it 53 Internet culturale in Wikipedia. 54 La Redazione, Biblioteca digitale.it 55"La Redazione, I Progetti di digitalizzazione della biblioteca digitale italiana" in DigitItalia.it 56La Redazione, M1 C3 Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" Ministero della Cultura, PNRR Cultura.it.
Scene 32 (1h 49m 42s)
[Audio] La Digital Library, istituita nel 2020 all'interno del Ministero della Cultura, è stata individuata come struttura attuatrice principale. L'istituto ha elaborato il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) per il quinquennio 2022-2026, che costituisce la visione strategica per la trasformazione digitale del settore.57 Il piano si articola in quattro ambiti di servizio principali: Servizi abilitanti: sviluppo di un'infrastruttura nazionale per la gestione delle risorse digitali Servizi di produzione: digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e musei Servizi di conservazione: sistemi per la gestione e conservazione a lungo termine Servizi di accesso: piattaforme integrate per l'accesso al patrimonio digitale L'implementazione del PNRR a livello regionale mostra una distribuzione significativa di risorse e progetti. La Regione Toscana ha ricevuto 4,5 milioni di euro per digitalizzare oltre un milione di oggetti digitali coinvolgendo 24 istituti culturali distribuiti in 19 comuni. L'Emilia-Romagna ha destinato oltre 2,5 milioni di euro per la digitalizzazione di periodici storici conservati in biblioteche e archivi regionali. Questi progetti regionali evidenziano l'importanza della cooperazione territoriale e della valorizzazione delle specificità locali. Le biblioteche coinvolte spaziano dalle grandi istituzioni statali alle piccole biblioteche comunali, creando una rete capillare di digitalizzazione che preserva e valorizza il patrimonio distribuito sul territorio.58 La pandemia ha rappresentato un acceleratore involontario del processo di digitalizzazione. Le biblioteche italiane, chiuse al pubblico dal marzo 2020, hanno dovuto rapidamente convertire i servizi in modalità digitale. Durante il lockdown, le biblioteche hanno potenziato i servizi digitali già esistenti e ne hanno sviluppati di nuovi. Le piattaforme di prestito digitale come MLOL (Medialibrary Online) hanno registrato un incremento significativo dell'utilizzo. Molte biblioteche hanno organizzato eventi online, corsi di alfabetizzazione digitale e servizi di reference da remoto. Questa esperienza ha dimostrato la resilienza delle biblioteche e la loro capacità di adattamento. Come documentato da uno studio del CNR, l'80% delle biblioteche è riuscito ad adattarsi alle nuove condizioni con difficoltà medio-basse, registrando spesso un aumento della consapevolezza della presenza bibliotecaria da parte degli utenti.59 Le biblioteche italiane stanno esplorando l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale per migliorare i servizi e ottimizzare i processi. Un'indagine condotta nel 2024 ha rilevato che il 78% dei bibliotecari italiani è interessato a sviluppare competenze in alfabetizzazione sull'IA. 57La Redazione, MIC Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Digital Library in Scuola Nazionale Patrimonio Attività culturali. 58La Redazione, "Digitalizzazione del patrimonio culturale" in Regione Emilia Romagna.it 59La Redazione, "Le biblioteche italiane durante la pandemia Covid: una indagine sui servizi" 19 Istituto di scienza e Tecnologia dell'informazione "A Faedo" Consiglio Nazionale delle Ricerche ISTI TR 2020/012..
Scene 33 (1h 53m 37s)
[Audio] Il processo di digitalizzazione presenta significative sfide tecniche e organizzative. La frammentazione dei sistemi informativi, la mancanza di standard comuni e le limitazioni normative sul deposito legale delle risorse digitali rappresentano ostacoli importanti. La cybersecurity emerge come una preoccupazione crescente. Le biblioteche digitali devono affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate, richiedendo investimenti in sicurezza e formazione del personale specializzato. Un'altra sfida significativa riguarda la qualità dei metadati. Molti repository presentano problemi di completezza e coerenza nelle descrizioni bibliografiche, limitando l'efficacia dei sistemi di ricerca e discovery. L'analisi condotta sull'aggregatore "CulturaItalia" ha evidenziato lacune nella metadata completeness che richiedono interventi strutturali.60 La trasformazione digitale richiede un aggiornamento significativo delle competenze professionali. L'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) ha lanciato il progetto "Le Biblioteche per il welfare digitale e informativo" per sostenere l'alfabetizzazione digitale sia dei bibliotecari che dei cittadini. I bibliotecari devono acquisire competenze in digital library management, data management, web semantico e, sempre più, nell'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale. La formazione continua diventa essenziale per mantenere il passo con l'evoluzione tecnologica e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti digitali. Il futuro delle biblioteche italiane si delinea sempre più ibrido e integrato. La convergenza MAB (Musei, Archivi, Biblioteche) sta emergendo come paradigma dominante, con progetti come Digital MAB che promuovono l'integrazione delle collezioni culturali attraverso la digitalizzazione. Nuovi progetti bibliotecari emblematici, come la BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) di Milano, prevista per il 2026, incarnano la visione futura delle biblioteche come spazi polifunzionali dove la tecnologia digitale si integra con la dimensione fisica e sociale. Questi spazi non saranno più solo luoghi di conservazione, ma centri di produzione culturale, innovazione e partecipazione comunitaria. Il sistema delle biblioteche italiane sta vivendo una trasformazione epocale che va oltre la semplice digitalizzazione dei contenuti. Si tratta di un processo di ridefinizione dell'identità bibliotecaria che abbraccia nuovi modelli di servizio, nuove competenze professionali e nuove forme di interazione con le comunità di riferimento. Questa evoluzione, sostenuta da significativi investimenti pubblici e accelerata dall'esperienza pandemica, sta posizionando l'Italia come protagonista nel panorama internazionale dell'innovazione bibliotecaria digitale. La sfida principale per i prossimi anni sarà mantenere l'equilibrio tra innovazione tecnologica e missione sociale delle biblioteche, garantendo che la digitalizzazione non sia fine a se stessa ma strumento per una maggiore accessibilità, inclusione e partecipazione culturale. In questo contesto, il ruolo del bibliotecario si evolve da mediatore dell'informazione a 60La Redazione "I requisiti per l'addestramento degli strumenti di AI ed il deposito legale delle risorse digitali: una riflessione sul contesto normativo italiano ed il ruolo delle biblioteche" in DigitItalia.it V.19 N.1 (2024)..
Scene 34 (1h 57m 38s)
[Audio] facilitatore della trasformazione digitale, richiedendo nuove competenze e una visione strategica del proprio ruolo nella società dell'informazione.61 I nuovi lavori nel sistema bibliotecario italiano. Figure professionali bibliotecarie in estrema difficoltà rispetto alle nuove tecnologie. La trasformazione digitale delle biblioteche italiane sta creando gravi difficoltà per diverse figure professionali tradizionali, minacciate dall'automazione, dall'intelligenza artificiale e dai profondi cambiamenti organizzativi in corso. Questi professionisti si trovano in una situazione particolarmente critica, caratterizzata dalla riduzione degli organici, dall'esternalizzazione dei servizi e dalla necessità di acquisire rapidamente nuove competenze tecnologiche. I catalogatori tradizionali rappresentano la categoria più direttamente minacciata dall'automazione. L'evoluzione dai cataloghi cartacei ai sistemi digitali e l'introduzione di tecnologie di catalogazione automatizzata stanno riducendo drasticamente la necessità di catalogazione manuale.62 L'automazione della catalogazione ha comportato una progressiva riduzione del lavoro duplicato attraverso l'adesione a reti bibliotecarie e la catalogazione partecipata. Il passaggio dai sistemi tradizionali come il formato MARC agli standard più moderni come RDA (Resource Description and Access) ha richiesto competenze che molti catalogatori anziani faticano ad acquisire. L'intelligenza artificiale sta inoltre iniziando a automatizzare processi di catalogazione che una volta richiedevano l'intervento umano qualificato. Gli algoritmi di machine learning possono ora analizzare automaticamente i contenuti, estrarre metadati e classificare documenti con crescente precisione. Naturalmente, come evidenziato dagli esperti, "il ruolo umano resta fondamentale" e "l'IA non sostituisce il bibliotecario o il catalogatore, ma ne amplifica le capacità", tuttavia molti catalogatori tradizionali si trovano impreparati di fronte a questi cambiamenti.63 Addetti al Prestito Tradizionale. Gli Addetti al prestito manuale stanno affrontando una delle trasformazioni più radicali. L'introduzione di sistemi di auto prestito, la gestione automatizzata delle prenotazioni e i servizi digitali stanno riducendo significativamente la necessità di operatori umani per le attività di routine del prestito. La Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ad esempio, ha implementato tre postazioni di auto prestito che permettono agli utenti di "svolgere in autonomia le principali operazioni del banco prestito". Quando i sistemi automatizzati non sono disponibili, la biblioteca deve attivare "procedure d'emergenza per la registrazione manuale del prestito", limitando significativamente le operazioni. Il servizio di prestito interbibliotecario sta inoltre diventando sempre più automatizzato attraverso protocolli standard come l'ISO ILL, che "è stato appositamente definito per gestire in modo automatizzato l'intero ciclo di vita di un prestito 61 La Redazione, "Biblioteche digitali e trasformazione digitale della PA" in DigitItalia.it V.16 N.1 (2021). 62 Giulio Bonanome, "Un ILS open source per l'automazione delle biblioteche. L'ipotesi Koha a Ca' Foscari". Università Ca' Foscari. Dipartimento Lettere e filosofia-Corso di Laurea specialistica in informatica per discipline umanistiche Anno accademico 2008-2009. 63 La Redazione "Leggere, oltre la tradizione come l'IA trasforma selezione catalogazione e raccomandazione libraria" in Leggere.it 28 maggio 2025..
Scene 35 (2h 1m 49s)
[Audio] interbibliotecario". Questo sviluppo sta riducendo la necessità di intervento umano in molte fasi del processo.64 Bibliotecari anziani con difficoltà digitali. I bibliotecari senior rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile. Le difficoltà degli anziani con la tecnologia sono ben documentate: "la diminuzione delle capacità cognitive e sensoriali legate all'invecchiamento può rendere difficile per gli anziani apprendere e utilizzare nuove tecnologie". Molti bibliotecari anziani si trovano in difficoltà nell'affrontare la complessità tecnologica moderna. "La mancanza di familiarità con i concetti tecnologici e la paura di fare errori possono causare frustrazione e resistenza all'apprendimento". Questo problema è amplificato dal fatto che "gli anziani che ricorrono maggiormente ad internet ed agli strumenti digitali hanno imparato per la maggior parte sul posto di lavoro", ma molti bibliotecari hanno iniziato a lavorare quando le tecnologie digitali non erano ancora diffuse.65 Personale non qualificato delle biblioteche piccole. Le biblioteche di piccoli comuni stanno affrontando una crisi particolare. Come riportano i dati ISTAT, "un terzo dei Comuni italiani non ha una biblioteca" e "le aree più sprovviste sono quelle interne". In molti casi, queste biblioteche sono gestite da personale non bibliotecario che ora si trova in estrema difficoltà nell'affrontare la digitalizzazione. La situazione è aggravata dalla riduzione degli organici. La Biblioteca Nazionale di Torino, ad esempio, "sette anni fa aveva quasi ottanta bibliotecari in servizio, ora ci sono 41 dipendenti". Questa riduzione ha comportato la necessità di tagliare i servizi: "i servizi di prestito e consultazione sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30, mentre prima erano garantiti dalle 8 alle 19". Figure professionali minacciate dall'esternalizzazione L'outsourcing dei servizi bibliotecari sta creando precarietà per molte figure professionali tradizionali. Le difficoltà finanziarie portano gli enti "a privilegiare la via dell'esternalizzazione dei servizi come scorciatoia per ridurre i costi". Il caso di Roberta, che "lavorava in una storica biblioteca di Venezia" è emblematico: "dopo l'ultimo appalto, vinto al massimo ribasso, la nuova Fondazione subentrata ha deciso di sostituire tutti i lavoratori meno qualificati con i volontari". Questa dinamica sta creando una sostituzione sistematica del personale qualificato con volontari o personale meno specializzato. L'esternalizzazione comporta anche la perdita di controllo sulla qualità professionale. Come evidenziato dall'AIB, "con l'esternalizzazione gli enti, da soggetti direttamente gestori ed erogatori di servizi diventano soggetti regolatori di servizi gestiti da terzi", spesso con una riduzione della qualità professionale.66 Bibliotecari specializzati in funzioni obsolete. Alcune specializzazioni tradizionali stanno diventando rapidamente obsolete. I bibliotecari specializzati nella gestione di collezioni cartacee si trovano in difficoltà quando le biblioteche transitano verso modelli "bookless" o prevalentemente digitali. La gestione tradizionale delle riviste cartacee e degli abbonamenti fisici sta diventando marginale con la prevalenza delle risorse elettroniche. Molti bibliotecari che si erano specializzati in questi settori ora devono reinventare completamente le proprie competenze. Anche i bibliotecari del reference tradizionale stanno affrontando difficoltà significative. L'avvento di Google, Wikipedia e altre risorse digitali ha cambiato radicalmente 64 Alessandra Citti e Marina Zuccoli, "Bibliotecari del futuro: cambiamento di servizi e di ruoli 1 in Biblioteche Oggi.it gennaio/febbraio 2028. 65 La Redazione, "La difficoltà degli anziani on la tecnologia" Diadema.it del 13 maggio 2024. 66 La Redazione, "Biblioteche e bibliotecari nel XXI secolo" in AIB.it dell'8 giugno 2012..
Scene 36 (2h 6m 25s)
[Audio] le modalità di ricerca degli utenti, rendendo meno rilevanti molte competenze di reference tradizionale.67 Impatto dei tagli di budget. La crisi economica ha aggravato significativamente la situazione. L'ICCU (Istituto centrale per il catalogo unico) è "più che dimezzato come personale, siamo passati da 90 del 2006 a 43 oggi". Questi tagli hanno comportato "un taglio di fondi che ci ha ridotto dai 2,3 milioni del 2007 a 1,3 milioni di oggi". Le biblioteche nazionali stanno subendo tagli drammatici: alla Biblioteca Nazionale di Roma "avevamo 398 dipendenti, siamo oggi a 210" con "un taglio ai finanziamenti del 70%: siamo passati da 3 milioni e 98 mila euro del 2003 a 1 milione e 250 mila di oggi". Questi tagli stanno costringendo molte biblioteche a ridurre drasticamente i servizi. La Biblioteca nazionale universitaria di Torino ha dovuto "ridurre i suoi orari" e "cancellare l'apertura del sabato mattina" a causa della "grave carenza di personale" Rischio di sostituzione con l'automazione. L'Intelligenza Artificiale sta accelerando il processo di automazione di molte funzioni bibliotecarie. Come evidenziato negli studi sui settori a rischio automazione, le professioni caratterizzate da attività prevedibili e routinarie sono maggiormente esposte. Nel settore bibliotecario, questo include attività come la catalogazione di base, la gestione degli inventari, le operazioni di prestito standardizzate, e molte funzioni di back-office. L'AI sta iniziando a svolgere attività complesse che un tempo erano appannaggio esclusivo degli esseri umani. Difficoltà di adattamento e formazione. Molti bibliotecari in difficoltà lamentano l'eccessiva specializzazione dei saperi: i percorsi accademici e quelli abilitanti alla professione continuano a concentrarsi molto sulla catalogazione e sulla gestione delle collezioni, trascurando altri aspetti ormai indispensabili. Il moltiplicarsi repentino delle mansioni da svolgere rischia di snaturare un ruolo professionale del quale non si colgono più i contorni. Molti bibliotecari si trovano disorientati di fronte a richieste che vanno ben oltre la loro formazione tradizionale. La situazione è aggravata dalla presenza di decisori che hanno in mente un modello di biblioteca di tipo tradizionale ma che allo stesso tempo richiedono l'adozione di tecnologie avanzate senza fornire la formazione e le risorse necessarie. Conseguenze per il sistema bibliotecario. Questa crisi delle figure professionali tradizionali sta creando un divario generazionale e professionale preoccupante. Da un lato emergono nuove figure altamente specializzate (Digital Librarian, Data Librarian, ecc.), dall'altro molti professionisti tradizionali rischiano l'emarginazione o la sostituzione. Il rischio è quello di una perdita di competenze consolidate e di memoria istituzionale, mentre il sistema bibliotecario italiano fatica a garantire percorsi di riconversione professionale adeguati per chi si trova in difficoltà. Senza interventi formativi mirati e investimenti in aggiornamento professionale, molte di queste figure rischiano di diventare strutturalmente obsolete nei prossimi anni. Evoluzione del profilo del bibliotecario in Italia: nuove competenze per una professione in trasformazione. 67 Nerio Agostini, "La gestione delle risorse umane nelle biblioteche pubbliche" in Biblioteche Oggi.it del settembre 2006..
Scene 37 (2h 10m 16s)
[Audio] Il profilo del bibliotecario italiano sta attraversando una profonda trasformazione che richiede un ripensamento sostanziale delle competenze tradizionali e l'acquisizione di nuove abilità per rispondere alle sfide del XXI secolo. Le tendenze di cambiamento. La professione bibliotecaria italiana è influenzata da diversi fattori di cambiamento. La rapida digitalizzazione sta modificando radicalmente il modo in cui le persone fruiscono di cultura, intrattenimento e contenuti formativi,68 mettendo sotto pressione sia il libro tradizionale che la lettura stessa.69 Le biblioteche pubbliche si stanno evolvendo da semplici collezioni di libri a centri democratici, informativi e comunitari, mentre quelle accademiche devono adattarsi ai cambiamenti nella ricerca, comunicazione e apprendimento.70 Nuove competenze e ruoli emergenti. L'Associazione Italiana Biblioteche ha identificato 12 profili professionali che riflettono la diversificazione della professione. Oltre al profilo base del bibliotecario, emergono specializzazioni verticali (Direttore di biblioteca, Coordinatore di sistema) e orizzontali che includono figure come il bibliotecario dei servizi digitali, il bibliotecario di reference, e il bibliotecario per bambini e ragazzi.71 Le competenze richieste per il futuro includono: ruoli più estroversi nell'accoglienza e nell'interazione con gli utenti: competenze digitali avanzate per navigare un mondo sempre più tecnologico; abilità di marketing e creazione di contenuti per social media; capacità di coordinamento eventi e promozione della lettura; competenze nell'uso etico delle nuove tecnologie, inclusa l'Intelligenza Artificiale. L'Impatto dell'Intelligenza Artificiale. Una sfida cruciale emerge dall'avvento dell'Intelligenza Artificiale Generativa. I bibliotecari devono ridefinire il loro valore aggiunto in un contesto dove ChatGPT può fornire riassunti di libri e consigli di lettura. La chiave sta nel trovare l'aspetto umano esclusivo che solo un bibliotecario può apportare, traducendo le competenze tradizionali sia in ambito fisico che digitale.72 Strategie per il futuro. L'Associazione Italiana Biblioteche ha delineato cinque aree strategiche per il periodo 2023-2026: advocacy per bibliotecari e biblioteche; una comunità di valori condivisi; politica dell'informazione di qualità per tutti e politiche della lettura; sviluppo professionale e leadership; equità, differenze, inclusione e coesione sociale. 68 La rapida digitalizzazione rappresenta il principale driver di trasformazione nel settore bibliotecario italiano. Secondo i dati del Report MLOL 2024, le transazioni digitali nelle biblioteche italiane sono cresciute del 6,3%, passando dalle 18.479.726 transazioni del 2023 alle 19.642.544 del 2024. Questo fenomeno non si limita alla semplice acquisizione di risorse digitali, ma sta ridefinendo radicalmente le modalità di fruizione culturale 69 La digitalizzazione sta effettivamente mettendo sotto pressione sia il libro tradizionale che la lettura stessa. Secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori (AIE), nel 2023 il mercato degli e-book ha rappresentato circa il 12,0% delle vendite totali di libri in Italia, con una crescita del 7,0% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i libri cartacei mantengono ancora la predominanza con il 78,0% delle vendite totali 70 Fabio Mercanti, "Nuovi bibliotecari per biblioteche che cambiano" in Biblioteche oggi Trends.it N.1/2024 71 Il riferimento è a: Rachele Arena e Ilario Ruocco (Osservatorio Lavoro e professione AIB), "Lavorare in biblioteca nell'Italia di oggi: una prima ricognizione quantitativa e qualitativa", relazione tenuta durante il 58° Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche "Quale lavoro in biblioteca? Riconoscimento professionale e valorizzazione della professione bibliotecaria", Roma, Università Roma Tre, 28-29 novembre 2013, Terza sessione "Lavorare in biblioteca, fra vecchie storie e nuove sfide" (29 novembre 2013). 72 Fabio Mercanti, "Nuovi bibliotecari per biblioteche che cambiano" in Biblioteche oggi Trends.it N.1/2024.
Scene 38 (2h 15m 15s)
[Audio] Collaborazione interdisciplinare. Il futuro della professione richiede una maggiore collaborazione con altre professioni e specializzazioni. Le biblioteche stanno integrando figure professionali diverse, offrendo ai bibliotecari tradizionali due alternative: acquisire tutte le nuove competenze richieste o specializzarsi e prepararsi a lavorare a fianco di altri professionisti.73 Formazione e sviluppo professionale. La formazione continua diventa essenziale per rispondere ai mutevoli bisogni degli utenti. I professionisti devono sviluppare competenze che spaziano dal marketing bibliotecario alla gestione dei servizi digitali, mantenendo sempre al centro i valori fondamentali della professione.74 La professione bibliotecaria richiede competenze multidisciplinari integrate. Secondo una ricerca dell'Università di Milano-Bicocca, i temi formativi più utili per i bibliotecari includono: comunicazione sui social media, software di presentazione e produzione documenti, strumenti di grafica e manipolazione immagini, gestione di sistemi informatici per catalogazione.75 Il ruolo sociale delle biblioteche. Le biblioteche del futuro si configurano come spazi di socializzazione aperti a tutti, luoghi della "bibliodiversità" dove l'apprendimento avviene attraverso il confronto. Le biblioteche pubbliche stanno infatti effettivamente attraversando una trasformazione da semplici collezioni di libri a centri democratici, informativi e comunitari. Secondo il Manifesto IFLA/UNESCO, la biblioteca pubblica è definita come "porta d'accesso locale alla conoscenza" che crea i presupposti per l'apprendimento permanente e lo sviluppo culturale della comunità. In Italia, le biblioteche stanno assumendo sempre più il ruolo di "laboratori sociali". Le biblioteche stanno diventando infrastrutture di coesione sociale che rispondono alla frammentazione della società contemporanea. Come luoghi neutri e plurali, offrono spazi di accoglienza senza condizionamenti, integrando diverse fasce della popolazione e promuovendo l'inclusione sociale. Iniziative come i "laboratori bibliosociali" e le "biblioteche di condominio" dimostrano come questi spazi stiano evolvendo verso una funzione di "incubatori socio-culturali" che creano connessioni dinamiche tra promozione della lettura e risposta ai cambiamenti sociali. Quindi siamo di fronte ad una trasformazione sistemica che va oltre la semplice digitalizzazione tecnologica, investendo il ruolo sociale, culturale e professionale delle biblioteche italiane nel XXI secolo.76 Questo richiede ai bibliotecari di sviluppare competenze relazionali e di mediazione culturale sempre più raffinate La trasformazione del profilo del bibliotecario italiano richiede quindi un approccio dinamico e flessibile, che combini la salvaguardia dei valori tradizionali della professione con l'acquisizione di competenze innovative, per continuare a servire efficacemente la comunità in un mondo in rapida evoluzione.77 Nuove figure professionali nelle biblioteche italiane. La trasformazione digitale e l'evoluzione tecnologica stanno ridefinendo profondamente il panorama professionale delle biblioteche italiane, portando all'emergere di nuove figure specializzate che affiancano i ruoli tradizionali del bibliotecario. Queste nuove professionalità nascono 73 Fabio Mercanti, "Nuovi bibliotecari per biblioteche che cambiano" in Biblioteche oggi Trends.it N.1/2024 74 Adriano Solidoro, Ilenia Buia, Camelia-Irina Caldarusa, "Quale futuro. Il fabbisogno formativo dei bibliotecari?", Indagine sugli addetti delle biblioteche pubbliche. In Biblioteche oggi.it marzo 2020. 75 La Redazione, "quali competenze per i bibliotecari" in ICCU.it del 12 gennaio 2024. 76 Alessandra Motta, "Le biblioteche pubbliche per il contrasto all'esclusione sociale" in Percorsi di Secondo welfare.it del 12 gennaio 2024. 77 Alberto Petrucciani, "Nascita e affermazione della professione bibliotecaria 1861-1969)" in AIB.it del 23 settembre 2002..
Scene 39 (2h 19m 56s)
[Audio] dalla necessità di gestire sistemi informatici complessi, risorse digitali, e servizi innovativi che richiedono competenze interdisciplinari specifiche.78 Ecco dunque alcune di queste figure. Data Librarian - Il Bibliotecario dei Dati. Rappresenta una delle figure professionali più rilevanti nelle biblioteche accademiche italiane. Questa figura si è evoluta dalla crescente importanza della gestione dei dati della ricerca e del Research Data Management (RDM). Il Data Librarian si occupa di supportare i ricercatori nella pianificazione, gestione, conservazione e condivisione dei dati di ricerca, utilizzando principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Le competenze specifiche includono la gestione dell'informazione con focus su memorizzazione nei depositi istituzionali, catalogazione specializzata, e servizi di supporto come la redazione di Data Management Plan. In Italia, questa figura è ancora in fase di sviluppo, con alcuni atenei come l'Università di Milano e l'Università di Padova che hanno iniziato a implementare servizi specializzati per la gestione dei dati della ricerca.79 Digital Librarian - Il Bibliotecario Digitale. E' chiamato a gestire la complessità del mondo digitale attraverso competenze tecnologiche sempre più specialistiche. Secondo il Master internazionale DILL (Digital Library Learning), le competenze del bibliotecario digitale si articolano in tre aree interdipendenti: competenze tecnologiche (System), competenze di metodologia della ricerca (User), e competenze biblioteconomiche tradizionali (Knowledge organization) Le competenze richieste includono programmazione di base, gestione di Semantic Web, Big Data, Data Curation, creazione di ontologie, Cloud computing per biblioteche digitali, e sviluppo di applicazioni mobile. Il bibliotecario digitale deve anche essere capace di gestire discovery tools, sistemi di gestione delle risorse elettroniche, e piattaforme digitali integrate.80 Electronic Resources Librarian - Specialista delle Risorse Elettroniche. Questa figura si è evoluta direttamente dal bibliotecario addetto allo sviluppo delle collezioni per rispondere alla centralità assunta dalle risorse elettroniche. L'Electronic Resources Librarian gestisce l'intero ciclo di vita delle risorse digitali, dalle negoziazioni con i fornitori alla gestione tecnica attraverso sistemi ERM (Electronic Resource Management) e piattaforme URM (Unified Resource Management). Le competenze includono la gestione di contratti digitali, l'integrazione con discovery services, la valutazione delle risorse elettroniche attraverso analytics e metriche d'uso, e la knowledge del complesso panorama editoriale digitale.81 Metadata Librarian - Esperto in Metadatazione. Rappresenta un'evoluzione diretta del catalogatore tradizionale. Questa figura gestisce schemi di metadati complessi, profili di applicazione, e standard diversi dal tradizionale formato MARC, includendo Dublin Core, MODS, BIBFRAME, e linked data. Le competenze spaziano dalla catalogazione semantica alla gestione di authority files condivisi, dalla creazione di mapping tra standard diversi alla gestione di sistemi di identifiers persistenti come DOI e ORCID. In Italia, molte università 78 Anna Maria Tammaro, "Breve storia dell'automazione" in Biblioteche oggi.it luglio agosto 2014. 79 Maria Cassella, "Dal Digital curator al Data Librarian" in Biblioteche oggi N.3/2016 Aprile 2016. 80 Anna Maria Marras, "Storytelling e Digital Library" in Biblioteca oggi N.2/2023 Marzo 2023. 81 Maria Cassella, "Le professioni per le biblioteche accademiche di ricerca" Quaderno sui profili professionali in AIB studi, Doi 10.2426/aibstudi-8876, vol. 53 n. 1 (gennaio/aprile 2013), p. 63-100..
Scene 40 (2h 24m 56s)
[Audio] stanno implementando questi profili per gestire i repository istituzionali e l'integrazione con il sistema nazionale SBN.82 Discovery Services Librarian - Specialista dei Servizi di Ricerca. Personalizza e mantiene gli strumenti di discovery, ovvero le interfacce di ricerca unificata che permettono agli utenti di interrogare contemporaneamente diverse banche dati e collezioni. Questa figura richiede competenze tecniche nella configurazione di discovery tools come EBSCO Discovery Service, Primo VE, o altre piattaforme. Le responsabilità includono la personalizzazione dell'interfaccia utente, la gestione dell'indicizzazione delle risorse, l'ottimizzazione dei risultati di ricerca, e l'integrazione con i sistemi di back-office.83 Repository Manager - Gestore degli Archivi Istituzionali. amministra gli archivi istituzionali ad accesso aperto, strumenti fondamentali per la disseminazione della ricerca scientifica. Questa figura combina competenze biblioteconomiche, tecniche e comunicative per gestire piattaforme come DSpace, EPrints, o Fedora. Le competenze includono la gestione di metadati per l'interoperabilità, la knowledge delle politiche di Open Access, la gestione dei diritti d'autore in ambiente digitale, e le competenze di advocacy per promuovere l'autoarchiviazione. In Italia, il 65% circa delle istituzioni accademiche ha implementato repository istituzionali.84 Copyright Librarian - Esperto in Diritto d'Autore Digitale. Questa figura emergente si occupa delle complesse questioni di diritto d'autore in ambiente digitale. Il Copyright Librarian fornisce consulenza sull'utilizzo e riutilizzo dei contenuti digitali, gestisce le questioni legali nei progetti di digitalizzazione, e supporta la pubblicazione di riviste e monografie online. Le competenze includono la knowledge approfondita della normativa italiana ed europea sul diritto d'autore, la gestione di licenze Creative Commons, la consulenza sui contratti editoriali, e la gestione dei diritti nei repository istituzionali.85 Information Literacy Specialist - Specialista dell'alfabetizzazione informativa. Progetta e gestisce programmi formativi per sviluppare le competenze informative degli utenti. Questa figura è particolarmente importante nelle biblioteche universitarie per supportare studenti, docenti e ricercatori nell'uso efficace delle risorse informative. Le competenze includono progettazione didattica, conoscenza degli standard internazionali di Information Literacy, valutazione dell'apprendimento, e capacità di adattamento a diversi contesti e tipologie di utenti.86 Systems Librarian - Bibliotecario di Sistema. Rappresenta la figura chiave per la gestione dell'automazione bibliotecaria. In grandi sistemi bibliotecari, coordina le attività tecniche, gestisce i rapporti con i fornitori di software, e supervisiona l'integrazione tra diversi sistemi informativi. Le competenze richieste includono conoscenze di sistemi operativi, 82 Gill Ringland, Scenario Planning. Managing for the future, Chichester: Wiley & Sons, 1998. 83 https://liberquarterly.eu/article/download/10626/11401 84 La Redazione,"Linee guida per la creazione e gestione di metadati nei repository istituzionali" in CRUI 22 febbraio 2012 85 Anna Maria Tammaro e Antonella Zane, "Ruolo e opportunità del bibliotecario dei dati per la Scienza aperta" in Biblioteche oggi N.6/ 2021 86 Arianna Terzi, "Sentire digitale: quali competenze per i bibliotecari?" in AIB del 28 febbraio 2024..
Scene 41 (2h 29m 2s)
[Audio] programmazione, networking, gestione di database, e capacità di project management per progetti di automazione complessi. Nuove Figure Emergenti. AI Librarian: con l'avanzare dell'intelligenza artificiale nelle biblioteche, sta emergendo la figura del bibliotecario specializzato in IA. Questa figura si occupa di implementare strumenti di AI per migliorare i servizi bibliotecari, gestire chatbot per l'assistenza agli utenti, e valutare l'impatto delle tecnologie AI sui servizi tradizionali. User Experience (UX) Librarian: specializzato nell'analisi e miglioramento dell'esperienza utente, questa figura applica metodologie UX alla progettazione di servizi bibliotecari, tanto fisici quanto digitali, per ottimizzare l'interazione tra utenti e biblioteca. Learning Analytics Specialist: nelle biblioteche accademiche, questa figura utilizza tecniche di learning analytics per analizzare i comportamenti di studio degli utenti e ottimizzare i servizi di supporto all'apprendimento.87 La ricerca AIB 2024-2025 sul mercato del lavoro delle professioni bibliotecarie evidenzia come queste trasformazioni continueranno ad accelerare nei prossimi 7-10 anni. L'evoluzione richiederà investimenti significativi nella formazione continua del personale esistente e nella creazione di nuovi percorsi formativi specialistici. Le nuove figure professionali non sostituiscono completamente i ruoli tradizionali, ma li affiancano e li integrano, creando un ecosistema professionale più articolato e specializzato che risponde alle crescenti esigenze di digitalizzazione e innovazione tecnologica delle biblioteche moderne. Verso le biblioteche del futuro: più di semplici luoghi di libri Le biblioteche italiane stanno cambiando volto sotto i nostri occhi. Non si tratta più solamente di spazi silenziosi pieni di scaffali di libri, ma di qualcosa di molto più grande e vitale: vere e proprie "piazze del sapere" che stanno reinventando il loro ruolo nella società contemporanea. Dalla casa dei libri alla casa di comunità Immaginate di entrare in una biblioteca moderna: oltre ai tradizionali scaffali troverete spazi per il coworking, laboratori digitali, aree per eventi culturali, angoli dedicati ai bambini con i loro genitori, e magari anche un caffè dove incontrare altre persone. Questa trasformazione sta accadendo in tutta Italia, dalle grandi città ai piccoli centri. La biblioteca del XXI secolo sta diventando quello che gli esperti chiamano un "terzo luogo" - non più solo la casa o l'ufficio, ma uno spazio intermedio dove la comunità si ritrova, si confronta e cresce insieme. È un posto dove "ti senti accolto, protetto, dove ti senti come a casa, a volte meglio che a casa". La rivoluzione digitale che non esclude nessuno 87 Anna Billotta, "La biblioteca del mondo che verrà" in Biblioteche oggi Trends n.2/2020.
Scene 42 (2h 32m 22s)
[Audio] La pandemia ha accelerato una trasformazione che era già in corso: l'integrazione del digitale nella vita quotidiana delle biblioteche. Durante i lockdown del 2020, i prestiti digitali sono raddoppiati e molte biblioteche hanno dovuto reinventarsi online. Ma questa digitalizzazione non ha sostituito l'esperienza fisica - l'ha arricchita. Oggi una biblioteca moderna offre: prestito digitale di libri ed e-book accessibile 24 ore su 24; servizi online per prenotazioni e consultazioni; laboratori di alfabetizzazione digitale per tutte le età; spazi tecnologici con computer, tablet e connessione WiFi gratuita Il bello è che tutto questo non esclude chi non è "digitale": anzi, le biblioteche stanno diventando luoghi privilegiati per accompagnare tutti i cittadini nella transizione digitale, senza lasciare indietro nessuno. Biblioteche come medicina sociale Una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni è che le biblioteche funzionano come una sorta di "medicina sociale". Non è un caso che si parli sempre più spesso di "welfare culturale": le biblioteche aiutano le persone a stare meglio, a sentirsi meno sole, a sviluppare nuove competenze. Pensate a una famiglia immigrata che trova nella biblioteca locale non solo libri nella propria lingua madre, ma anche corsi di italiano, supporto per i compiti dei figli, e soprattutto un luogo accogliente dove sentirsi parte della comunità. O a un anziano che scopre internet per la prima volta grazie ai corsi organizzati dai bibliotecari, riuscendo finalmente a videochiamare i nipoti lontani. I nuovi abitanti delle biblioteche Chi frequenta oggi le biblioteche? Non più solo studenti e ricercatori, ma una varietà incredibile di persone: famiglie con bambini piccoli che partecipano a letture animate e laboratori creativi; giovani genitori che trovano spazi di confronto e condivisione; professionisti che usano le sale per riunioni o lavoro individuale; anziani che partecipano a gruppi di lettura o corsi di ginnastica dolce; persone in cerca di lavoro che accedono gratuitamente a computer e internet; migranti e rifugiati che trovano supporto per l'integrazione Il bibliotecario del futuro: un facilitatore di comunità Anche il ruolo del bibliotecario si sta trasformando radicalmente. Non è più principalmente un custode di libri, ma diventa una figura multifunzionale: Animatore culturale che organizza eventi e laboratori; Mediatore digitale che aiuta i cittadini a navigare nel mondo online; Facilitatore sociale che mette in connessione persone e opportunità; Consulente dell'informazione che aiuta a orientarsi nell'oceano di dati disponibili: Coach dell'apprendimento che supporta percorsi formativi personalizzati Un bibliotecario moderno potrebbe trovarsi a spiegare come funziona un'app a un pensionato al mattino, organizzare un laboratorio di coding per bambini nel pomeriggio, e coordinare un gruppo di lettura per adolescenti la sera..
Scene 43 (2h 35m 34s)
[Audio] Storie di trasformazione dal territorio In Italia ci sono centinaia di esempi concreti di questa trasformazione. A Torino stanno ripensando l'intero sistema bibliotecario della città con il progetto "PIU" (Piano Integrato Urbano), puntando su inclusività e partecipazione cittadina. Nel Mezzogiorno, dodici progetti innovativi stanno trasformando le biblioteche in "luoghi di inclusione sociale" con aperture serali, laboratori artistici e servizi che escono dalle mura bibliotecarie per raggiungere carceri, ospedali e case di riposo. Le "biblioteche di condominio" di Milano portano i libri direttamente nei cortili dei palazzi, mentre i bibliobus raggiungono le zone più isolate del paese, dimostrando che la cultura può essere davvero per tutti e ovunque. Le sfide che ci aspettano Naturalmente, non tutto è semplice. Le biblioteche italiane devono affrontare sfide importanti: carenza di personale qualificato e difficoltà nel formare quello esistente; risorse economiche limitate che costringono a scelte difficili; divario digitale tra Nord e Sud del paese; necessità di aggiornare normative ormai datate; concorrenza con altri spazi di aggregazione e intrattenimento Ma forse la sfida più grande è culturale: convincere cittadini e amministratori che investire nelle biblioteche non è un costo, ma un investimento nel futuro della comunità. Un futuro che è già presente La biblioteca del futuro, in realtà, esiste già in molti luoghi d'Italia. È quel posto dove: una mamma trova sostegno per crescere i suoi bambini in un contesto stimolante; un giovane disoccupato scopre nuove opportunità formative e lavorative; un anziano impara a usare lo smartphone e si sente meno isolato; una comunità locale si ritrova per discutere dei problemi del quartiere; persone di culture diverse si incontrano e costruiscono relazioni. Il cuore pulsante della società Le biblioteche stanno dimostrando di essere molto più che semplici contenitori di cultura: sono incubatori di coesione sociale, laboratori di democrazia partecipativa, presidi di welfare culturale che rendono le nostre comunità più forti, più inclusive e più resilienti. In un'epoca in cui i rapporti umani rischiano di dissolversi nel digitale, le biblioteche offrono qualcosa di prezioso: spazi fisici dove incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme. Non è un caso che molte vengano chiamate "salotti della comunità" - luoghi dove chiunque può entrare, sentirsi benvenuto e trovare quello che cerca, anche quando non sa ancora di cosa ha bisogno. Il futuro delle biblioteche italiane non è scritto nei server o negli algoritmi, ma nei sorrisi delle persone che ogni giorno varcare le loro soglie e trovano, oltre ai libri, una comunità che li accoglie e li fa sentire parte di qualcosa di più grande..